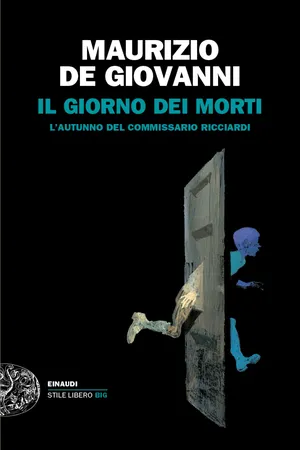Quando l’alba tirò fuori dalla notte e dalla pioggia i contorni delle cose, se qualcuno fosse passato avrebbe visto il cane e il bambino ai piedi dello scalone monumentale che portava a Capodimonte. Ma sarebbe stata necessaria grande attenzione: a stento si distinguevano, nella luce incerta del primo mattino.
Se ne stavano là, fermi, indifferenti alle grosse gocce fredde che cadevano incessanti dal cielo. Erano seduti su uno scalino di pietra, una sorta di panca nella rientranza ornamentale dopo i primi gradini. Le scale erano un torrente in piena che trasportava rami e foglie dal bosco della reggia.
Se qualcuno fosse passato e si fosse fermato a guardare, si sarebbe forse chiesto come mai il flusso dell’acqua e dei detriti che cadeva incessante a valle sembrasse rispettare il cane e il bambino, passando loro accanto senza toccarli se non per qualche schizzo occasionale. La rientranza offriva un po’ di riparo, anche dalla pioggia: solo il pelo sul dorso del cane ogni tanto aveva un fremito, come un brivido di vento.
Qualcuno avrebbe potuto chiedersi che cosa facessero là il cane e il bambino, fermi nella fredda alba di un autunno pieno di pioggia.
Il bambino era grigio, le mani in grembo, i piedi sospesi a pochi centimetri dal suolo, la testa lievemente reclinata, gli occhi persi come dietro un sogno o un pensiero. Il cane sembrava dormire, la testa appoggiata sulle zampe, il mantello a macchie marroni zuppo, un orecchio sollevato, la coda ferma lungo il fianco.
Qualcuno si sarebbe chiesto se stessero aspettando un arrivo, una venuta. O se stessero ripensando a qualcosa che era accaduto, e che aveva lasciato il segno nella memoria. O ancora se stessero ascoltando un suono, una musica lieve.
Ora la pioggia rinforza, uno scroscio potente come una ribellione al sorgere del sole; il cane e il bambino non reagiscono, la furia dell’acqua li lascia indifferenti. Dal naso dell’uno e dall’orecchio sollevato dell’altro scorrono rivoli freddi.
Il cane sta aspettando.
Il bambino non ha piú sogni.
Lunedí, 26 ottobre 1931 - IX
La chiamata arrivò alle sei e mezzo, un’ora prima della fine del turno di notte.
A Ricciardi non dispiaceva rimanere in questura, quando gli toccava: erano per lo piú ore tranquille, da dedicare alla lettura o a un piacevole dormiveglia sul divano della stanza di fianco al suo ufficio. Ed era piuttosto raro che il riposo o le riflessioni fossero disturbati da una guardia che bussava alla porta, richiedendo un intervento.
I delitti accadono di notte, ma vengono scoperti di mattina; l’ora pericolosa era appunto quella, quando la luce del giorno alzava il velo dalle turpitudini del buio.
Ricciardi si era appena lavato all’acquaio in fondo al corridoio, quando vide arrancare il brigadiere Maione lungo la rampa di scale.
– Commissa’, e figuratevi se aspettavano la fine del turno nostro. È arrivata una telefonata, un signore dal Tondo di Capodimonte. Dice che ci sta una lattaia con una capra che piange.
Ricciardi considerò la questione, asciugandosi le mani.
– E adesso ci chiamano pure quando piangono le lattaie? E poi, chi piange, lei o la capra?
Maione allargò le braccia, ancora ansimando per la corsa sulle scale.
– Commissa’, voi scherzate: intanto qua piove a dirotto, e siccome abbiamo un’altra ora per finire, ci tocca arrivare fino a Capodimonte sotto all’acqua. Il fatto è serio, pare che ci sta un bambino morto sullo scalone monumentale. L’ha trovato proprio la donna, che scendeva da una masseria con la capretta per vendere il latte, dice che è la zona sua, e l’ha visto là fermo, l’ha scosso ma quello non si muoveva. Allora ha chiesto aiuto nel palazzo piú vicino, e questo signore che ci ha chiamato era l’unico che teneva il telefono. Mo’ dico io, non poteva succedere tra un paio d’ore, cosí lo scarpinetto sotto alla pioggia se lo faceva Cozzolino che è giovane e solerte, che io appena piglio un po’ di umidità mi viene un dolore alla schiena che devo camminare storto?
Ricciardi aveva già l’impermeabile addosso.
– Insomma, ti stai facendo vecchio veramente. Dài, andiamo a vedere di che si tratta: magari è solo uno scherzo, lo sai che alla gente piacciono i poliziotti che vanno su e giú di corsa sotto la pioggia. Poi vai a casa e ti asciughi.
La strada dalla questura a Capodimonte corrispondeva a quella che faceva Ricciardi per tornare a casa. Un cammino lungo, che a un certo punto cominciava a salire e tagliava il fiato. Bisognava percorrere via Toledo, coi suoi imponenti palazzi nobiliari, attraversare largo della Carità e lo Spirito Santo, fiancheggiare il Museo Nazionale; una linea di confine, a monte e a valle gli impenetrabili vicoli dei Quartieri Spagnoli, del porto e della Sanità, ribollenti di vita e dolore, di allegria e povertà.
Ricciardi ci pensava sempre, ogni mattina e ogni sera, sentendo sulla pelle gli occhi diffidenti di chi aveva da nascondere il modo in cui si procurava da vivere: quella strada diceva tanto, della città. Diceva tutto.
E cambiava sempre, stagione dopo stagione, offrendo una torrida immagine estiva in cui lo sporco macerava sotto il sole; o un profumato quadro primaverile, coi venditori di frutta e fiori che esponevano la merce al passeggio dei ricchi; o un finto deserto invernale, coi loschi affari che si trasferivano nei bassi adiacenti la strada, al riparo dal vento gelido che soffiava senza sosta.
Ora, in quell’autunno umido, la lunga via era attraversata da tanti ruscelli quanti erano i vicoli che la intersecavano, portando verso un mare irraggiungibile rifiuti e sporcizia dalla collina lontana.
Maione saltellava per evitare le pozzanghere piú profonde, nel vano tentativo di preservare gli stivali.
– Mi uccide. Sicuro. Mia moglie mi uccide. Voi non avete idea, commissa’, della belva che diventa quando deve pulire gli stivali dal fango e dallo sporco. Io ci dico: lascia, ché me li pulisco io. E lei: ma non dire sciocchezze, mi dice, io sono la moglie di un brigadiere e gli stivali li devo pulire io. E allora, ci dico, perché fai tutte queste storie? E lei dice: io li pulisco, ma tu ti potresti pure stare un poco piú attento, no?
Camminando, cercava di proteggere sé stesso e il commissario dalla pioggia reggendo un grande ombrello nero. Ricciardi, al solito, non portava cappello né sembrava curarsi del clima. Maione cambiò facilmente argomento.
– Io a voi non vi capisco, commissa’. Non dico l’ombrello, che pure sarebbe il caso dato che piove da tre giorni, però uno si può scocciare di portarselo e va bene; ma almeno un cappello, perché non ve lo mettete? Voi siete giovane, ma credetemi, quando poi avrete l’età mia, ogni singola goccia di pioggia si trasformerà in una fitta alla testa.
Ricciardi procedeva svelto, le mani immerse nelle tasche dell’impermeabile.
– Lo sai, il cappello non lo sopporto: mi fa venire l’emicrania. Io poi sono di montagna, il freddo e l’umido non mi dànno fastidio. Non ti preoccupare; pensa ai dolori tuoi, e a non sporcarti gli stivali.
Erano arrivati nel punto del percorso che a Ricciardi pesava di piú. Si trattava del ponte che i Borboni avevano costruito per arrivare a Palazzo Reale senza dover attraversare la Sanità, da sempre uno dei quartieri piú pericolosi. Per qualche strano e inspiegabile motivo, da allora quell’alto viadotto, quel ponte senza fiume che affondava i propri pilastri nei vicoli sottostanti, era il luogo dei suicidi.
Quello che Ricciardi chiamava tra sé «il Fatto», la sua dolorosa condanna a percepire l’ultimo pensiero dei morti con violenza, diventava nei pressi del ponte un peso insopportabile. C’era sempre almeno un’immagine sospesa, pronta ad alzare lo sguardo al suo passaggio per comunicargli le parole con cui era stata costretta ad abbandonare l’esistenza di carne, ossa e sangue. Un biglietto d’addio con un solo destinatario: lui.
In quella mattina di pioggia, perfettamente visibili agli occhi della sua anima, in bilico sul parapetto distingueva due adolescenti che si tenevano per mano. Il giovane aveva il collo spezzato, e rivolgeva il viso all’indietro come se la testa gli fosse stata montata al contrario; mormorava: Senza te no, senza te mai.
La ragazza aveva il torace schiacciato e la faccia quasi cancellata dall’impatto. Dall’ammasso sanguinolento che era diventato il suo viso, arrivava un pensiero: Non voglio morire, sono giovane, non voglio.
Ricciardi pensò che forse aveva fatto piú vittime l’amore che la guerra. Anzi, senza forse.
Piú in là, sullo stesso parapetto, un vecchio grasso dal cranio sfondato diceva: Non posso restituirveli, non posso. Debiti, rifletté il commissario accelerando il passo e lasciandosi dietro l’affannato Maione. Un’altra malattia inguaribile. Dio, quant’era stanco. Sempre uguale, sempre le stesse cose.
Arrivarono finalmente al Tondo di Capodimonte, da cui partiva lo scalone monumentale. Giunsero con qualche difficoltà, perché l’ultimo tratto della strada era un fiume impetuoso di rami e foglie, da percorrere controcorrente. Maione aveva rinunciato a salvaguardare gli stivali, e aveva assunto un’espressione cupa. Ricciardi aveva in corpo l’immagine dei suicidi ed era ancora piú triste.
Una piccola folla si era radunata ai piedi dello scalone, dopo la prima rampa. La fungaia di ombrelli impediva di vedere cosa ci fosse oltre. L’arrivo di Maione e Ricciardi, accompagnati da due guardie, disperse all’istante l’assembramento. Maione sogghignò:
– Al solito. L’unica cosa piú forte della curiosità è la paura di essere coinvolti in un guaio, appena arriva la polizia.
Ricciardi vide subito il bambino, seduto su una sorta di panca di pietra, sotto il contrafforte di sinistra. Era di bassa statura – i piedi non toccavano terra – e fradicio di pioggia. L’acqua inzuppava i vestiti, scadenti, da scugnizzo. Calzava un paio di zoccoli che non nascondevano i segni dei geloni. Le labbra erano violacee, gli occhi semiaperti nel vuoto.
Rimase impressionato dalle mani, abbandonate in grembo come due uccellini morti. Bianche, molto piú chiare della carnagione delle gambe resa livida dal freddo, sembrarono al commissario un segno di resa e di sfiducia. Attorno, non vide traccia di immagini: il bambino doveva essere morto senza violenza, forse per il freddo o la fame, forse per una malattia. Lasciato solo a sé stesso, pensò: alle intemperie, alla violenza, alla solitudine. Senza poter scegliere.
Se c’era una cosa che odiava erano i bambini morti. La sensazione di spreco, di rinuncia, di occasioni perdute. Un popolo, una civiltà si qualifica dalla cura per la propria infanzia, aveva letto in un libro. Non ne usciva certo bene, quella città.
Maione lo riscosse dai pensieri.
– Prima di lasciare la questura ho disposto di chiamare l’ospedale, sia il medico legale che il carro per la rimozione del corpo, a momenti saranno qua. Là in fondo c’è la lattaia, quella con la capra al guinzaglio, ci volete parlare? Vicino c’è il proprietario del telefono, quel signore con l’ombrello. Gliel’ho detto che non ci serve e che se ne può andare, ma non si muove. Ve li faccio venire qua?
Alla lattaia tremavano le labbra sotto il fazzoletto stretto sulla testa. Era giovane, poco piú che una bambina; con una mano teneva la capra legata a una corda, con l’altra un recipiente di metallo per il latte. A spizzichi e bocconi, balbettando per il freddo, la paura e l’imbarazzo, raccontò che stava scendendo lo scalone per andare a fare il suo giro di vendita del latte, attenta a non cadere, quando la capra aveva fatto uno scarto di lato. C’era un cane, accucciato di fianco all’inizio dell’ultima rampa di gradini, che ringhiava.
– Eccolo là, lo vedete? Si è spostato quando sono tornata da casa del signore, qua, per chiamarvi, e poi non si è mosso piú.
Ricciardi vide, a una ventina di metri di distanza, un cane accucciato sulle zampe posteriori, fermo come una statua, che li osservava attento. Era un bastardino come se ne vedono a decine, il manto bianco sporco chiazzato di marrone, il muso aguzzo e un orecchio sollevato.
La donna riprese raccontando di come, dopo aver cercato di capire se il bambino fosse addormentato o stesse male, era andata di corsa nel palazzo piú vicino, dove aveva chiamato il ragioniere Caputo, suo cliente. L’uomo, un azzimato signore di mezza età, di bassa statura e con le lenti cerchiate d’oro, avanzò di un passo e sollevò il cappello.
– Commissa’, se permettete, io sono il ragioniere Caputo Ferdinando, al vostro servizio. La ragazza, qua, che si chiama Caterina, viene ogni due giorni. Io digerisco solo il latte di capra, que...