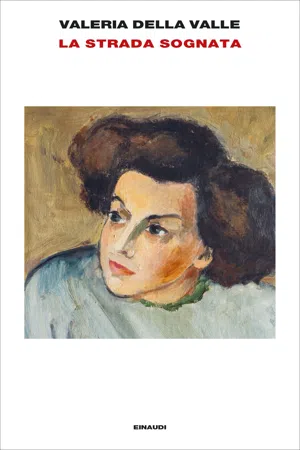La strada l’aveva sognata una notte: era coperta di neve, silenziosa e stretta. Livia non ci aveva pensato piú, ma quando, dopo mesi, c’era capitata all’improvviso, l’aveva riconosciuta. Era proprio la stessa, anche se mancava la neve: i cancelli si aprivano su cortili grandi, con la ghiaia e le panchine di marmo, le statue nelle nicchie, i glicini attorcigliati alle inferriate, le fontane ricoperte di muschio. Quella strada la conoscevano tutti, perché c’erano gli studi degli artisti e le botteghe degli artigiani: si trovava nel centro della città, ma rimaneva appartata e in disparte, come se fosse un’isola. Livia non la conosceva, la strada del sogno, perché nessuno gliene aveva mai parlato: nei suoi pomeriggi solitari, all’uscita dalle lezioni di disegno, aveva cominciato a fare dei giri sempre piú lunghi, ma non era arrivata mai fino a lí. Da quando viveva nella nuova città cercava di orientarsi e camminava per ore, poi si accorgeva che si era fatto tardi, e correva a prendere la circolare, per arrivare in tempo per la cena, alle sette in punto.
La cena, in casa Bencini, era un momento sacro: tutti dovevano essere al loro posto, intorno alla tavola quadrata, sotto al lampadario di vetro che spargeva sulle loro teste una luce debole, da acquario. Luciana arrivava trascinando i piedi, con la zuppiera tra le mani tozze e arrossate: serviva il generale, la moglie del generale, Livia. Il generale non ammetteva ritardi o imprevisti: la cena procedeva, da quando Livia ne aveva memoria, secondo regole fisse e immutabili, che la facevano pensare con fastidio, ogni volta, a una battaglia, con ordini, marce, esecuzioni. Gli ordini erano impartiti dal generale, in tono spazientito: «Avanti con la minestra, quanto si deve aspettare ancora? Arriverà fredda, come al solito», «È andata al macello a prenderla, la carne?», «Che cosa aspetta a sparecchiare, che venga notte?» Le marce erano quelle che Livia seguiva, con disgusto, dai piatti alla bocca del padre e della madre: le posate Krupp ritmavano i gesti, con rumori secchi, metallici. Le esecuzioni riguardavano, agli occhi di Livia, il modo di tagliare la carne, il pesce, la frutta: le incuteva sempre timore e ribrezzo come il padre decapitava, squartava, sventrava, indifferentemente, con gesti precisi e crudeli, cotolette, triglie, albicocche. E la madre aveva, anche lei, un modo brusco e prepotente di strappare il pane, di bere avidamente il bicchiere tutto d’un fiato, con una smorfia, gli occhi chiusi, la testa reclinata all’indietro, il collo pulsante nell’inghiottire.
Livia si era abituata da tempo a piccoli gesti di ribellione, ma era solo lei a conoscerli. Nascondeva pezzetti di pane sotto al bordo del piatto proprio mentre il generale ripeteva, come ogni sera, che il pane era sacro, e che tutti dovevano mangiarlo. Oppure inghiottiva, senza masticarli, i cibi di cui in casa si vantavano le doti e la bontà, e che non era ammesso rifiutare. Baccalà, cavolo, trippa, fagioli, Livia mandava giú tutto, con un senso di nausea per quegli odori forti, per i sapori penetranti, per il viscido che le scendeva in gola e che sembrava soffocarla. Se ne sarebbe liberata piú tardi, in bagno, con le lacrime agli occhi per lo sforzo, ma non solo per quello. E poi c’erano dei ricordi confusi, che ogni tanto le tornavano addosso all’improvviso, e che la lasciavano, tutte le volte, piena di disgusto: erano immagini e sensazioni che non sapeva spiegare. Le sembrava che una mano la toccasse, la palpasse attraverso i vestiti. Era una mano dura, che sentiva attraverso la stoffa, e che si fermava sui suoi fianchi, poi scendeva a stringere le gambe nude di quando era una bambina gracile, e per un momento, solo per un momento, risaliva a sfiorarla in alto. Livia cercava di allontanare da sé quelle immagini lontane, ma quando vedeva le mani del padre sulla tovaglia lo stomaco le si chiudeva, e distoglieva lo sguardo.
Solo di notte Livia era libera da ordini bruschi e domande ripetute, sempre uguali («Dove sei stata oggi?», «Perché sei arrivata all’ultimo momento?», «Con chi ti sei fermata a parlare?», «Tirati indietro i capelli»), e restava con gli occhi aperti, nel buio, ad ascoltare i passi stanchi di Luciana nel corridoio, l’ultima tirata d’acqua nel bagno, le mandate di chiave alla porta di casa. Poi tutto taceva e Livia cominciava a piangere piano, raggomitolata nel letto, con le gambe strette, avvolte nella camicia di flanella spessa, comprata, come tutto, all’Unione Militare. Si teneva abbracciata da sola, come a proteggersi, alla ricerca di un calore che non aveva mai trovato in nessuno. La sua vita era quella da sempre, e tante volte si era domandata, e si domandava ancora, perché mai fosse nata proprio lí, in quello che, fin da piccola, le era sembrato un posto sbagliato.
Nelle sue fantasie, Livia immaginava di non essere figlia di quel padre e di quella madre, ma di essere stata raccolta da qualche parte, e poi adottata. Si raccontava da sola queste storie per addormentarsi: fantasticava di genitori immaginari, prendendo in prestito ricordi dalle letture di quando era bambina. Una volta si immaginava un papà musicista povero e una mamma nobile che aveva dovuto rinunciare a lei, un’altra si figurava di essere nata in un circo, da genitori saltimbanchi che l’avevano lasciata davanti a una caserma, in una città di provincia. Ma sempre, in quei sogni, c’era la speranza che, prima o poi, sarebbero venuti a riprenderla, e la sua vita sarebbe cambiata, e qualcuno l’avrebbe accarezzata, per la prima volta, con dolcezza. Si consolava cosí, Livia, della sua infelicità, e si addormentava tenendosi stretta a sé stessa e ai suoi genitori di fantasia. Nei sogni veri, invece, le capitava di vedere luoghi dove non era mai stata, come la strada con la neve, e anche queste visioni la convincevano, al risveglio, di non essere nel posto giusto, di aver sbagliato lei a nascere in quella casa, da quelle persone.
Di loro le dispiaceva tutto: l’aspetto fisico e la voce, il colore olivastro della pelle e l’odore, il modo di camminare e di toccarla e di parlarle. Osservava i loro gesti con fastidio e imbarazzo: c’era sempre qualcosa di autoritario e perentorio, nel loro atteggiamento, che lei detestava. Davano ordini, esprimevano giudizi, sapevano sempre quello che si doveva fare e in quale modo. I loro discorsi Livia li conosceva a memoria, e li avrebbe potuti recitare come un copione: ripetevano con gusto, in ogni occasione, frasi come «mena l’asino dove vuole il padrone», oppure «impara l’arte e mettila da parte», e via cosí, fino a quelle che sentiva ogni mattina, nel dormiveglia, quando, ancora raggomitolata nel letto, con le lacrime secche e salate sulle guance, veniva svegliata in modo brusco dalla luce violenta e dallo sbattere delle persiane spalancate all’improvviso, mentre la madre sentenziava, soddisfatta: «Chi dorme non piglia pesci», «Chi non semina non raccoglie».
Le giornate cominciavano cosí, e Livia aveva imparato trucchi e strategie per sottrarsi agli ordini e alle inchieste («Che cosa hai disegnato ieri?», «Beata te che te la prendi comoda!», «Vedi di non consumare troppa carta, con quello che costa!»), e alla mattina scappava di casa sempre prima, ogni volta con una scusa diversa, le matite da comprare o la lezione di disegno anticipata. I sogni della notte le facevano compagnia mentre si lavava in fretta, nel bagno, dove trovava lo specchio e i vetri coperti ancora di vapore, e un rigo schiumoso di sapone nel lavandino. Cercava di non sentire l’odore nauseante della saponetta verde e scivolosa, di non toccare la spazzola del padre, con qualche capello nero rimasto impigliato tra le setole, di non guardare la camicia da notte della madre appesa alla porta, un sacco vuoto che conservava, come un calco, le sue forme sgraziate e massicce. Si vestiva di corsa: infilava le scarpe col tacco ortopedico, sistemava le calze di seta in modo che non si vedessero i microscopici rammendi, prendeva la cartella dei disegni, e giú per le scale, verso la circolare che la portava nel centro della città.
Arrivava trafelata nella piazza nascosta, simile a un palcoscenico, chiusa tra vicoli stretti e simmetrici come quinte teatrali: saliva all’ultimo piano, nell’appartamento affacciato sui tetti e sulla grande chiesa barocca. Era come arrivare in paradiso, per Livia, ma sempre la prendeva una strana timidezza quando Fiore Agagian l’accoglieva sulla porta. Fiore Agagian aveva davvero uno strano nome, e i genitori di Livia, pur avendola scelta come insegnante di disegno per la figlia, non mancavano mai di prendersi gioco del nome della pittrice. Dicevano, divertendosi a punzecchiare Livia: «Come sta la tua margherita?», «Cosa ti ha insegnato oggi la malva armena?», «Ricordati che il tuo nasturzio ci costa un occhio!», e Livia si infastidiva soprattutto per la banalità cattiva delle sostituzioni, perché Fiore poteva essere paragonata solo a fiori delicati e rari.
Fiore si chiamava Agagian perché aveva sposato un armeno apolide, Michele. Il marito di Fiore era alto e imponente, con un po’ di pancia e pochi ricciolini scuri a incorniciare la pelata lucida, mentre Fiore era piccola e minuta. Fiore aveva gli occhi chiari, di un colore indefinito, una pelle delicata e rosea, e i capelli attorcigliati in treccine biondicce riunite in una crocchia, in cima alla testa. In casa Agagian c’era sempre un buon odore di colori a olio e di acqua ragia: i quadri dipinti da Fiore erano un po’ dappertutto, appoggiati sui cavalletti, per terra, appesi alle pareti. Erano ritratti di donne immobili, sedute con la testa reclinata e gli occhi socchiusi, o con un bambino in braccio, oppure nature morte che rappresentavano scodelle, conchiglie, pesci in un piatto: avevano colori asciutti e pastosi, e il blu dominava, insieme al grigio, in tutte le tele. Quel blu avvolgeva Livia e si mescolava a quello del cielo che vedeva dalle finestre, dietro alle volute di travertino e ai ciuffi di capelvenere sul timpano della chiesa color crema, la chiesa di Sant’Ignazio.
Quando stava lí, nelle mattine tranquille passate a copiare a carboncino un modello di gesso – un piede, una mano, una testa –, oppure, con gli acquerelli, un mazzetto di anemoni in un vaso, Livia si sentiva leggera e quasi felice. Amava tutto di quella casa: i tappeti sparsi a strati sui pavimenti (l’unica ricchezza portata via quando la famiglia Agagian era fuggita dalla sua terra), i mobili chiari, di legno opaco, costruiti da Fiore e Michele, e le lampade, fatte anche quelle dalle mani operose degli Agagian, che spargevano una luce calda attraverso la pergamena giallina dell’abat-jour. C’erano libri dappertutto, sui tappeti e sugli scaffali chiari: messi uno sull’altro servivano come tavolini; ogni tanto Michele Agagian si chinava su quelle pile, spostava delicatamente tavolozze e tazzine, e poi con aria di conquista e una luce particolare negli occhi neri mostrava il libro tanto cercato e finalmente ritrovato.
Livia intuiva che quel gesto con cui Michele Agagian le mostrava in modo apparentemente casuale un libro dal bordo verde o arancione, con una minuscola testa di medusa sul bianco della copertina, era rivolto proprio a lei. Mentre glielo tendeva, Agagian diceva, in quel suo italiano fin troppo perfetto, che sembrava recitato piú che parlato: «Lo ha mai letto? È molto interessante, lo prenda». Anche Fiore seguiva la stessa strategia: mentre le correggeva una linea o un’ombra sul foglio, buttava lí all’improvviso: «È stata a vedere la mostra di Mafai alla Galleria della Cometa? No? Le spiego io come andarci». Livia si vergognava di tutto quello che non sapeva: per lei i nomi degli scrittori, dei pittori, dei musicisti di cui sentiva parlare in quella casa erano sconosciuti. Non era stata mai a scuola, lei, perché il generale sosteneva che a scuola si prendono solo malattie e non si impara niente, e cosí la scuola gliela aveva fatta sua madre. Ma dopo i primi anni le era passata la voglia di farle da maestra, o forse era colpa di Livia, che era davvero, come le dicevano sempre, una zuccona permalosa, che non dava soddisfazione, e che sapeva fare una sola cosa: disegnare. Cosí, quando gli Agagian citavano con indifferenza il verso di un poeta o il titolo di un libro, Livia non sapeva dove guardare: si sentiva goffa e ignorante, e fingeva di non vedere le occhiate che Fiore e Michele si scambiavano con discrezione.
Per Livia sentir muovere gli Agagian intorno a sé, mentre disegnava, era un piacere amaro, che le dava una fitta di dolore misto a felicità: avrebbe voluto essere come loro, o almeno averli come genitori, come amici, ma sapeva di essere troppo diversa, di non essere all’altezza, e aveva sempre l’impressione che la commiserassero un po’. In casa Agagian non c’erano orari fissi, come in casa Bencini: Michele sedeva in silenzio alla scrivania, chino a tradurre, circondato da vocabolari, mentre Fiore si divideva tra il cavalletto e Livia. Poi Michele si alzava e andava a preparare un caffè: quei momenti passati cosí, con la tazza calda tra le mani, la luce blu che entrava dalle finestre, e le voci sommesse degli Agagian che raccontavano cose nuove e sconosciute, facevano a Livia un effetto strano.
Era come se avesse sempre saputo che persone come loro dovevano esistere, da qualche parte, e che prima o poi le avrebbe incontrate. Questa certezza l’aveva avuta da sempre: da quando, bambina, osservava in silenzio, da un angolo del «salotto buono», i conoscenti dei genitori in visita: di volta in volta, secondo un orario sempre uguale, si avvicendavano in casa Bencini militari accompagnati dalle mogli, il farmacista, il notaio con la sorella nubile, il medico condotto. Quegli incontri Livia li aveva bloccati nella memoria come fotografie: ricordava con disgusto i modi rigidi degli uomini in divisa, le pose leziose delle donne, le gambe accavallate negli stivali lucidi, le calze bianche delle signore, i cappelli ridicoli, i complimenti, le frasi d’occasione, i piattini con i fondenti color pastello, l’odore del ratafià versato con parsimonia nei bicchierini di cristallo; ricordava anche, ora che era piú grande, che gli invitati parlavano spesso, con aria compiaciuta, di un uomo forte e deciso, mandato dalla provvidenza in aiuto della nazione, che ne aveva tanto bisogno. Di quei discorsi Livia ricordava un brusio confuso, nel quale il nome di un certo cavaliere si mescolava e sovrapponeva, nella conversazione, a quello di Virgilio Brocchi. Ma ricordava, soprattutto, Livia, il momento in cui, all’improvviso, come ubbidendo a un ordine, tutti quegli occhi si giravano nella sua direzione e guardavano lei.
Era il momento di cui aveva avuto sempre paura, quello per il quale cercava di rimanere un po’ in disparte, fingendo di leggere un libro e trattenendo il respiro. Ne aveva paura perché era in quei momenti che tutto il suo odio per quello che la circondava sembrava salirle in gola e soffocarla. Quando i genitori le dicevano di venire avanti, di non fare la smorfiosa, e poi, di fronte ai suoi occhi bassi e alla sua immobilità, si alzavano e la portavano, con uno strattone, in mezzo al circolo degli invitati, Livia avrebbe voluto scappare lontano. Ma c’era la mano della madre che la teneva stretta, che le faceva male, che la spingeva a salutare gli ospiti, che la obbligava a fare un piccolo inchino, o a baciare le guance gessose delle signore, e intanto il padre si prendeva gioco di lei, davanti a tutti, e Livia riusciva a malapena a distinguere, tra le risate dei presenti, attraverso le lacrime che le pungevano gli occhi, le frasi di scherno: «Ecco la nostra pittrice!», «Fai vedere ai signori gli ultimi capolavori!», «Scusatela, è ancora una bestiolina, non sa stare con i grandi».
Finivano sempre male quei pomeriggi con gli ospiti: quando la porta si chiudeva dietro all’ultimo invitato, c’erano i rimproveri, e altri strattoni delle mani forti della madre, e quella disperazione che la prendeva nel buio della camera, quando sentiva le voci dei genitori che commentavano tra loro, prima di dormire, la brutta figura, e per di piú proprio davanti al notaio e al farmacista.
In quegli anni dell’infanzia la famiglia Bencini si era spostata in varie città, a seconda dei trasferimenti del padre di Livia: erano sempre cittadine di provincia fredde e umide del Nord, e il trasloco si svolgeva seguendo un rituale fisso: ricerca del nuovo appartamento, che doveva essere economico ma decoroso, spedizione dell’attendente a sistemare mobili e suppellettili secondo un ordine che rimaneva sempre lo stesso, e infine spostamento definitivo dei Bencini con ceste, casse, cappelliere. Forse Livia amava tanto il disordine luminoso di casa Agagian perché non era mai riuscita ad abituarsi alle geometrie dell’arredamento della propria casa. I mobili, in casa Bencini, erano squadrati, di legno scuro scelto per durare in eterno: le sedie, in particolare, avevano uno schienale alto e rigido, che obbligava a una posizione innaturale e impettita, e Livia fin da piccola si era chiesta se chi entrava in quella casa era predisposto a quell’atteggiamento ad angolo retto, o se lo assumeva per la forma delle sedie.
In casa Agagian c’erano cuscini sparsi dappertutto: una volta un amico di Fiore e Michele, un pittore romeno, s’era seduto per terra, sul tappeto, e Livia l’aveva guardato con stupore. Il pittore si chiamava Radu Roman: piú che dipingere, Radu disegnava incessantemente. Aveva sempre in tasca un blocchetto di carta di Fabriano con la copertina di tela, chiuso da un elastico. Mentre parlava, seduto lí per terra, beveva caffè forte e scuro e mangiava pistacchi. Livia lo ascoltava leggere i versi di un poeta che lei non conosceva, e che si chiamava Tudor Arghezi. Radu Roman declamava versi, sgusciava pistacchi, raccontava avventure, poi all’improvviso tirava fuori dalla tasca della giacca di velluto il blocchetto, e continuando a parlare, con occhiate velocissime, riempiva di segni sottili il foglio di carta. A volte rimetteva via il blocco con indifferenza, altre ne staccava con cura una pagina lungo i forellini e la tendeva a uno dei presenti. Un giorno il foglio era stato teso proprio a Livia, e lei si era vista, sulla carta, diversa da come pensava di essere. Si era vista attraverso gli occhi e la mano di Radu: una ragazza con tanti capelli, che nel disegno erano ghirigori a china, e due grandi occhi fissi, con un’espressione seria, un po’ meravigliata, il mento appoggiato sulle mani, i gomiti sulle ginocchia.
Non si era mai vista cosí Livia, ma solo attraverso gli occhi critici dei genitori. Anche per il suo aspetto fisico pensava di averli delusi: le era sempre sembrato che loro, cosí bruni, con le sopracciglia nere e marcate, i capelli scurissimi e lisci, disprezzassero un po’ quei suoi ricci castani striati di rosso, e la sua pelle chiara. Ma allora, per la prima volta, si era vista non brutta, e aveva nascosto il disegno nell’album. Spesso, nei giorni e nei mesi che seguirono quell’incontro, Livia aveva riguardato il disegno, come per convincersi che quella ragazza era proprio lei.
I suoi giri nella nuova città continuavano: ormai era in grado di muoversi con disinvoltura non solo tra le strade e i vicoli del centro, ma anche nelle zone antiche che, all’improvviso, proprio in quegli anni stavano diventando nuove, dopo l’abbattimento delle vecchie case e dei borghi, per far posto a vie dritte e larghe, a palazzi squadrati e imponenti, decorati con bassorilievi bianchi. Quei bassorilievi le facevano uno strano effetto, e non era sicura che le piacessero: raffiguravano donne e uomini nudi o seminudi: gli uomini erano sempre forti e massicci, a volte avevano il busto nudo e calzoni abbondanti, mietevano il grano o spingevano un aratro, le donne avevano fianchi larghi, spighe o forme di pane tra le mani, bambini in braccio e ai piedi. Quelle donne non le piacevano, perché avevano polsi forti, caviglie e fianchi larghi, come sua madre.
In quel periodo Livia aveva preso l’abitudine, incoraggiata dagli Agagian, di andare ai concerti. Ai genitori quella era sembrata un’altra stranezza della figlia, un’imitazione ridicola di quegli smidollati – cosí li chiamavano – che si era messa a frequentare. Per loro la musica si identificava solo con l’opera e soprattutto l’operetta, con le marce suonate dalle bande militari, e consideravano una posa questo suo nuovo entusiasmo, un po’ costoso, per la musica sinfonica.
In quegli anni i concerti si svolgevano, d’estate, all’aperto, in una grande basilica romana sovrastata da volte. Livia, per imitare Radu Roman, portava con sé un blocchetto di carta spessa, color avorio, e durante il concerto tracciava schizzi a penna: una donna nella fila davanti a lei, con un cappello curioso, a cupola, e un profilo appuntito; un uomo assorto nell’ascolto, con la testa tra le mani; oppure il direttore d’orchestra tutto proteso, con le braccia alzate e i capelli scomposti, a incitare l’orchestra con la bacchetta. Anche lí Livia si sentiva quasi felice: amava quella musica di cui cominciava a imparare nomi e titoli, ma soprattutto le piaceva esserci e sentirsi parte di un gruppo. Rivedeva ogni volta le stesse persone, con qualcuna scambiava un sorriso o un cenno d’intesa: riconosceva da lontano gli Agagian, e Roman che la salutava con un gesto enfatico, mandandole un bacio sulle punte delle dita, prima che le luci si spegnessero e la musica attaccasse.
Era in quei momenti che a Livia sembrava, per la prima volta, di non essere piú tanto sola e brutta e disperata. Anche se conosceva poche persone, le bastavano quei cenni di saluto, quegli sguardi che, incrociando i suoi, si fermavano per un momento a considerarla, per farle sentire, mentre se ne stava lí al buio, sotto alle stelle, avvolta dalla musica, un calore nuovo che le scendeva nel corpo, e le dava piccoli morsi di piacere al ventre. Forse un giorno – si diceva – sarebbe diventata una persona come quelle che aveva intorno, e avrebbe avuto anche lei un uomo al suo fianco. Immaginava sé stessa e quell’uomo indefinito e vago seduti vicini, proprio come gli Agagian, che vedeva, una fila piú avanti, chini a sussurrarsi qualcosa sottovoce, le due teste che, per un momento, si univano e diventavano una cosa sola, fatta dei ricciolini scuri di lui e della crocchia chiara di lei.
Tornare a casa, dopo le lezioni, dopo i giri nel centro della città, dopo i concerti, era sempre piú difficile: scendeva di corsa dalla circolare, e camminava svelta nella via in discesa che la portava a casa, con la cartella dei disegni sotto al braccio. Via Nizza era una strada lunga e sinuosa, in discesa, costeggiata da case austere circondate da strisce di ...