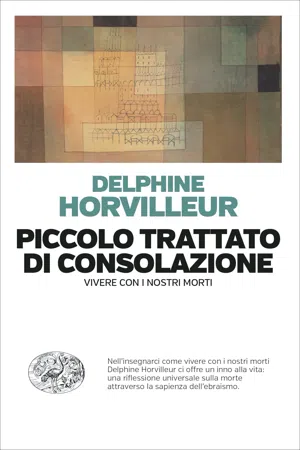«Non tornerà piú», dissi alla figlia di Elsa.
Avevo torto.
Nel giugno del 2017, cioè due anni e mezzo dopo l’attentato di «Charlie Hebdo», ricevo la chiamata di una famiglia che ha appena perso un parente. Marc aveva cinquantanove anni e lasciava i genitori, una compagna e un figlio. Grazie a loro scopro l’uomo brillante e ancora cosí giovane che mi appresto ad accompagnare insieme a loro.
Incontrare i familiari e preparare una cerimonia funebre è un momento sacro. Pare persino banale scriverlo. Ma quelle ore, quei giorni trascorsi insieme a coloro che si separano da una persona cara rappresentano proprio un tempo «sacro» come sottintende l’ebraico. Qui la parola «sacro», qadosh, significa letteralmente «separato», e la scomparsa di una persona cara fa davvero entrare chi resta in un tempo «separato»: ne interrompe la linearità.
La tradizione ebraica stabilisce che fra il decesso e la tumulazione si ponga accanto al corpo del defunto una candela, simbolo della presenza della sua anima, rimasta in vita. Questo rito enuncia una verità profonda: qualcosa della vita di colui o colei che ci ha lasciato resta acceso in quei giorni. È quello un tempo in cui la vita che se ne va brilla in un modo particolare e tutti coloro che vi si accostano se ne rendono conto: quella luce può mettere a fuoco il mondo, quando non aiutare a vedere ciò che fino a quel momento era rimasto nella piú totale oscurità.
È la ragione per cui le conversazioni con i parenti, in quel tempo fuori dal tempo, sono cosí determinanti. Come rabbino so che ho a disposizione un intervallo molto breve per provare a riconoscere quella luce attraverso le parole, i gesti, i racconti e i silenzi della cerchia ristretta di persone vicine al defunto. Devo captare quel che tale luce può rivelare, ciò che illustra, le ombre che contiene e il modo in cui vibra.
So bene che non mancherà chi legge in queste righe una forma di bigottismo o di pensiero magico. No, non mi riferisco a nessuna fede nell’eternità dell’anima né di vita oltre la morte bensí di una coscienza tanto concreta quanto razionale: i rituali di accompagnamento finiscono per fare della vita del defunto un destino, a condizione di dire senza tradire.
In una celebre citazione André Malraux afferma che «la tragedia della morte è tale che trasforma la vita in destino». La morte ha certamente questo potere, grazie alle parole e ai riti. Crea una narrazione che edifica la vita un po’ come un monumento di cui si pongono le fondamenta all’ultimo respiro. Pertanto, a differenza di quanto lascia intendere André Malraux, a me sembra che in quei momenti sacri non sia necessario chiamare in causa la tragedia. È invece possibile pensare diversamente l’edificio memoriale che comincia a costruirsi sotto i nostri occhi.
Esistono ben altri modi per trasformare una vita in destino. La morte è spesso una tragedia, senz’altro quando viene in un momento in cui per le nostre coscienze è qualcosa di inconcepibile perché non è ancora giunta l’ora o perché la violenza dello strappo annienta tutto al suo passaggio… eppure esiste un modo per non farsi portar via tutto il racconto di una vita. Troppo spesso la brutale scomparsa di qualcuno ci depreda del complesso di un’esistenza che non dovrebbe ridursi alla sua spoliazione.
Mai raccontare una vita dalla fine bensí attraverso tutto ciò che in essa si è creduto «senza fine».
Saper dire tutto quel che è stato e quel che avrebbe potuto essere, ben prima di dire quel che non sarà mai piú.
Mi viene in mente una scena tratta dal film Le Nom des gens di Michel Leclerc. Il protagonista, discendente di un deportato, assiste nella sua scuola alla posa di una targa in memoria dei bambini morti nei campi. Quando l’insegnante spiega il senso di quell’omaggio, l’adolescente sconvolge tutti i suoi compagni con questo intervento:
Immagino di essere stato ucciso, e tutti i giorni passo davanti a questo coso che mi ricorda quanto sia orribile essere stato assassinato, non sono sicuro che mi farebbe piacere. Sarebbe meglio ricordarsi del giorno in cui ho mangiato la panna montata per la prima volta, ad esempio, scrivendo sulla targa IN QUESTA SCUOLA DEI BAMBINI HANNO MANGIATO LA PANNA MONTATA PER LA PRIMA VOLTA IN VITA LORO. Sarebbe piú carino per loro, trovo.
Le considerazioni del ragazzo mandano su tutte le furie l’insegnante, che non si rende conto che questa provocazione enuncia una verità sulla quale è interessante riflettere: esistono tanti modi per raccontare la vita di coloro che ci lasciano, anche quando la loro dipartita è quanto mai drammatica. Forse vale davvero la pena di fare in modo che la nostra memoria resti fedele alla complessità della loro esistenza, che a sua volta non si riduce mai soltanto alla tragedia della fine.
Quante volte ho pensato che mi auguravo, per me e per i miei affetti, che il giorno del nostro funerale le nostre vite possano essere raccontate in una forma alternativa alla tragedia, che ci sia dato di essere rievocati con altri lessici, altri registri, che le nostre vite possano essere guardate magari come un thriller, una serie romantica, un racconto mitologico o perfino una commedia popolare. Purché al nostro funerale ci sia consentito di non essere ridotti alla nostra morte, di comunicare quanto in vita siamo stati vivi.
Capita che a un funerale i discorsi sorvolino su una vita, o che l’officiante sbagli completamente registro. Sí, mi è capitato. Mi ricordo in particolare di una volta in cui ebbi la nitida sensazione di aver «sballato» l’omaggio all’uomo che stavo accompagnando. Non ero stata in grado di identificare gli elementi salienti della sua esistenza. Le sorelle e i fratelli erano venuti a organizzare la cerimonia qualche giorno prima. Avevano faticato a rispondere a tutte le mie domande, come se fossero loro sfuggiti interi settori della sua personalità, come se fossero stati degli estranei per lui, sino alla fine.
«Aveva delle passioni?»
«Niente di cui siamo a conoscenza».
«Quali erano le persone che contavano veramente per lui».
«Vai a sapere».
«Quali erano i suoi sogni?»
«Non ci risulta che avesse dei sogni».
La risposta a tutte queste domande giunse durante la cerimonia stessa, vale a dire troppo tardi. L’uomo da cui ci stavamo congedando era stato amato moltissimo, ma la sua famiglia biologica non ne sapeva niente. Gli amici e le persone amate lí riunite lo attestavano. Loro erano la vera famiglia che lui si era costruito, coloro ai quali aveva confidato i propri sogni. Ma nessuno di loro era venuto a parlarmi.
La famiglia biologica di quell’uomo non aveva nemmeno sfiorato la sua vita, a compartimenti stagni, e cosí, il giorno del funerale, mi trovai a fare da portavoce di un’ignoranza, di un appuntamento mancato, la testimone di un incontro che non c’era mai stato. E volente o nolente, ammettere il fallimento: non negare le barriere che quell’uomo si era costruito per separare gli uni dagli altri nella propria vita, ma anche provare a sentire quel che c’era sull’altro versante dell’invisibile muro, ascoltare tutto quel che non ero stata in grado di sapere.
Al funerale di Marc non è successo niente del genere. Quest’uomo aveva saputo intessere dei legami con tutti coloro che avevano contato nella sua vita. E tanti, quel giorno, raccontarono della sua umanità. Ricordo di essermi resa conto quel giorno di quanto amore c’era stato nella sua vita: l’amore per la medicina e per la cura degli altri, l’amore per la scrittura e per la sua famiglia, l’amore degli amici e di tutti coloro con i quali aveva stretto legami profondi, condiviso affinità. Una di queste persone amiche chiese la parola, e ne aveva ben donde.
Alla vigilia del funerale di Marc, mentre mi accingevo a scrivere la sua eulogia funebre, la sua famiglia mi ha mandato un ultimo messaggio.
Volevano semplicemente aggiungere un dettaglio alla nostra conversazione trascorsa, un aneddoto che si erano scordati di condividere con me. Insomma, dovevo sapere che Marc aveva intrattenuto «per molti mesi una corrispondenza che gli stava molto a cuore»: aveva scambiato delle mail con una certa Elsa Cayat, la psicoanalista assassinata durante l’attentato a «Charlie Hebdo», e avevano in mente di pubblicarle in un libro. La famiglia allegava al messaggio una copia di quel loro dialogo elettronico interrotto nel 2015.
Pensavo che Elsa non sarebbe mai piú tornata. Avevo torto. Una sera, a modo suo, ha bussato di nuovo alla mia porta, o sullo schermo del mio computer, a incalzarmi e aiutarmi a scrivere. Ho aperto l’allegato.
Era tardissimo, tremavo al pensiero di quello che stavo per leggere. Ne avevo il diritto, poi? Marc e Elsa si erano effettivamente scambiati molte mail, nel corso di tutto il 2014, l’ultimo della vita di Elsa.
Credo di non tradirli condividendo un poco di ciò che sta scritto in quei messaggi; sembravano scritti apposta per essere pubblicati. Marc evocava i propri ricordi e faceva delle riflessioni, Elsa rispondeva con la propria esperienza psicoanalitica. Avevano finito per scegliere insieme un tema di scrittura, un oggetto di quella esplorazione che prima o poi sarebbe diventato l’argomento del loro libro.
Per tutto il 2014, dunque, quei due avevano deciso di conversare intorno alla… morte. Erano entrambi perfettamente consapevoli che prima o poi sarebbe venuta a trovarli, tutti e due.
Fu cosí che una notte d’estate del 2017 giunse a me, per mail, il dialogo epistolare di persone che non avrebbero certamente mai immaginato che il loro primo lettore, postumo, sarebbe stato il rabbino preposto ai loro funerali.
Evocando la loro morte, fu come se mi affidassero gli elementi che speravano di vedere nella propria eulogia. Forse mi stavano invitando a «incontrarli». Era la prima volta in vita mia che mi capitava di ricevere un messaggio da dei fantasmi, e men che meno via mail. È cosí che talora tornano, gli spettri.
«Ritornanti». Spesso in francese i fantasmi si chiamano cosí, perché è proprio questo che si impuntano a fare: tornare. Tornare sino a quando non si accetta di vederli, e poi di parlare di loro.
Torniamoci, dunque.
Tutti i bambini giocano ai fantasmi. Ricordo di essermi nascosta centinaia di volte dietro le tende del salotto dei miei nonni e di aver fatto tremare il tessuto lanciando inquietanti uhuuuu. Non c’è film o cartone animato della nostra infanzia dove non siano rappresentati nello stesso modo, cioè in forma di figure nascoste sotto un telo bianco che volteggia. Ma l’origine di questa immagine e il suo simbolismo esulano in realtà dalla cultura popolare: la veste bianca del fantasma è di fatto reminiscenza di un rito ebraico ancestrale, e cioè l’avvolgimento del morto in un sudario.
Nell’ebraismo il defunto non viene sepolto in abiti formali o con il vestito della domenica. Prima di essere inumato viene preparato lavato e coperto con una tunica bianca apposita. Che riproduce simbolicamente un’altra tenuta, di cui è detto nella Bibbia: il paramento che indossava il Sommo Sacerdote quando officiava al Tempio di Gerusalemme, piú di duemila anni fa.
La Torah descrive con dovizia di particolari come il Sommo Sacerdote si purificava, eseguiva le abluzioni e si vestiva sull’altare, prima di presentarsi al cospetto del Creatore. Nel Tempio il cohen era colui che poteva stare piú vicino a Dio di tutti gli altri, l’unico che aveva il diritto di entrare nel Santo dei Santi, vale a dire di fronte al Dio invisibile. Nella tradizione ebraica, il giorno dell’inumazione ogni uomo assume il ruolo sacerdotale. Il suo corpo viene avvolto in un sudario che riproduce tutti gli elementi del paramento sacerdotale. Ogni uomo che viene sepolto è un Sommo Sacerdote, il giorno della sua dipartita. Si prepara, infatti, allo stesso «faccia a faccia».
I fantasmi della nostra infanzia sono dunque a immagine di quella tenuta funebre che incalza le nostre memorie collettive. Riproducono quel rituale di morte… Con una eccezione.
Un ultimo elemento conclude la preparazione dei morti nella tradizione ebraica: il sudario deve essere cucito alle sue estremità, e chiuso appena prima che il corpo sia pronto per l’inumazione. L’abito dei morti è chiuso, e quella cucitura suggella la loro dipartita.
Quest’ultimo punto della preparazione funebre porta con sé delle inattese ripercussioni nella quotidianità di alcune famiglie ebraiche, fra cui anche la mia. Quand’ero bambina, se perdevo un bottone o un angolo del mio vestito si scuciva, bisognava ricucire rapidamente, rammendare subito il tessuto scucito. Mia madre mi imponeva allora di fare una cosa sorprendente, all’apparenza giocosa: dovevo assolutamente masticare con forza, con movimenti esagerati delle mascelle, durante tutto il tempo del rammendo. Mi ci sono voluti anni per venire a capo della superstizione in gioco in questa ingiunzione apparentemente anodina ma in realtà drammatica. Racconta infatti del divieto di cucire un tessuto su una persona viva, perché quel gesto di solito viene fatto sui morti.
Bisognava dunque stornare la sorte, piú precisamente mandare un messaggio inequivocabile all’angelo della morte, nel caso si trovasse nei paraggi. Se fosse testimone della scena di rammendo penserebbe di trovarsi davanti a un morto! La masticazione, invece, gli fa presente che no, la persona in questione è viva e vegeta. «Scusi, ci deve essere un equivoco: è solo un rammendo!» Ecco come si invita la morte a tornare piú tardi. Il piú tardi possibile.
Ecco che cosa rappresenta il fantasma nei film o nella cultura popolare: quella figura bianca e mobile è un morto avvolto nel suo sudario «flottante». Un defunto con indosso un paramento funebre cucito male o non cucito del tutto.
Visto che ha dei punti scuciti, il fantasma non può lasciare questo mondo. È trattenuto qui e vaga in attesa del rammendo, che gli permetterà finalmente di partire. In ebraico, del resto, fantasma si dice ruach refaim, alla lettera «spirito rilasciato»: sono degli spiriti dai fili scuciti.
I fantasmi portano traccia delle loro storie scucite ed è per questo che tornano. Aspettano il rammendo, vale a dire vedere la loro storia «ripresa» da coloro che sono rimasti.
Nel film Il sesto senso di Night Shyamalan un bambino ripete agli adulti intorno a lui questa frase tremenda: «Vedo persone morte», «vedo dei morti». Se lo spettatore rabbrividisce, è perché si trova costretto a chiedersi se non sia lui a rifiutarsi di vedere i fantasmi che ha intorno. E se anche noi avessimo facoltà di...