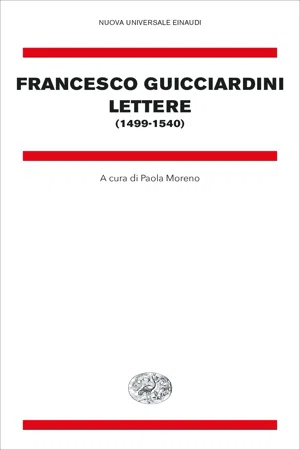Ai miei allievi,
da cui ho sempre imparato.
Francesco Guicciardini nacque nel 1483, nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, terzogenito di una famiglia illustre e rispettata. La sua ricchissima vita si interruppe all’età di cinquantasette anni, in una città di cui le istituzioni e le pratiche di convivenza civile erano completamente cambiate.
Questi dati biografici non sono puramente aneddotici, ma segnano un tratto importante della personalità e del pensiero di Guicciardini: egli, infatti, assaggiò nella sua infanzia il benessere della pace italica perseguita da Lorenzo, mentre la sua morte sopraggiunse quando la Penisola si ritrovò sottomessa al giogo spagnolo, avendo vissuto esperienze traumatiche come le guerre, l’intrusione violenta di potenze straniere su tutto il territorio e il sacco di Roma. Diversamente dalla generazione immediatamente precedente alla sua, a cui appartenne Machiavelli, che non poté valutare esaustivamente il processo che aveva condotto Firenze dalla repubblica al principato e l’Italia alla perdita della libertà, Guicciardini poté applicare la propria intelligenza storico-politica a un intero ciclo storico, da lui vissuto in prima persona e indagato con acume, lucidità e passione in tutti i suoi scritti. Non a caso il maestoso esordio della sua Storia d’Italia mette in evidenza proprio il contrasto tra l’epoca d’oro ante 1494 e quella che segue gli eventi bellici e politici, inesorabilmente segnata dalla tragedia:
Io ho deliberato di scrivere le cose accadute alla memoria nostra in Italia, dappoi che l’armi de’ franzesi, chiamate da’ nostri principi medesimi, cominciorono con grandissimo movimento a perturbarla: materia, per la varietà e grandezza loro, molto memorabile e piena di atrocissimi accidenti; avendo patito tanti anni Italia tutte quelle calamità con le quali sogliono i miseri mortali, ora per l’ira giusta d’Iddio ora dalla empietà e sceleratezze degli altri uomini, essere vessati. […] Ma le calamità d’Italia (acciocché io faccia noto quale fusse allora lo stato suo, e insieme le cagioni dalle quali ebbeno l’origine tanti mali) cominciorono con tanto maggiore dispiacere e spavento negli animi degli uomini quanto le cose universali erano allora piú liete e piú felici.
La scelta adottata dall’uomo pubblico fu quella dell’impegno e della serietà nell’affrontare le responsabilità e le sfide che gli impose la sua lunga carriera: contarono molto nella sua condotta politica i valori ereditati dal ceto a cui apparteneva, ma soprattutto la necessità della coerenza, della salvaguardia dell’onore personale e della preservazione di Firenze.
Quello dello scrittore è invece un atteggiamento piú riservato, che alcuni hanno definito “segreto”, non solo perché lo storico non volle pubblicare nessuno dei suoi numerosi scritti, ma anche perché la scrittura fu per lui un’attività da praticare nell’intimità, in solitudine, al limite concedendo solo a membri della famiglia di usufruirne in futuro (come per i Ricordi). In questa pratica quotidiana e di lungo corso, egli maturò esperienze sempre piú autonome, che lo condussero all’elaborazione di un linguaggio proprio e di un metodo conoscitivo originale, che fu utile a lui per orientarsi nel presente fluido in cui doveva prendere decisioni cruciali, e che risulta per noi lettori un esempio di disposizione intellettuale lucida e integra, esente da ogni tentazione di ottimismo, di fronte a una crisi che possiamo a buon diritto definire epocale.
Tra gli scritti guicciardiniani, le lettere assumono un valore specifico. Il lettore moderno, infatti, dovrà sempre tenere presente l’inversione di prospettiva per cui la corrispondenza – che noi tendiamo a considerare come una testimonianza privata, a circolazione limitata – fu il principale veicolo di diffusione delle idee guicciardiniane, mentre le opere programmatiche, come i dialoghi politici o le storie, che si iscrivono in una tradizione letteraria classica, registrano sí riflessioni personali di grande portata filosofica e storica, ma sono state volutamente sottratte dall’autore al confronto con coloro che si interrogavano, negli stessi anni, sui temi a lui cari.
D’altra parte, bisogna considerare che le lettere funzionano, nel sistema della scrittura guicciardiniana, come punto di partenza, a caldo, di idee e formulazioni nuove, che vengono successivamente sviluppate in altri scritti, ma anche come un costante richiamo, una fonte a cui attingere anche per testi, come la Storia d’Italia, la cui redazione è molto posteriore agli avvenimenti trattati nella corrispondenza. Talvolta risulta perfino difficile distinguere il documento epistolare dal discorso politico, se non attraverso elementi afferenti alla materialità del documento. La lettera e il discorso condividono, ad esempio, l’impronta dialogica, che talvolta viene esplorata fino al confronto dialettico tra argomenti pro e contra una determinata tesi, o al dialogo immaginario tra piú interlocutori. Questo della contrapposizione, in discorsi speculari, di due tesi opposte è un vero e proprio “marchio di fabbrica” guicciardiniano, che ci dice molto sul suo modo di guardare al mondo, e che struttura l’argomentazione, spesso preliminare alla presa di decisioni o di posizioni pubbliche. L’impressione è insomma che la lettera, al pari della piú classica orazione, funzioni per Guicciardini da vero e proprio archetipo per il ragionamento politico, concepito sovente come pars altera dialogi.
Un focus piú ravvicinato di alcuni dei documenti presentati in questo volume servirà da illustrazione a quanto detto, nonché da affondo nei pensieri di volta in volta formulati da Guicciardini in vari momenti della sua vita.
Presentata per temi, che qualche volta coincidono con momenti cruciali della biografia dell’autore, la rassegna che viene qui proposta comincia con un gruppo di lettere latine (→ I-V), destinate a un compagno di gioventú, Alessio Lapaccini, negli anni in cui Guicciardini conduceva gli studi giuridici a Firenze, presso Iacopo Modesti da Prato, Ormannozzo Deti e Francesco Pepi. Queste lettere, pur mancanti delle responsive del Lapaccini, mettono in scena un vero e proprio gioco umanistico, in cui l’indole scherzosa, nonché la raffinatezza nel maneggio del latino, ci appaiono per la prima volta. Discendente di una potente famiglia fiorentina, Francesco aveva infatti atteso nella sua fanciullezza a «cose di umanità», e fu allevato «santamente» dal padre Piero, seguace di Savonarola. Consigliato dal genitore, decise di seguire gli studi guridici, che ben si confacevano al suo carattere ambizioso. L’influenza che la formazione giuridica ebbe sul suo pensiero e sulla sua azione politica è un campo d’indagine ampiamente esplorato dagli studiosi1, ma in queste lettere giovanili gli insegnamenti seguiti a Firenze sono solo oggetto di una raffinatissima moquerie; e proprio il gusto canzonatorio si ritroverà in lettere piú tarde, tra cui, notoriamente, quelle scambiate con Machiavelli.
La solida formazione, perseguita a Ferrara, poi a Padova, gli permise di avviare a Firenze una fiorente attività d’avvocatura, che egli esercitò anche piú tardi, fino agli ultimi anni della sua vita, sebbene con intensità variabile. La notorietà acquisita, nonché il prestigio della famiglia da cui discendeva, gli valsero il primo importante incarico politico della sua lunga carriera: l’ambasciata in Spagna, per conto della Signoria di Firenze, dalla fine di gennaio 1512 fino agli inizi del 1513. Le lettere relative a questo periodo sono numerose, indirizzate principalmente ai Dieci di Balía, a cui l’ambasciatore non cessava di chiedere istruzioni, in un clima particolarmente confuso, e alla famiglia, specialmente al padre e al fratello maggiore, Luigi. L’orizzonte familiare e quello politico sono strettamente connessi nella corrispondenza guicciardiniana. Il confronto con il padre, poi con i fratelli, particolarmente Luigi e Iacopo, serviva, nei mesi della missione in Spagna, a mantenere vivo il contatto con Firenze, che proprio nel 1512 registrava la prima restaurazione medicea. Puntualmente informato dai familiari sulla vita politica fiorentina, durante il soggiorno in Spagna Guicciardini redasse il Discorso di Logroño, la prima opera programmatica nella quale rifletteva sull’assetto istituzionale e politico che Firenze avrebbe dovuto mettere in campo. Si tratta di un progetto articolato di riforma istituzionale, giacché «el vivere nostro civile è molto difforme da uno ordinato vivere di buona republica, cosí nelle cose che concernono la forma del governo, come nelli altri costumi et modi nostri»2. Guicciardini immaginava per la sua patria un governo popolare, in cui il Consiglio Grande, supremo organo della sovranità popolare istituito da Savonarola sul finire del Quattrocento, fosse guidato da un gonfaloniere a vita; ma un senato, composto da cittadini «savi et esperimentati», doveva nelle sue intenzioni accompagnare il Consiglio e il gonfaloniere, neutralizzando cosí il pericolo della demagogia dell’uno e dell’autoritarismo dell’altro organo. In tal modo Guicciardini fornisce una prima risposta a quella che sarà una sua costante preoccupazione: l’individuazione dei criteri di selezione della classe dirigente, che per lui si identifica con il ceto ottimatizio, e la conciliazione di questa esigenza di competenza politica con la necessità, vitale per Firenze, del mantenimento della libertà e dell’uguaglianza dei cittadini rispetto all’assegnazione degli uffici.
Negli anni successivi, la corrispondenza con i fratelli diventa a tratti fitta: Iacopo fu suo interlocutore nella gestione dei governatorati, quando doveva allontanarsi dalle città sottoposte al suo governo; Luigi, pure impegnato in politica, ma solo in Toscana, fu nel tempo destinatario di lunghe lettere che sintetizzavano, talvolta con un taglio storico, avvenimenti bellici, riflessioni personali sull’andamento della politica fiorentina o italiana, strategie familiari e personali volte a mantenere alto il prestigio dei Guicciardini, in tempi in cui alleanze o inimicizie potevano determinare il declino definitivo della casata. Con i fratelli, Francesco intratteneva anche rapporti economici, dal momento che tutti partecipavano a una società commerciale, specializzata nella compravendita di varie merci, con contatti fittissimi verso i Paesi Bassi. La lettera scritta da Valladolid nel giugno del 1513 (→ IX) informa Luigi delle nuove prospettive economiche generate dalle esplorazioni spagnole e portoghesi nelle Americhe e in Oriente. Guicciardini intravede subito le conseguenze, non solo economiche ma anche politiche, dell’apertura delle nuove rotte commerciali:
Et in effecto, per quello che si vede, questa fortuna sua [i. e. di Ferdinando di Spagna] grande, la quale lo ha accompagnato dal dí che nacque insino a hora, pare ancora piú verde et piú frescha che mai; et se la continua insino alla morte, si potrà dire arditamente che da Carlo Magno in qua non sia stato in tucta Cristianità uno tale principe.
Ma il momento in cui Guicciardini poté veramente sperimentare l’esercizio concreto e pragmatico del potere è quello relativo agli anni in cui assunse il governo di importanti presidi della Chiesa, come Modena e Reggio Emilia, e successivamente Parma, la Romagna e Bologna.
I primi governatorati gli furono conferiti grazie alla stima che si era guadagnata da parte dei Medici, soprattutto Lorenzo il giovane e Giulio. Con quest’ultimo, ancora lontano dal soglio pontificio ma in prima linea per gestire il pontificato di Leone X, Guicciardini si confidava spesso, esponendo nelle lettere a lui inviate il proprio programma politico, che consisteva, nei primi anni, nel ristabilimento dell’ordine e della legalità, in città dominate dalla nobiltà locale, restia alla sottomissione al potere pontificio e assuefatta a una condizione di faziosità endemica3. Significative sono a tale proposito le parole di sfogo scritte a Giulio de’ Medici nella lettera del 9 giugno 1522 (→ XIV), durante il governatorato di Parma:
Ci si aggiugne che, per havere costoro [i. e. le fazioni parmensi] parte et amici drento, ci è pieno d...