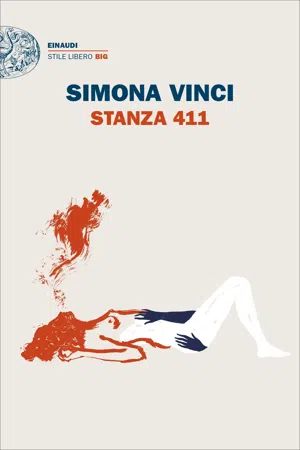Questa è una stanza d’hotel.
Albergo Nazionale, piazza di Montecitorio, Roma.
Il numero della stanza è 411.
E questo è il mio corpo, riflesso dentro uno specchio. Uno specchio diverso da quello dentro il quale mi osservo ogni giorno: lo specchio lungo e stretto dell’anta di un armadio a muro. Questo è largo, un’intera porta che racchiude anche l’eco di un’altra superficie riflettente. La luce mi illumina da dietro e del mio corpo vedo solo i contorni. Quella che vedo è una donna. Semplicemente una donna.
È bella?
Oppure è brutta?
Cerco uno sguardo neutro – se mai è possibile trovare uno sguardo neutro per osservare sé stessi –, lo pulisco, lo mondo dai residui, dalle domande, dalle incertezze, dai complessi che come chiunque altro mi porto dietro dall’adolescenza – piú indietro ancora, dall’infanzia.
Questo che vedo dentro lo specchio del bagno della camera d’albergo di un hotel a quattro stelle è un corpo di donna. A osservarlo cosí, nella luce che sfuma i dettagli e permette una visione chiara soltanto della sagoma, mi sembra un corpo minuto. Gambe slanciate, cosce sottili che non si toccano in mezzo. Quando ero bambina, per un periodo è successo e d’estate era un inferno: sudavo, e tra le cosce che sfregavano una contro l’altra si formava una chiazza rossa. Bruciava. E io odiavo le mie cosce. Cosí come odiavo la mia pancia, grassa e bianca sotto le mutande di cotone rigato che mi segavano l’ombelico con l’elastico. Sono stata una bambina magrissima. Nelle foto vedo una bambina ragno, con la pancia rotonda e le braccia e le gambe secche, le clavicole sporgenti, le costole tutte in evidenza. Un giorno, di colpo, mi sono tramutata in un’adolescente sovrappeso. Adesso, la testa mi sembra troppo grande per questo corpo rattrappito, minuscolo, asciugato ma sempre imperfetto. Lo stomaco è piatto, la pancia ha una leggera curva, un’onda morbida di pelle sotto la quale letteralmente scoppiano le ossa del bacino. Certi giorni, queste ossa mi sembrano spaventose, altri le sfioro di nascosto sotto i vestiti e mi dà sicurezza sentire che sono lí, esposte, pronte a ferire in un abbraccio troppo stretto. Il seno è né grande né piccolo. Le areole larghe e rosa, i capezzoli troppo grossi. Il seno è la cosa piú brutta di questo corpo. La cosa che ho odiato dal primo giorno. Ricordo un altro specchio, la luce arriva da sinistra, è la luce di un pomeriggio d’estate. Ho tredici anni e osservo con disprezzo la mia immagine riflessa nello specchio rotondo del bagno blu di mia madre. Mi guardo davanti, dietro, di sbieco, di profilo. Due escrescenze estranee sono comparse di colpo a dividermi in due il petto, a deformarlo. Prima di quel giorno, credo di non aver mai desiderato il seno come invece fanno moltissime bambine. Credo di non averci neanche mai pensato, che mi sarebbe cresciuto. E invece è arrivato: un dono non richiesto, un sacco di carbone schifoso al posto dei cioccolatini e delle caramelle, dei regali. Sei stata una bambina cattiva, dice lo specchio, e questo è il risultato. Da quel giorno, imparo a occultare il segreto immondo che mi porto cucito addosso, imparo a stringerlo, appiattirlo, celarlo sotto strati di vestiti in modo che gli altri non sappiano. Mi illudo. Gli altri lo sanno: non c’è modo di nascondersi.
Non c’è mai modo di nascondersi, ma questo l’ho imparato soltanto adesso.
Stanza 411. Albergo Nazionale. Roma. Fuori della finestra spalancata sopra la piazza di Montecitorio deserta a quest’ora di notte, a parte le guardie armate e qualche passante occasionale, soprattutto turisti ubriachi, splende una luna fredda. Luna di febbraio.
Io sono qui, e ti aspetto.
Il mio corpo è fatto di ossa. Muscoli. Tendini. Ci sono le vene azzurre, un reticolato di fiumi che mi attraversano. Le vene grigie, dossi di materiale vischioso, in rilievo. È un arazzo segreto che puoi contemplare solo da vicino, dopo aver tolto i vestiti. Dentro le vene, il sangue. Ancora piú a fondo – immagina la lama del chirurgo che fende gli strati, li lacera uno alla volta con perizia – ci sono gli organi. Sotto il seno sinistro, appena piú grande – e dunque piú odiato – del destro, c’è il cuore. Sotto lo sterno, c’è lo stomaco. A sinistra la milza, a destra il fegato e la cistifellea, e piú sotto l’intestino, l’utero, le ovaie. C’è ancora tutto. Niente è stato toccato. Sono ancora intera.
A mia madre hanno tolto la cistifellea, poi l’utero. A una donna che conosco, un seno. A un’altra tutti e due. A un ragazzo, hanno tagliato mezzo polmone. A un altro, un rene. A un altro ancora, un tratto di intestino.
Sull’inserto di un quotidiano, qualche mese fa ho visto la fotografia di una donna con una sola mammella. L’altra, diceva l’articolo che accompagnava la fotografia, le era stata asportata per un tumore. Ho staccato la pagina per conservarla. Lo scatto è in bianco e nero e la donna non sorride con le labbra, ma con gli occhi sí. Una donna di cinquant’anni, ancora molto attraente: capelli chiari, labbra piene, un volto bellissimo. Al posto della mammella asportata, la metà del petto segnata da una lunga e spessa cicatrice semicircolare, e sopra e attorno a quel taglio, il tatuaggio di un ramo fiorito. La fierezza in quegli occhi: sono viva, posso ancora amare e essere amata. I segni della battaglia, come per gli antichi guerrieri, sono gli ornamenti piú preziosi: ho sfidato la morte, mi sono buttato in bocca al nemico, e sono tornato. Sono ancora qui.
I corpi sopravvivono anche mutilati. Mutilati dal di dentro. Mutilati fuori. Il cuore continua a battere. Le funzioni essenziali a compiersi. Senza qualcosa, senza molto, senza moltissimo, lo stesso si può sopravvivere.
Non sono sola, in questa stanza.
C’è un uomo. Si muove leggero al di là di questa porta chiusa che sfioro con un dito. Posso sentire il suono dei suoi passi all’interno di quel perimetro in cui i percorsi sono percorsi obbligati: dall’armadio al letto, dal letto alla scrivania, dalla scrivania alla finestra. Il frusciare delle pagine di un libro tra le sue mani. Lo scatto secco dell’accendino.
Non so niente di lui.
Di te.
Ignoro il nome di tua madre, la forma del tuo sesso, l’odore della tua pelle sotto i vestiti, non so come fai l’amore, se sei buono o cattivo, se ti piace il mare oppure la montagna, se sai tenere le posate a tavola e conosci le regole della cavalleria – aprire e chiudere lo sportello della macchina, entrare in un ristorante prima della donna, versare il vino tenendo la bottiglia dal fondo e ruotando il polso alla fine con un gesto breve per non rovesciarne neanche una goccia –, non so neanche cosa c’è dentro il piccolo zaino nero che ti porti sempre dietro.
Quell’uomo sei tu.
Questa frase, mi sembra, raccoglie in sé ogni altra frase possibile, qualsiasi definizione diversa si dissolverebbe davanti a questa evidenza.
Dentro il bagno bianco e scintillante di luci della mia stanza d’hotel, mi appresto a compiere i gesti che mi iscrivono a pieno diritto in questa categoria: Donna. Una catena inscindibile di movimenti che hanno a che fare con la miglioria e la manutenzione. Mi prendo cura del mio corpo con una lucidità astratta che non ha niente a che vedere con la tenerezza, con la partecipazione, piuttosto, con la perizia di un cuoco che inietta la panna con la siringa dentro un bignè o capovolge con una torsione secca della mano uno sformato sopra un piatto da portata. Ispeziono ogni centimetro di pelle. Mi lavo i denti insistendo sulla zona posteriore, strofino persino la lingua, non prima di averla contemplata stirata davanti allo specchio. Strappo con una pinzetta qualche pelo invisibile dalle sopracciglia. Mi lavo con cura, strofino tra gli interstizi, spalmo la crema su tutto il corpo, deodoro le ascelle, spruzzo due gocce di profumo tra le pieghe dell’inguine, ripasso lo smalto trasparente sulle unghie dei piedi e attendo che si asciughi. Ora il mio corpo è a posto: plastificato e imbellettato come un cadavere della morgue. Prima, c’è stata la depilazione di gambe braccia ascelle labbro superiore e sopracciglia, la maschera all’acido glicolico al viso, pedicure e manicure, parrucchiere, doccia abbronzante. Senza uno solo di questi dettagli non sarei stata capace di arrivare fino qui. Eppure lo so – lo sappiamo tutte – che gli uomini non sono poi cosí attenti a queste cose. Siamo noi donne a osservare il nostro corpo con questo sguardo da macellaio, a suddividerlo mentalmente in pezzi: spalla-coscia-stinco-pancetta-salsicce.
Mi guardo un’ultima volta nello specchio. Il cuore batte violento sotto le costole. Ora dovrò uscire da questo bagno ed espormi al tuo sguardo. Cercare di essere disinvolta, di non sembrare troppo nervosa e neppure troppo sicura.
Sono una donna, perdonami.
Dentro la stanza 411 ci sono poche cose. Una valigia. La mia. Il tuo zaino nero. Gli abiti che indossavamo oggi appesi nell’armadio e sulla spalliera di una sedia.
Siamo in due.
Tu sei un uomo.
E io sono una donna.
È la prima volta che lo penso. Degli altri, quelli che sono venuti prima di te, pensavo: ragazzi. Di me davanti a loro, pensavo: bambina.
Hai gli occhi chiari. Un colore bellissimo. Il cielo di marzo quando è limpido, ma ancora freddo. Giornate strane, che potrebbero di colpo diventare di neve. Azzurro. Ma anche grigio. Sono trasparenti. A volte fanno paura. Non si scaldano mai.
Dentro la stanza 411 ci sono due letti accostati. Lenzuola color crema e pistacchio. Tappezzeria negli stessi toni. Sul soffitto, stucchi verde pallido e avorio. Una scrivania. Un grande specchio. Molto spazio. Una finestra che dà su una piazza. La piazza è enorme. Delimitata da posti di blocco. La città è Roma. Poco oltre, c’è il Pantheon.
Questa è una città nella quale vengo esclusivamente per impegni di lavoro. Mi ci perdo lo stesso, anche se i miei percorsi sono sempre identici. Arranco tra i turisti, lo sguardo basso, insensibile ai monumenti, alla Storia, ai miti. Salgo e scendo dai taxi, dai tram, dalle automobili e dai motorini di chi mi offre un passaggio. Attraverso le strade, urto i corpi di quelli che si fermano a guardare le vetrine. Scappo da questa città non appena ho finito di fare quello che devo fare: troppi turisti, appunto, troppi monumenti, troppa Storia, troppi miti. Troppo rumore e troppa luce. Da anni ormai, corro lungo via Nazionale verso la Stazione Termini con la borsa stretta al petto nella speranza di prendere al volo il primo autobus che mi avvicini a un treno, un Eurostar che in due ore e quarantacinque mi riporterà alla calma piatta, alla nebbia, al silenzio, al gelo micidiale o al caldo soffocante del posto di pianura dal quale vengo, che detesto e che non riesco a lasciare.
Se fossi io a dover scegliere, di sicuro non sceglierei un albergo come questo perché amo il verde degli alberi, e i posti decentrati, e invece qui sono proprio al centro della città – il centro esatto a giudicare dalla cartina –, assediata da questa metropoli che si estende attorno a me all’infinito, con i suoi quasi tre milioni di abitanti e le migliaia di turisti in transito, di automobili, tram, motorini, palazzi, ville, chiese, negozi, vie, viali, slarghi, sottopassaggi, parchi, piazze piccole e piazze grandi, scalinate, alberi, aiuole, cemento armato, vetro, mattoni, asfalto, fili elettrici, tubature, fogne, ratti, spazzatura, fibre ottiche, e ho paura. Me la sento premere addosso, questa quantità infinita di cose che si muovono, brulicano sottoterra, si innalzano verso il cielo e frusciano, raschiano, grattano, mangiano, si decompongono, fanno rumore.
Solo all’interno del Pantheon mi sento in salvo, al sicuro, come se mi trovassi nell’occhio del ciclone, nel punto preciso dove le forze contrastanti si annullano, e infine si disperdono.
Il Pantheon, con le sedici colonne grigie e rosse del suo pronao maestoso che incute paura. Otto monoliti di granito grigio e altri otto, quattro in seconda fila e quattro nella terza, di granito rosso egiziano. In realtà, la differenza di colore è appena percepibile, sembrano tutte uguali, e testardamente, a dispetto di quel che dice la guida, cerco ogni volta di convincermi che si sono sbagliati tutti, è solo il modo in cui le avvolge la luce a farne apparire alcune come appena un po’ sbiadite. Eccola l’enorme porta di bronzo, una delle tre antiche porte di Roma, un’entrata sobria e solenne, attraversata la quale si fanno pochi passi e si è già all’interno del tempio. È istantaneo, ogni volta che entro nel Pantheon, perdo la voce, le parole. Sollevo la testa verso l’alto, gli occhi feriti dalla luce che entra dall’occhio del tempio, e guardo il cielo. Immobile, al centro di quel cerchio magico, socchiudo le palpebre e i turisti spariscono, tutto sparisce, non sento piú niente, né il frusciare delle loro sportine di plastica, né i passi, le voci, i commenti, non sento le urla dei bambini, il clic o i beep beep delle macchine fotografiche. Tutto smette di accadere. Giapponesi e tedeschi, coreani, francesi, americani, tutti a bocca spalancata, la testa ribaltata all’indietro, la fronte battezzata da un fascio di luce lattea che acceca e intimidisce.