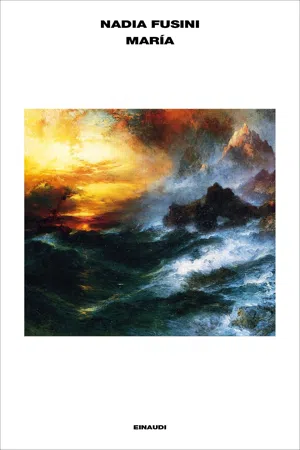Se fossi uno scrittore questo potrebbe essere un romanzo. Ma se ho scritto queste pagine non è con quell’idea. È che la storia di questa donna mi ha colpito, e non volevo dimenticarla. Cosí, tornato a casa, ho preso carta e penna – sí, ancora uso questi mezzi arcaici –, e ho cercato di ricordare per filo e per segno tutto quello che aveva detto. E nei mesi dopo che la vicenda s’era consumata e la donna era sparita – ora ne so poco o niente –, ho continuato a indagare, ho cercato altre prove, ho inseguito altri dettagli. Quando mi è arrivato per posta il suo diario, un quaderno a righe dalla copertina nera – quello sí che è stato un regalo che ho apprezzato molto. È come se mi avesse donato la sua vita, perché io potessi trasformarla in un romanzo. E anche se non pubblicherò mai queste pagine, nella mia testa io l’ho fatto, l’ho trasformata in un romanzo. Ma prima ancora l’aveva già fatto lei nelle sue pagine, dove in modo semplice, com’era lei del resto, aveva raccolto le impressioni dell’inizio della sua vita di donna sposata in un paese se non straniero, certo per lei molto, molto estraneo; impressioni che mi sono state quanto mai utili a capire. Capire che cosa? Quello che voglio capire – che penso sia quello che vogliono capire tutti, e cioè: perché si sta al mondo? Non è questa la domanda?
Già, ma per quale ragione ho scelto proprio questa donna? A questo interrogativo non so rispondere. Almeno ora, forse saprò rispondere alla fine. Fatto sta che la sua vicenda mi ha appassionato cosí tanto, che a un certo punto il suo destino è diventato piú importante della mia vita stessa. Non è stato affatto un gioco, anche se è vero che a me piacciono i giochi di pazienza, di incastro, gli enigmi e i rebus. Con pazienza mi sono dedicato alla ricostruzione del caso, non solo perché è il mio lavoro, e al mio lavoro io mi dedico con una passione forse spropositata; no, io cercavo qualcosa di piú del profilo di una vittima, o della colpevolezza di una complice. Cercavo il segreto di un’esistenza anonima.
Io stesso, del resto, che altro sono, se non un uomo semplice, un uomo qualunque? E proprio per questo, profondamente disturbato dal caos che mi circonda. E se dalla confusione non mi posso salvare, mi difendo come posso, a modo mio. Per esempio, applicandomi in modo ossessivo a ricostruire i misteri in cui mi trovo coinvolto. Mi piace rimettere insieme i pezzi, fino a ricostruire la figura intera, come in un puzzle. Sento cosí di consacrarmi all’unica potenza che rispetto – l’ordine, la chiarezza logica, una cosa che viene dopo un’altra, di conseguenza, come quando si scrive: sí, potrei dire che sono uno schiavo della scrittura, e in un certo senso sarebbe vero. Anzi, è proprio vero: solo quando scrivo, mi sento vivo. Quando scrivo presto la mia mano a un potere alieno, che non saprei come chiamare, forse destino. Quando scrivo sento che la mia mano collabora con una potenza impersonale, che mi guida a ritrovare un senso, uno qualsiasi, nell’esistenza umana. Perché il senso della vita m’interessa.
Nel caso della donna di cui parlo, grazie anche al suo diario, alla fine tutti i pezzi del puzzle si sono ricomposti, e ne è emersa la figura di un’esistenza umile e dannata. O almeno, ripeto, cosí a me pare. Comunque, non c’è nessuna fantasia, non c’è niente di inventato in quello che racconto, se c’è qualcosa di mio è la commozione. A volte, è vero, mi dilungo in dettagli che nel racconto lei aveva saltato e io ho ricostruito da solo, grazie alle mie ricerche. E al suo diario, ripeto. Ma non ho inventato le maglie della trama che mancavano nella storia. Sí, io scavo, scavo buche, apro tombe, dove María fa la morta, io a volte mi intrometto e suggerisco spiegazioni rispetto a episodi che a lei non pare di dover giustificare. Se si entra nell’esistenza di un altro, del resto, è difficile non portarvi un po’ del nostro proprio modo di vedere le cose. Anche senza volere, anche semplicemente nella punteggiatura, come nel fraseggio di un pezzo musicale, basta una pausa in piú, basta una virgola, e il significato cambia. In certi casi, lo confesso, quando le parole di lei non le ricordavo esattamente, le ho inventate – però ho cercato per lo piú di essere fedele. Non volevo certo parlare io, in prima persona. Io di mio non ho nulla da dire. A volte addirittura penso di non esistere: mi colpisce, ad esempio, come la gente si scordi di me, anche quella che incontro piú volte e che per un momento mi dà l’illusione di vedermi, di ascoltarmi. E se la gente si scorda di me, è perché io non sono nessuno. Non ho legami con nessuno: né moglie, né figli, né parenti. Sono l’uomo piú solo al mondo che io conosca. Però sto in mezzo agli altri e ascolto e osservo. E ho scoperto che c’è un che di teatrale in ogni esistenza. Anche nella vita di questa donna anonima, io l’ho capito subito che c’era un’odissea, un’avventura. Per questo volevo che parlasse, volevo sentire la sua voce. Perché nella sua voce ho subito riconosciuto la qualità che piú conta per me in una voce: l’umanità. Aveva una voce umana.
Visto il lavoro che faccio, ne ascolto tante di storie strane, aberranti, mostruose. E ne ho sentite di confessioni – gente che racconta con fervore o quietamente, o addirittura inconsapevolmente, i propri vizi e peccati e crimini e debolezze. Ma non sempre la voce che parla è umana. Spesso prevale un tono neutro, come se chi racconta vicende criminose avesse perso l’umanità nel fare quello che ha fatto. Le azioni non sono tutte uguali. Certe azioni che certi individui compiono li trasportano in un oltremondo, dove le cose non hanno piú un senso umano. Ecco, quando questo accade io lo sento dalla voce, che risulta falsa, fessa.
Invece in lei no, questo a lei non accadeva. Riusciva a raccontare quello che raccontava – cose angosciose, tremende, senza perdere la sua umanità.
A volte sento il bisogno di inventare nomi nuovi, di creare nuove parole. Perché pur nei non molti anni di vita che ho vissuto – ho poco piú di quarant’anni – mi rendo conto di avere visto svanire mondi, la Terra diventare un oceano senza limiti e senza punti fissi, enigmi abissali aprirsi al pensiero, e mi sono detto tante volte: come affrontare tutti questi cambiamenti con le parole che conosco? Invidio chi nel passato ha fabbricato parole nuove, invidio gli inventori di parole, invidio chi in un’epoca in cui non c’era piú nulla da scoprire sulla Terra, per contrasto s’è avventurato in terre di fantasia, sconosciute – e ha fatto sorgere cosí nuovi continenti di pensiero. E questo contrasto, badate, non è mai il frutto del caso, e penso a Vico, che ho studiato. E penso a Giordano Bruno, che ho letto con passione. Sí, ci sono stati uomini cosí, uomini che avendo conosciuto per intero tutto quello che c’era da conoscere nel loro mondo, hanno accettato il loro isolamento nel bel mezzo di un cosmo, che non era sovrastato da nessun oltremondo; e riconoscendo, voglio dire, che non si poteva piú cercare chissacché in un aldilà di qualsiasi tipo – a quel punto si sono dati a esplorazioni all’apparenza strane, stravaganti. Epperò necessarie. Comprendendo che non si poteva piú cercare sulla terra, né tantomeno sottoterra o nello spazio, un’origine, un senso, un orientamento, hanno cercato allora altre parole – parole sperimentali, parole che non fissano, parole che non concludono in identità o dottrine, parole semmai che tendono a scomparire e a lasciar esistere le cose che sono cosí come sono. Parole che aprono campi ignoti, territori che non rientrano in nessuna nominazione già data. È come se dei segni senza significato accessibile ai dizionari, addirittura senza rinvio a chi li ha fabbricati, venissero inventati per arrivare a formulare pensieri che non rimandano a nulla di già dato, a nulla di già disponibile. Ecco, questi segni io li penso come doni che nella loro piena irresolutezza ci coinvolgono in enigmi, che nel medesimo istante ci nutrono e ci avvelenano. Quel che ci nutre, ci avvelena: non è questo il punto? Non è questo il senso della vita stessa?
In effetti, chissà come, ma questo l’ho sempre saputo: non bisogna farsi ingannare dagli atteggiamenti di certezza che assumono certi filosofi, o teologi, o profeti, né tantomeno dare retta agli scienziati – questo mi diventa sempre piú chiaro. Gli scienziati, quelli veri, l’hanno sempre saputo che le loro sicurezze sono limitate, che viviamo in balia di un’ignoranza vertiginosa. Anche se a loro insaputa, hanno sempre saputo che siamo tutti schiavi, se non altro per via del fatto che il nostro intelletto è insufficiente, limitato. C’è evidente, chiara, una limitatezza costitutiva che consiste nel fatto di trovarci, noi umani, di fronte a cose che escono dal nulla e ci espongono al nulla, o a qualcosa che è lí per amore del gioco, del caso. Perché molta parte della nostra vita è arresa al caso. Non c’è dubbio. Chi può negarlo?
Lo dico subito, io non sono affatto un brav’uomo. Anzi, mi definirei piuttosto maligno – o ancora meglio, un uomo vuoto, una specie di sanguisuga –, non ho neppure una vita mia, l’ho detto, vivo delle vite degli altri. O forse sono un uomo malato, difatti il male mi interessa, e ho scoperto che spesso il male si confonde con la cattiveria, con l’ignoranza. E comunque, una cosa è certa, l’ho visto coi miei occhi – a forza di stare male, si diventa cattivi. È una questione di influenza per contatto prolungato, credo, e di abitudine. Si diventa cattivi per consuetudine, per stupidità. Per abitudine, ripeto. Per pigrizia. Ma c’è anche chi patisce il male, e non se ne infetta. Queste, secondo me, sono creature superiori. E a me piace tenerne il conto. Anche perché sono davvero rare. Ora, a dire proprio la verità – ed è del resto comprensibile, dato il mestiere che faccio, è comprensibile, ripeto, e lo confesso spontaneamente, che a me interessino i criminali, gli assassini, i ladri; insomma, la mala gente che capita qui dove lavoro. E proprio per questo, a dimostrazione che davvero mi piace il mio lavoro, tengo una statistica di quanti si salvano, di quanti soccombono.
Cosí, quando quel pomeriggio d’autunno d’un tratto, prima ancora di vedere chi fosse, nella stanza della Questura, dove io e l’appuntato Picciolini sedevamo piuttosto annoiati, sentii risuonare le parole: «Sono venuta a confessare un delitto» – subito alzai la testa. Picciolini e io avemmo addirittura un soprassalto, e quasi spaventati guardammo di fronte a noi: c’era una donna esile, anonima, scialba – non la si poteva credere un’assassina. Io d’istinto cercai il suo sguardo, perché sono abituato a cercare la verità negli occhi, piú che sulle labbra, ma lo sguardo di lei mi sfuggiva dietro le palpebre abbassate, forse per abitudine al pudore, piú che per vergogna, visto che veniva ad autodenunciarsi.
Di gente cosí, che si autodenuncia, a volte ne capita, e non c’è da fidarsi. Un sacco di poveracci vanno in giro a raccontare storie incredibili; il punto è che noi della Questura dobbiamo starli a sentire comunque, è il nostro dovere. Confesso che a me non dispiace affatto; a me piacciono le storie, e non mi chiedo se sono vere o false, l’importante è che abbiano coerenza e negli anni ho imparato a riconoscere quelle che ce l’hanno, anche se sono del tutto campate in aria. L’importante è che sia logica la struttura del racconto.
Chi s’inventa una storia è spesso un mitomane, un megalomane. C’è chi non li sopporta i mitomani, i megalomani, a me invece non dispiacciono affatto. Ci vuole una certa dose di grandezza e di fantasia per inventarsi degli intrecci, e a volte ho sentito raccontare storie che terrebbero il confronto con Shakespeare e Dostoevskij. E lo dico con cognizione di causa, lo dico perché lo so, perché anche se sono un poliziotto, sono comunque laureato, e Shakespeare e Dostoevskij li ho letti, e li rileggo spesso. Ma alla fine, devo riconoscere che a volte la realtà li supera. A volte arriva un povero cristo qualunque e ti racconta una storia, che Shakespeare e Dostoevskij non se la sognano nemmeno.
Cosí guardai con un certo interesse la donna, all’apparenza anonima, scialba. Però era una persona perbene, si vedeva. Su questo ci avrei giurato. Tra me e me mi dissi, chissà che s’è inventata questa qui, e sempre tra me e me mi preparavo a registrare la confessione nei minimi dettagli.
Io e Picciolini stiamo qui in Questura per questo: dobbiamo raccogliere le confessioni, registrare tutto. Se dicono la verità o mentono, non è un problema nostro, è un problema della giustizia; noi dobbiamo solo stendere il verbale, e a me piace farlo bene, è una specie di lavoro da copista, mi sento un monaco medievale, un amanuense. Copio anche piú volte lo stesso verbale, lo leggo e rileggo prima di darlo ai miei superiori. Ho acquisito una certa fama, ormai, qui in Questura. Col verbale della donna in questione la mia fama s’è accresciuta, e ne sono contento, soddisfatto, perché Dio sa quanto m’è costato.
La donna stava lí, ferma: ripeté una seconda volta che voleva fare una confessione, come fosse in trance. Non sembrava né drogata, né matta. Però era chiaro che non stava bene, si vedeva. Ebbi l’impressione che potesse svenire da un momento all’altro. Forse aveva la febbre, all’aspetto era debole, esausta. Pare una che abbia partorito da poco, mi dissi. Perché mi fece quest’impressione non lo so spiegare; forse per un non so che di languido, di umido, che aveva negli occhi e mi ricordò lo sguardo di una puerpera, che si fosse appena alzata dal letto.
Con gentilezza le dissi: «Sí, certo, aspetti un momento, si metta a sedere», e a Picciolini ordinai: «Va’ a chiamare la Vitale, sarà meglio che ci sia anche lei ad ascoltarla». Mentre le cercavo una sedia «intanto mi dica il suo nome, da dove viene», le chiesi. E lei subito rispose: «María, mi chiamo María, con l’accento». «L’accento?» feci io sorpreso. «Sí, c’è un accento sulla i. Si sbagliano sempre nei documenti. È il nome spagnolo della mia nonna andalusa, María. Mi chiamo María Liberati, – continuò quieta, compitando con precisione e con lentezza la sua identità. – Sono nata a Malo. Ma ora vengo da Trapani». Al che io la fermai: «Aspetti, ora arriva la dottoressa Vitale, potrà parlare con lei», dissi.
Con lentezza, con un certo sforzo, si abbandonò sulla sedia, quasi che scoprisse solo in quel momento quanto fosse stanca. E rimase lí, sulla sedia, docile, composta. Attendeva senza impazienza. A vederla avrei detto che era una persona istruita, sicuramente bene educata. Voglio dire, c’era in lei un contegno discreto, gentile sul serio, non per finta. Dev’essere una donna con un gran cuore, pensai. Il che, badate, non significa affatto che non potesse essere un’assassina, le cose sono piú complicate. Ne ho conosciuti di assassini che, a vederli, gli avresti affidato tuo figlio.
Teneva il volto abbassato di fronte a me, non mi guardava. Era persa in qualche pensiero che l’angosciava, questo si vedeva. Si vedeva da come respirava, dal tremito delle spalle. Alzò subito la testa, però, quando arrivò la dottoressa Vitale, la quale è sí una poliziotta, ma è anche psicologa, una donna con un’immensa esperienza che traspare nei modi – viene spontaneo fidarsi di lei per quella matura serenità che le brilla in faccia. Capii che all’assassina faceva piacere vedere un’altra donna. O perlomeno una donna cosí calorosa, cosí affabile, come la nostra dottoressa.
La Vitale la salutò con cortesia, e con un tono che faceva venire voglia di buttarsi tra le sue braccia la invitò ad andare con lei nel suo ufficio: «Ven...