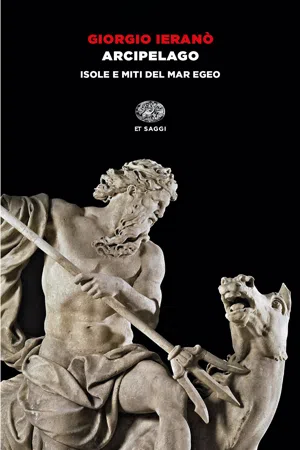Delo, la ninfa vagante.
Delo è un’isola piovuta giú dal cielo. Per questo il suo nome piú antico rimandava alle stelle: un tempo, infatti, si chiamava Asteria. In origine era una ninfa celeste, amata da Zeus. Per fuggire al signore dell’Olimpo, infaticabile molestatore di fanciulle, che la inseguiva eccitato dal desiderio, Asteria si gettò in mare. O, secondo altri, fu scagliata in mare da Zeus stesso, furibondo per il rifiuto. Intorno a questo tuffo la tradizione mitologica innesca una serie di altri prodigi. Prima di diventare un’isola Asteria si sarebbe infatti mutata in una quaglia. Questo racconto serve a spiegare un altro nome alternativo di Delo, Ortigia, che deriva appunto dal greco ortyx, «quaglia». Anche dopo essersi mutata in isola rimase tuttavia un luogo speciale, una terra vagabonda, in perenne movimento tra le acque, che appariva e poi si dileguava come un miraggio sulle onde dell’Egeo. Solo piú tardi, quando fu benedetta da Apollo e da sua sorella Artemide, prese a essere chiamata Delo, che significa «La luminosa». I due dèi le erano grati perché, sola tra tutte le terre, l’isola aveva osato ospitare la loro madre Latona quando era incinta di Zeus. Ogni altro luogo temeva la gelosia di Era: la regina dell’Olimpo, violenta e implacabile, non tollerava che il marito disseminasse per il mondo i figli avuti con le sue amanti. Ma la piccola Delo non ebbe paura: all’ombra di una palma, sul monte Cinzio, Latona poté cosí generare i due gemelli divini, Apollo e Artemide. Allora l’isola vagante fu ancorata ai fondali marini. Delo divenne il centro fulgido delle Cicladi, l’ombelico dell’Egeo. Da quel giorno, e per molti secoli a venire, sarebbe stata la piú santa tra tutte le isole del mare greco.
«Sacra, nel mezzo del mare, sorge una terra, carissima alla madre delle Nereidi e a Nettuno Egeo. Il dio dell’arco, a lei grato, mentre prima vagava di lido in lido, l’avvinse a Mykonos e all’eccelsa Gyaros: di essere immota le diede, di prendersi gioco dei venti». Cosí, nel terzo libro dell’Eneide (vv. 73 sgg.), Virgilio descrive Delo. Ma questi versi sono solo il punto di arrivo di una lunghissima tradizione che rimonta fino alla prima età arcaica. Non c’è poeta che non abbia cantato la gloria di Delo, a partire da un celebre Inno ad Apollo che gli antichi vollero attribuire addirittura al grande Omero. Anche in Pindaro troviamo una celebrazione ispirata dell’isola sacra:
Salve, suolo fondato dagli dèi, germoglio carissimo
ai figli di Latona dai ricci lucenti,
creatura del mare, dell’ampia terra
immoto prodigio, che i mortali
chiamano Delo, ma gli dèi beati d’Olimpo
astro lucente della terra scura.
Errava infatti un tempo
sulle onde ai soffi d’ogni vento:
ma quando la figlia di Ceo [Latona], nel delirio
delle doglie prossima al parto, vi pose piede,
allora, ecco, quattro diritte colonne
sorsero dal fondo del mare,
e con i capitelli sostennero
su ferrei piedistalli la roccia,
dove essa contemplò la prole
divina che aveva generato1.
Luogo ambiguo e sovrannaturale, al confine tra terra, mare e cielo, all’incrocio tra le stelle e le onde, Delo apparirà sempre come un prodigio. Persino nelle mappe medievali, essa figura spesso come il centro del mondo. Un primato che, a volte, le è conteso da Patmos, dove san Giovanni ebbe la rivelazione dell’Apocalisse: solo l’isola sacra dei cristiani, insomma, poteva fungere da alternativa all’isola sacra dei pagani. Anche i persiani, quando invasero la Grecia al tempo del re Dario, non osarono profanare Delo. Era l’anno 490 a.C. All’annuncio che la flotta dei barbari si stava avvicinando, gli abitanti dell’isola erano fuggiti nella vicina Tenos. Ma l’ammiraglio Datis mandò un araldo a rassicurare gli abitanti di Delo (Storie, VI, 99): «O uomini sacri, perché siete fuggiti, sospettandomi di intenzioni non buone? Io per me stesso sono saggio abbastanza, e per di piú anche dal re mi è stato ordinato di non recare alcun danno al paese ove nacquero i due dèi, né al territorio stesso né ai suoi abitanti. Ritornate dunque alle vostre case e continuate ad abitare la vostra isola»2. Datis bruciò anche una quantità immensa d’incenso sull’altare di Apollo a Delo, equivalente a ben trecento talenti. Poi riprese il mare, verso Maratona, dove gli opliti ateniesi lo attendevano sulla spiaggia.
È difficile oggi rendersi conto di quanto grande sia stata la gloria di Delo. L’isola è poco piú che uno scoglio battuto dai venti. I suoi templi e le sue case sono in rovina da millenni. Arida e afosa d’estate, s’anima soltanto in primavera, quando, tra le mura sbrecciate e le statue abbattute, si schiude un manto di fiori colorati. «La piccoletta Delo, celebrata per li versi de’ Poeti», come scriveva Tommaso Porcacchi3, è ora un deserto dove anche i turisti possono approdare soltanto durante il giorno. Di notte, nessuno può abitarla, e i resti di quello che è stato uno dei piú venerati santuari del mondo antico vengono consegnati al silenzio e ai bagliori della luna. Eppure, un tempo, a Delo i pellegrini affluivano da ogni angolo della Grecia. La sua fama era legata al tempio di Apollo che gareggiava in splendore con il santuario continentale di Delfi, dove la Pizia offriva i suoi responsi profetici. Apollo è divinità piú ambigua e oscura di quanto comunemente si usi credere. Se in una mano portava la cetra, nell’altra il dio impugnava l’arco: il signore della musica e del canto sapeva anche spargere la morte con le sue frecce micidiali. La sua prima apparizione, all’inizio dell’Iliade di Omero (I, 44 sgg.), quando scende dall’Olimpo per far strage di uomini e bestie nel campo degli achei, è sinistra e inquietante: «Scese dalle vette dell’Olimpo, il cuore gonfio d’ira; sulle spalle portava l’arco e la faretra, chiusa da entrambe le parti; risuonavano i dardi sulle sue spalle mentre avanzava in preda alla collera; veniva avanti, simile alla notte». Apollo, insomma, è tutto meno che apollineo. È il dio che purifica chi si è contaminato con un omicidio, come avviene a Oreste dopo che ha ucciso la madre Clitennestra. Ma è lui stesso un dio omicida, un dio «con il coltello in mano», come recita il titolo di un bel libro di Marcel Detienne4. Lo ha imparato a sue spese il povero satiro Marsia, che Apollo scuoiò come un animale dopo averlo vinto in una gara musicale.
A Delo, però, questo dio cosí furibondo, «simile alla notte», appare sempre luminoso e benigno. Nell’isola sacra, Apollo sembra deporre ogni rabbia omicida: qui egli è solo la divinità delle feste e della gioia, della musica e dei canti. Nell’Inno omerico che lo celebra viene narrata nel dettaglio l’origine del legame speciale che vincola il dio a Delo. Il poeta enumera, con un lungo catalogo, tutti i luoghi che hanno rifiutato di accogliere Latona, incinta di Zeus. L’infelice pellegrinaggio della madre divina termina infine quando Latona raggiunge l’isoletta che vaga per l’Egeo e le si rivolge cosí:
«Delo, vorresti forse essere la dimora di mio figlio,
Febo Apollo, e accogliere in te un pingue tempio?
Nessun altro mai si occuperà di te, né ti onorerà;
e io credo che tu non sarai davvero ricca di armenti, né di greggi,
né porterai raccolti, né produrrai molti alberi.
Ma se tu ospiti un tempio di Apollo arciere,
tutti gli uomini ti porteranno ecatombi
qui riunendosi; e da te sempre un infinito aroma
di grasso si leverà, e tu potrai nutrire il tuo popolo
per mano di stranieri: perché non hai ricchezza nel tuo suolo».
Cosí parlava; e Delo ne fu rallegrata, e rispondendo diceva:
«Leto, augusta figlia del possente Ceo,
di gran cuore, in verità, la nascita del dio arciere
accoglierei: infatti, io sono davvero eccessivamente oscura
fra gli uomini; cosí invece diventerei famosa.
Ma, non te lo nasconderò, Leto, io sono preoccupata per questa voce:
dicono infatti che Apollo sarà un dio oltre misura violento
e avrà un grande potere fra gl’immortali,
e fra gli uomini mortali, sulla terra feconda.
Perciò temo assai, nella mente e nel cuore,
che, quando egli vedrà per la prima volta la luce del sole,
dispregiando l’isola – poiché io sono invero una terra rocciosa –,
calcandomi coi piedi mi sprofondi nelle acque del mare.
Allora gli alti flutti senza numero, sul mio capo, per sempre
mi sommergeranno, ed egli se ne andrà in un altro paese che a lui piaccia,
per fare sorgere un tempio e un bosco sacro folto di alberi;
e i polipi su di me i loro covi, e le nere foche
le loro dimore faranno, al sicuro, perché io sarò deserta.
Ma se tu volessi, o dea, farmi un solenne giuramento
che qui, prima che altrove, egli edificherà uno splendido tempio
destinato a essere oracolo per gli uomini»5.
Delo, dunque, stringe un patto con Latona (la quale, peraltro, secondo una tradizione che risale già alla Teogonia di Esiodo, sarebbe stata sua sorella). Poiché conosce il lato oscuro di Apollo, vuole garantirsi di non essere vittima dei furori del dio. Latona promette, giurando sulle acque infernali dello Stige, che Delo sarebbe stata in eterno cara al figlio nascituro. Secoli dopo l’Inno omerico, un altro poeta, Callimaco, raffinato letterato e bibliotecario nell’Alessandria dei Tolomei, canterà la gloria dell’isola, descrivendo cosí, nel suo Inno a Delo, la nascita di Apollo: «Latona si sciolse la cintura e appoggiò le spalle al tronco di una palma, afflitta da un’oscura angoscia. Sulla pelle le scorreva umido il sudore. Sfinita e inquieta disse: “Perché, bambino mio, fai soffrire tua madre? Eccoti, mio amato, l’isola che naviga sul mare. Nasci, nasci, bambino mio, e dolcemente esci dal mio ventre”». È una vera e propria natività pagana che annuncia la gloria futura di Apollo. Come promesso, il dio farà di Delo il suo santuario prediletto. L’Inno omerico celebra le folle di pellegrini che giungono da ogni dove per festeggiare il dio:
Tu, o Febo, piú che di ogni altro luogo, ti compiaci nel tuo cuore di Delo,
dove per te si adunano gli Ioni dalle lunghe tuniche
coi loro figli e con le nobili spose;
essi, col pugilato, la danza ed il canto,
ti allietano, ricordandosi di te, quando bandiscono l’agone.
Chi fosse presente quando gli Ioni sono riuniti
direbbe che sono immortali, e immuni da vecchiezza in eterno:
potrebbe osservare la grazia comune a tutti, e si allieterebbe nell’animo
contemplando gli uomini, e le donne dalle belle cinture,
e le navi veloci, e le loro abbondanti ricchezze.
L’invenzione poetica rispecchia, da un lato, la realtà. Delo è effettivamente un centro di culto che raccoglie pellegrini da ogni dove e il dio vi viene celebrato con gare poetiche, cori e agoni atletici. Ma la realtà viene a sua volta trasfigurata in leggenda. Gli ioni che accorrono a Delo appaiono «immortali, e immuni da vecchiezza in eterno». Sull’isola sacra, sotto il segno di Apollo, sembra addirittura risorgere la favolosa età dell’oro. E al miracolo della Natività segue anche quello di una Pentecoste pagana. Uno spirito santo infonde nelle ragazze che formano i cori di Delo la virtú prodigiosa di sapersi esprimere in tutte le lingue. Si legge infatti nell’Inno omerico:
E v’è ancora una grande meraviglia, la cui gloria non perirà mai:
le fanciulle di Delo, ancelle del dio che colpisce lontano.
Esse dopo aver celebrato, primo fra tutti, Apollo,
e poi Leto e Artemide saettatrice,
rammentando gli eroi e le donne dei tempi antichi
intonano un inno, e incantano le stirpi degli uomini.
Di tutti gli uomini le voci e gli accenti
sanno imitare: ognuno direbbe d’essere lui stesso a parlare,
tanto bene si adegua il loro canto armonioso.
A Delo, crocevia del mondo, luogo d’incontro di tutti i sentieri del mare («Where all the waters meet», per parafrasare T. S. Eliot), nei tempi remoti era approdato anche il misterioso popolo degli iperborei. Questa stirpe favolosa, che abita nell’estremo Nord, «al di là di Borea», fa ogni tanto la sua enigmatica apparizione nelle saghe mitologiche. Gli iperborei sono spesso legati ad Apollo: si diceva che, ogni inverno, il dio abbandonasse la Grecia per rifugiarsi presso di loro. Erodoto (Storie, IV, 33-35) riferisce le leggende che legavano il popolo nordico all’isola sacra. Parla delle vergini iperboree, Iperoche e Laodice, che, un tempo, avrebbero raggiunto Delo portando offert...