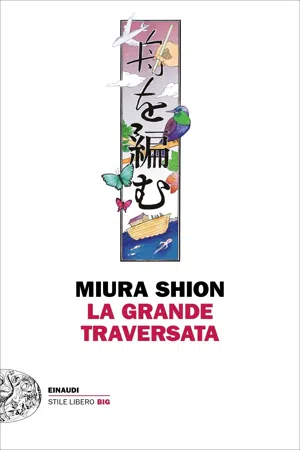Araki Kōhei aveva dedicato ai dizionari la sua intera vita lavorativa e non solo. Le parole lo avevano sempre affascinato, fin da bambino. Cane, tanto per citarne una: inu, che in giapponese può significare anche «non esserci». «Eppure il cane è sempre lí, basta solo nominarlo, ah ah ah!»… Era una delle tipiche battute che Araki si inventava tutti i giorni, roba da vecchi bacucchi che oggi farebbe storcere il naso a qualsiasi giovane impiegata. Le escogitava fin dai tempi della scuola, si divertiva a giocare con le parole già da piccolo e ne traeva un indicibile piacere.
Tornando all’esempio di prima, aveva imparato molto presto che il termine «cane» includeva altri significati, a parte quello dell’animale. Una volta suo padre lo aveva portato al cinema: sullo schermo, in primo piano, uno yakuza tradito e sanguinante esalava l’ultimo respiro gridando: «Maledetto, te la facevi con gli sbirri! Sei un cane bastardo!» In quell’istante Araki aveva appreso che, se un killer faceva la spia e ammazzava un membro del clan rivale, poteva essere chiamato «cane». Nella scena successiva, venuto a sapere che il fidato scagnozzo era stato freddato, il boss scattava in piedi e urlava con voce rabbiosa ai suoi uomini: «Che ci fate ancora qui, idioti? Non statevene lí impalati, datevi una mossa! Non dobbiamo lasciarlo morire come un cane, inutilmente!» Quindi la stessa parola poteva anche alludere a qualcosa di «vano» e «inutile».
Il cane è il miglior amico dell’uomo, fedele, simpatico e intelligente: lo dicevano tutti, eppure la parola «cane» poteva riferirsi a un vile traditore o a una situazione sterile e infruttuosa. Che strano! Nella sua mente di bambino, Araki cercava delle risposte. Fedele al punto da ridursi a un vuoto servilismo; devoto ma misero e patetico. Forse quelle caratteristiche canine, magari rare ma non da escludere, erano all’origine della possibile accezione negativa del termine.
A dispetto dell’interesse precoce per le parole, il primo vero incontro di Araki Kōhei con un dizionario non era avvenuto molto presto. I suoi genitori, che gestivano un piccolo negozio di casalinghi ed erano sempre occupati con la merce e i clienti, erano poco inclini a procurargliene uno ed esortarlo allo studio. Le loro idee sull’educazione dei figli, in linea con quelle della maggior parte dei genitori dell’epoca, si potevano sintetizzare piú o meno cosí: «L’importante è che il nostro ragazzo goda di piena salute e non si cacci nei guai, il resto conta poco o niente». D’altra parte, lo stesso Araki preferiva di gran lunga divertirsi all’aria aperta con gli amici anziché studiare. L’unico dizionario riposto su uno scaffale nell’aula della scuola elementare non aveva mai destato la sua attenzione. Era lí, triste e solitario, un semplice oggetto rettangolare il cui dorso entrava di rado nel suo campo visivo.
Tutto cambiò quando un caro zio gliene regalò uno in occasione della promozione alle medie. Nel momento in cui strinse tra le mani quel Dizionario della lingua giapponese Iwanami, ne rimase subito incantato. Il piacere di sfogliare un vocabolario suo era indescrivibile. La copertina lucida e bella, le pagine fitte di caratteri, la sensazione della carta sottile tra le dita. E, piú di ogni altra cosa, le definizioni esatte e concise.
Una sera, Araki e il fratello piú piccolo si erano messi a fare baldoria in soggiorno e il padre li aveva sgridati: – Ehi, abbassate la voce, voi due! – Allora Araki provò a cercare la parola koe («voce») nel dizionario e lesse la seguente definizione:
koe (sost.) 1. Insieme dei suoni che persone e animali producono per mezzo di un organo speciale situato nella gola. 2. Suono o manifestazione sonora corrispondente o simile a un’enunciazione vocale. 3. L’approssimarsi di una stagione o di una fase della vita.
Seguivano vari esempi sull’utilizzo della parola nelle diverse accezioni. Alcuni gli erano familiari, come koe o ageru («alzare la voce») o mushi no koe («il canto di un insetto»). Altri non li aveva mai sentiti: aki no koe («la voce dell’autunno») per esprimere l’arrivo imminente della stagione autunnale; yonjū no koe o kiku («ascoltare la voce dei quaranta») a indicare l’avvicinarsi di una persona ai quarant’anni. Per Araki si trattava di un concetto nuovo, inedito ma innegabile: il termine koe poteva comunicare molto bene «l’approssimarsi di una stagione o di un periodo della vita». Al pari di «cane», la parola abbracciava un ampio spettro semantico. Quel giorno Araki apprese che la lettura di un dizionario poteva permettere di scoprire nuovi significati di parole comuni, significati di una ricchezza e una profondità sorprendenti.
Tuttavia la seconda metà della frase all’inizio della definizione, «organo speciale situato nella gola», risultava alquanto criptica. Mettendo da parte il rimprovero del padre e la richiesta di attenzione del fratellino, Araki si affrettò a cercare anche i vocaboli tokushu («speciale») e kikan («organo»).
tokushu (agg.) 1. Di qualcosa che è diverso dall’ordinario; di natura specifica e particolare. 2. In filosofia: individuale in quanto opposto a universale.
kikan (sost.) Parte costituente di un organismo animale o vegetale dotato di morfologia propria e avente una determinata funzione fisiologica.
Leggere quelle definizioni non gli fu di grande aiuto, anzi lo rese ancora piú confuso. Preferí lasciar perdere, visto che per lui «l’organo speciale situato nella gola» non poteva riferirsi ad altro che alle corde vocali. E se a leggere quella spiegazione fosse stato qualcuno all’oscuro dell’esistenza delle corde vocali? In tal caso, «l’organo speciale situato nella gola» sarebbe rimasto avvolto in un alone di mistero.
Ma Araki non si perse d’animo. La constatazione che il dizionario Iwanami era in un certo senso imperfetto contribuí ad accrescere il suo entusiasmo. Alcune definizioni lasciavano un po’ a desiderare, ma era evidente il tentativo di avvicinarsi il piú possibile alla verità. In fondo erano proprio quei piccoli difetti a rendere vivi e palpabili lo sforzo e la passione dei compilatori. Quel lungo elenco di parole – lemmi, definizioni, esempi – appariva a un primo sguardo freddo e impersonale, ma a ben riflettere rappresentava nell’insieme il risultato del lavoro di un team che aveva ponderato con estrema attenzione ogni singola scelta. Persone che si erano consacrate chissà per quanto tempo a una missione incredibile, dimostrando una straordinaria pazienza e un profondo attaccamento alle parole.
Ben presto Araki iniziò a mettere da parte la paghetta settimanale per compiere periodiche incursioni nelle librerie dell’usato. Dopo che veniva pubblicata la nuova edizione di un determinato vocabolario, era facile procurarsi in tempi brevi e a un ottimo prezzo una copia della precedente. A poco a poco collezionò una serie di dizionari di varie case editrici e si impegnò in un’opera di confronto. Alcuni erano logori e rovinati, la copertina strappata, altri recavano una miriade di annotazioni a margine e sottolineature in rosso. Quei vecchi volumi mostravano i segni delle lunghe battaglie degli autori e degli utenti contro l’invincibile armata delle parole.
Araki sognava di diventare un filologo o uno studioso di linguistica giapponese e di vedere il proprio nome stampato sulla copertina di un vocabolario. Durante le vacanze estive del secondo anno di liceo, manifestò per la prima volta al padre l’intenzione di andare all’universitàa.
– Dici sul serio, vuoi studiare il giapponese? Ma tu già lo parli il giapponese, che ci vai a fare all’università?
– Ma che c’entra, papà! Non è questo il punto.
– E come la mettiamo con il negozio? Devi dare una mano, la schiena di tua madre va sempre peggio.
Niente da fare, Araki e suo padre erano su due lunghezze d’onda diverse. Per fortuna lo zio, lo stesso che alcuni anni prima gli aveva regalato l’Iwanami, prese a cuore il suo caso. Membro dell’equipaggio di una baleniera, quello zio aveva imparato ad apprezzare i dizionari nel corso delle lunghe ore di navigazione. In famiglia aveva la fama di essere una persona eccentrica. In occasione di una delle sue rare visite ai genitori di Araki aveva perorato la causa del nipote con parole sensate e appassionate.
– Dovete dargli una possibilità, Kōhei è un ragazzo intelligente e volenteroso come pochi, – aveva concluso. – Sarebbe un gran peccato non mandarlo all’università.
Alla fine il padre si era arreso e aveva accondisceso alla richiesta.
Il giovane Araki sgobbò giorno e notte sui libri e superò al primo tentativo il difficile esame di ammissione. Nel corso dei successivi quattro anni si rese conto di non avere le capacità e i requisiti necessari per diventare un bravo studioso, ma il suo desiderio di redigere un dizionario della lingua giapponese rimase intatto.
Durante il suo ultimo anno accademico, la casa editrice Shōgakukan iniziò a dare alle stampe il Grande dizionario della lingua giapponese. Si trattava di un’opera monumentale in venti volumi, per la quale erano stati necessari piú di dieci anni di lavoro e che contava circa quattrocentocinquantamila lemmi e tremila collaboratori. Una meraviglia del genere non era alla portata di uno studente squattrinato. Mentre passava in rassegna quei preziosi volumi nella biblioteca dell’università, Araki tremava per l’emozione pensando alla passione e al tempo investiti nella loro creazione. Sugli scaffali impolverati e silenziosi della biblioteca, il grande dizionario sembrava riflettere una luce pura come la luna piena nell’immensità del cielo notturno.
Araki Kōhei era consapevole che non sarebbe diventato uno studioso e non avrebbe mai visto il proprio nome sulla copertina di un vocabolario, ma sapeva che esisteva una strada alternativa da percorrere, nello stesso mondo: lavorare come editor in una casa editrice. Si attaccò a quell’idea con ogni forza, deciso a non mollarla. I dizionari erano la sua vita, non c’era nient’altro in cui desiderasse riversare il proprio tempo e la propria passione. Alla fine, dopo diversi colloqui, riuscí a farsi assumere da una nota casa editrice, la Genbu shobō.
– Da allora, per trentasette anni, ho lavorato solo ed esclusivamente ai dizionari.
– Davvero? È già passato tutto questo tempo?
– Sí. Del resto lei e io ci conosciamo da piú di trent’anni, professore. All’epoca aveva qualche capello in piú, o sbaglio?
Mentre pronunciava l’ultima frase, Araki rivolse lo sguardo alla testa pelata del professor Matsumoto, seduto dall’altra parte del tavolo.
Il suo interlocutore posò la matita con cui stava prendendo appunti e rise, facendo traballare quella sua figura smunta che ricordava una gru. – Invece sulla sua chioma si è accumulata un bel po’ di brina, eh, Araki? – replicò assottigliando gli occhi in un sorriso.
L’istante successivo servirono i piatti in tavola: zarusoba per entrambi. Era ora di pranzo, il ristorante era pieno di impiegati. I due uomini restarono in silenzio, concentrati a gustare il pasto. Mentre mangiava, Matsumoto, sempre sul chi va là alla ricerca di vocaboli e modi di dire inusuali, teneva un orecchio teso al flusso di parole che proveniva dal televisore, pronto a prendere nota servendosi di certe schede prestampate. Come al solito, Araki teneva gli occhi puntati sulle mani del commensale, perché sapeva che quando il professore si lasciava assorbire dalle parole era capace di provare a scrivere con le bacchette o di tirare su una manciata di soba con la matita. Il suo compito, in quel caso, era intervenire e riportarlo alla realtà.
Quando ebbero vuotato i rispettivi piatti, si rilassarono sorseggiando una tazza di mugicha freddo.
– Qual è stato il suo primo dizionario? – chiese Araki.
– Il Mare delle parole di Ōtsuki Fumihiko, lo ereditai da mio nonno. All’epoca ero un ragazzino… Quando scoprii che Ōtsuki aveva fatto tutto da solo, superando un mucchio di difficoltà, provai nei suoi confronti un’ammirazione sincera e profonda.
– Posso immaginarlo. A proposito, sono sicuro che come la maggior parte dei ragazzini anche lei si metteva a cercare qualche parolina sconcia, eh?
– No, macché!
– Il mio primo amore, come le ho già detto, è stato il dizionario Iwanami, che mi regalarono all’inizio della scuola media. Mi rintanavo nella mia stanza e lo sfogliavo freneticamente alla ricerca di parolacce e vocaboli osceni.
– Però quel dizionario è estremamente raffinato, decoroso. Immagino la sua delusione…
– Sí, ci rimanevo sempre molto male. Per chinchin, ad esempio, elencava tra i significati solo la capacità dei cani ben addestrati di stare dritti su due zampe e il borbottio dell’acqua che bolle nella pentola. Nessun riferimento a chinchin nel senso di «pisellino», «pistolino» e via dicendo… Suvvia, professore, non posso credere che non si sia mai incuriosito e non abbia provato a dare un’occhiata a certi termini.
Matsumoto ridacchiò divertito, senza smentire l’insinuazione di Araki.
La pausa pranzo volgeva al termine, da un momento all’altro il ristorante si era svuotato. La proprietaria si avvicinò al tavolo con una brocca in mano e versò ancora mugicha nei bicchieri.
– Ho il privilegio e la fortuna di collaborare con lei da moltissimo tempo, – disse a un certo punto Araki, – ma non avevamo mai avuto occasione di parlare dei nostri ricordi personali sui dizionari, sono contento.
– Sí, ha ragione, eppure il nostro lavoro sui dizionari va ava...