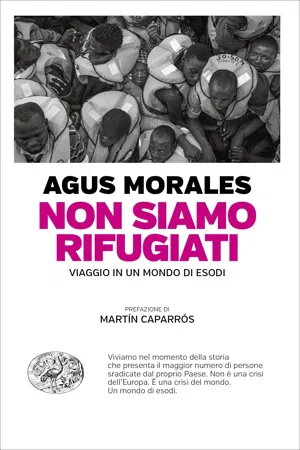Alcuni bambini salgono su una torre di legno nell’aeroporto di Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana. Giocano, si tirano le magliette, si mettono la mano sulla fronte a mo’ di visiera. Sarebbe una bella immagine, se non fosse che quello che stanno guardando non è un Boeing 787 sul punto di decollare, un autobus che trasporta passeggeri verso un volo internazionale, o personale di terra che gesticola sulla pista d’atterraggio. Ciò che stanno guardando è un’enorme macchia di tende ricavate da fragili teli di plastica, che si estende attraverso e su un terreno accidentato di orti e boscaglia. Quello che stanno guardando è un campo, limitato a est da un bosco e da un Tupolev russo, e a ovest da un minuscolo terminal. Quello che i bambini stanno guardando è la loro casa: un campo profughi nell’aeroporto.
Qui vivono oltre ventimila persone fuggite dalla guerra. Sono quasi tutti cristiani, scappati dagli attacchi della coalizione islamica Seleka nel dicembre del 2013. Questo terreno attaccato all’aeroporto era arrivato a dare alloggio a centomila persone: molte sono tornate a casa – o a ciò che restava della loro casa –, ma quelle che risiedevano nei quartieri in cui i conflitti erano stati piú forti si rifiutano di tornarci. Il tempo passa davanti all’indolenza della comunità internazionale, il tempo passa senza che il governo della Repubblica Centrafricana muova un dito, il tempo passa e tutta questa umanità continua a essere rinchiusa in questo territorio onirico, dove gli sfollati seminano orti, cercano l’ombra sotto le ali di ultraleggeri abbandonati e si tappano le orecchie ogni volta che c’è un atterraggio.
L’angolo piú pittoresco di questo campo sono gli hangar, che sono stati occupati dagli sfollati fin dall’inizio del conflitto. Cammino in uno di questi e mi sembra di visitare un negozio di antichità preso d’assalto dalla folla: sgabelli e tavoli capovolti; ultraleggeri sgangherati ricoperti dalla polvere e con le ali sollevate; asciugamani appesi alle ali, infradito incastrate negli interstizi dell’uccello metallico che la distruzione ha portato allo scoperto; armadi di un altro secolo, zanzariere, scope di saggina, secchi d’acqua, cuscini e ceste per i vestiti.
Questo è un centro di rottamazione aeroportuale a cielo aperto, abitato da persone che sono scappate terrorizzate alla ricerca di sicurezza. Perché qui? Quando un visitatore arriva a Bangui può pensare che tutte quelle persone accalcate siano lí in attesa di un aereo che le porti via dalla città o dal paese. No: si sono rifugiate nell’aeroporto perché qui era schierato un contingente militare francese e hanno pensato che fosse l’unico posto sicuro – suona come il Sud Sudan. Adesso i francesi se ne sono andati e sono stati sostituiti da una missione di caschi blu dell’ONU.
Non ci garantiscono una protezione totale, dicono gli sfollati, ma non abbiamo il coraggio di tornare.
Quando esco dall’hangar mi trovo davanti altri due aggeggi: un biplano rosso la cui elica invita i bambini a giocare e un ultraleggero bianco che non ha alcuna possibilità di essere aggiustato. Nessuna, davvero. Riparata all’ombra delle sue ali, una signora fa mazzetti di manioca. Mi avvicino a parlare con lei e mi invita subito a sedermi. Si chiama Mboudou.
– I musulmani hanno bruciato la nostra casa. Ci siamo rifugiati qui. Abbiamo perso tutto. Mio marito non riusciva a sopportarlo ed è morto di crepacuore, in questo campo. Sono rimasta vedova e con sette figli.
Inconsapevoli delle parole che la madre pronuncia con tristezza, i bambini ci circondano sotto l’ala dell’ultraleggero, girano intorno, osservano lo straniero; si aggiungono altre persone.
– Nessuno di loro va a scuola perché non ho i soldi per pagare l’iscrizione. Non abbiamo niente. Al mattino mi alzo, non facciamo colazione perché non abbiamo da mangiare, se ho qualche foglia di manioca mi metto qui a separarle fino a mezzogiorno, poi le trito e le cucino per dare da mangiare ai bambini. Non abbiamo nemmeno i soldi per condirle.
L’intera famiglia vive in una tenda situata proprio davanti all’entrata dell’hangar. In questo tipo di campi all’abituale sofferenza si aggiunge un fastidio: il suono assordante dell’aeroporto.
– Sono molto nervosa. Non riesco a dormire bene per colpa del rumore. I peggiori sono gli aerei grandi, quando decollano.
Dice Mboudou che è sola. Che ha paura di tornare a casa fino a quando le armi non saranno sparite dal suo quartiere. E supplica:
– La comunità internazionale ci deve aiutare. Deve disarmare i quartieri e aiutarci a uscire da qui.
Mboudou se ne vuole andare. In qualsiasi modo. È normale: intorno a lei, tutto è miseria e decadenza. La maggior parte delle tende non ha i classici teli dell’UNHCR, ma è coperta da semplici teli di plastica, e ci sono persino degli strappi rattoppati con sacchi della pattumiera. Adesso non c’è piú la stessa pressione demografica, ma all’inizio gli sfollati vivevano anche dentro gli aerei. Dopo aver salutato Mboudou, continuo la mia visita accompagnato da Luis Arias, coordinatore di Medici senza frontiere a M’Poko, che mi spiega i paradossi di questo insolito luogo.
– Questo è un governo che non esiste. Non ha la forza per cacciare via dal campo gli sfollati. La polizia qui dentro non può entrare. Ieri ci sono stati cinque feriti perché un musulmano ha provato a rubare una moto-taxi guidata da un uomo che è risultato essere un soldato centrafricano e che, in tutta risposta, ha lanciato una granata.
Camminiamo lungo il campo diretti al terminal. Fra le tende, spunta l’ala di un cargo Tupolev bianco con una striscia blu dipinta sopra, e che sembra prepararsi al decollo. Rumore di turbine, vibrazione dell’orizzonte: pienezza della confusione.
– Ogni volta che un aereo decolla, mi devo tenere per non cadere. Questo è terribile per i piccoli, – dice Marcel, capo di uno dei quartieri del campo, mentre stringe uno dei bastoni che sorreggono la sua tenda.
Dietro al Tupolev ci sono un aereo commerciale e ultraleggeri dell’ONU e delle ONG. Ora costeggiamo il limite del campo: ci sono solo spighe, erbacce e un canale d’acqua tra gli aerei e la gente. Ci allontaniamo dal terminal e ci incamminiamo verso la pista.
– Venite qui e fate finta di prendere appunti! – mi urla una signora che mi vede annotare sul taccuino queste impressioni. – E poi ci lasciate qui, senza cibo né niente!
Non dico nulla. Deglutisco.
Ha ragione.
Inciampo in una linea gialla che unisce il campo all’asfalto della pista. Lí circolano moto e addirittura macchine, un uomo che sta caricando della paglia, bambini che vanno a fare commissioni. Sí: la pista dell’aeroporto – l’unica pista –, adesso è un grande corso pieno di vita, con un traffico persino ordinato, per niente africano: atmosfera da domenica. Improvvisamente, caschi blu camerunensi su un veicolo militare iniziano a pattugliare tutta la pista. Hanno attivato il protocollo del decollo: devono liberare l’asfalto perché l’aereo possa partire. Piano piano il traffico si ferma. Gli ultimi si affrettano, come fosse un attraversamento pedonale e stesse lampeggiando il semaforo verde. Passa un signore con una carretta e il soldato camerunense lo lascia passare come per dire: «L’ultimo, eh».
Appare il Tupolev che avevamo visto accanto al terminal. Alcuni lo guardano come fosse la prima volta. Altri sono già abituati. L’aereo gira per prepararsi al decollo, solleva polvere, c’è un gran putiferio: dalla mia posizione – a circa cinquecento metri – sembra che le persone del campo siano sotto le turbine, c’è una foglia che gira accanto a me, i soldati camerunensi, con le pettorine arancioni, sorreggono i loro fucili e aspettano la partenza dell’aereo – ma chiunque potrebbe entrare sulla pista e far precipitare tutto nel caos –, l’erba si muove come le onde – onde libiche, onde del Mediterraneo, penso io – l’aereo si mette in moto, prende velocità, i bambini urlano, fumo marrone e bianco, solo qualche secondo di rumore e già vola sul piú grande campo profughi della Repubblica Centrafricana.
Dopo il decollo, torniamo dalla pista agli hangar. I due punti sono uniti da una sorta di corso: negozi di musica, signore che friggono teste di pesce, altre motociclette. La linea gialla non mente: sebbene ormai non lo sembri piú, questo corso era la pista di atterraggio degli ultraleggeri. Un’altra donna ci inveisce contro, cosa nient’affatto abituale nei campi.
– Adesso è tutto piú o meno tranquillo, – dice Luis, – ma pensa che qui una granata costa 150 franchi [30 centesimi di euro]. Alcuni seppelliscono granate accanto ai kalashnikov, sotto le tende.
Lungo il tragitto conosco Augustine, un uomo di sessantatre anni. Iniziamo a parlare e si tappa le orecchie con le mani.
– Qui c’è tanto rumore. Quando un aereo atterra, si svegliano tutti.
Parla con me in una tenda, ma la sua famiglia, composta da trentasette membri, ne occupa diverse altre nella zona.
– Non mi piace questo campo, me ne voglio andare e tornare nel mio quartiere, con la mia famiglia. Se è sicuro e c’è un processo di disarmo, voglio tornare.
Dice Augustine – una maglietta taroccata con l’emblema della Spagna, barba rada, sguardo perso – che è strano vivere in un aeroporto, che i bambini non vanno a scuola, che quando piove è tutto un disastro, che le condizioni di vita sono precarie, che vogliono tornare. E poi, la stessa rabbia di Mboudou, la donna con cui avevo parlato sotto l’ala dell’aereo.
– Adesso non possiamo tornare, è tutto distrutto. Non possiamo vivere circondati dalle armi. Il governo non sta facendo niente. Chiedo alla comunità internazionale di trovare una soluzione e di tirarci fuori da questo campo.
Nel terminal – cosí lontano, cosí vicino – un elicottero dell’ONU si prepara a decollare.
La colonia francese meno strategica, la Cenerentola dell’impero, la colonie poubelle – secchio della spazzatura – poteva essere in un solo posto: in mezzo all’Africa. All’inizio, la Repubblica Centrafricana aveva un nome che rispecchiava la sua doppia identità. Si chiamava Ubangi-Shari, per via dei fiumi che dominano la sua geografia. Il fiume Ubangi scorre dalla capitale, Bangui, e sbocca nel Sud: è il piú grande affluente del fiume Congo. Il fiume Shari nasce nel centro del paese e sfocia al Nord: nel lago Ciad. In questo dualismo è già scritta la sua vaga forma di esistere, la sua mancanza di carattere, il suo squilibrio territoriale. Qui non c’è un centro, è tutto periferia: una parte della nazione – quella dell’Ubangi – è collegata alla pura Africa subsahariana: l’esuberanza, la foresta, la regione dei Grandi Laghi e il fatalismo, le perenni guerre della Repubblica Democratica del Congo, i Kivu, il Ruanda. L’altra parte – quella dello Shari – guarda verso il Sahel, verso il deserto arabo, verso il Ciad e il Sudan e verso le reti commerciali che le sue genti hanno tessuto per decenni. Le periferie di questo Stato hanno molti piú rapporti con altre regioni – Grandi Laghi, Sahel – che con il proprio stesso centro. Questo territorio è una periferia della periferia.
Nel centro dell’Africa non c’è niente.
Repubblica Centrafricana. Persino al suo nome manca personalità e in piú, come succede spesso, ci riferiamo a lei usando la sua sigla: RCA. Per buona parte della sua storia, il paese fu una zona di passaggio e di rifugio per i grandi movimenti dei popoli: prima propiziati dal commercio di schiavi africani, poi dalle guerre che pesarono sulla regione. Nel centro: nessuno. La Repubblica Centrafricana è piú grande della Penisola iberica e ha una popolazione di appena quattro milioni e mezzo di persone.
Formalmente, la Repubblica Centrafricana ha raggiunto l’indipendenza dalla Francia nel 1960, ma in pratica i «galli» la continuano ad amministrare come se fosse una colonia. Quando arrivò il momento di camminare sulle proprie gambe, la nazione aveva soltanto un ospedale e il territorio era stato gestito per decenni da imprese coloniali che contribuirono a instaurarvi la cultura del clientelismo. Lo Stato si trasformò nel predatore di se stesso: in un organismo inerte che viveva dell’economia dei diamanti e dell’oro, dei «morsi» del suo padrone francese. Forse la Repubblica Centrafricana dice qualcosa al pubblico occidentale per via del nome di Jean-Bédel Bokassa, che poi si convertí all’Islam e si fece ribattezzare come Salah Eddine Ahmed Bokassa: anche nel suo piú importante autocrate si legge la confusione identitaria centrafricana. Si fece chiamare imperatore Bokassa I. In Occidente, la sua stravagante figura, condita da generose dosi di razzismo e sensazionalismo, venne associata a tutti i cliché sulle élite africane: la sua fastosa incoronazione imperiale, il suo presunto cannibalismo, il suo insaziabile a...