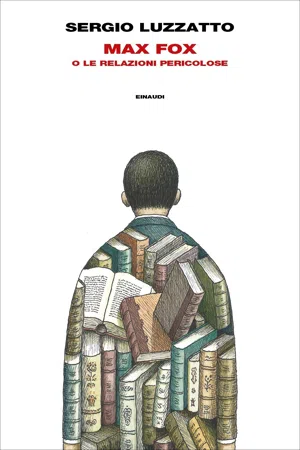Aperta a Milano il 15 marzo 2007, la XVIII Mostra del libro antico ha trovato spazio, come al solito, sulle colonne del «Corriere della Sera». Come al solito, attraverso la penna di Armando Torno. Che l’ha definita «zeppa di sorprese», in particolare grazie all’approdo al Palazzo della Permanente di un’eccezionale «collezione galileiana»: neanche a dirlo, la collezione di Massimo De Caro. Dalla presunta vendita segreta del 2004 in poi, questa era stata oggetto di trattative riservate che l’avevano fatta passare per Parigi e per Chartres, oltreché per la cassetta di sicurezza della banca svizzera dove normalmente veniva custodita. Ed ecco che la collezione era ritornata sul mercato, al prezzo (si vociferava sul «Corriere») di dieci milioni di euro. Nel suo articolo sulla Mostra, Torno segnalava anche la prossima attivazione a Milano – da parte di Marcello Dell’Utri e della Biblioteca di via Senato – di un master in Economia del libro antico: «il primo corso post-universitario in questa materia, in collaborazione con l’Università di Oxford». Si trattava, evidentemente, del progetto didattico affidato alle cure di Michelangelo Zaccarello. Sebbene non riuscissero chiari i termini della sbandierata sinergia tra l’Università di Oxford e la fondazione del senatore-bibliofilo.
Ma il titolo dell’articolo di Torno non era dedicato né alla collezione di De Caro, né al master di Dell’Utri. Per la mostra del libro antico «Pasque di sangue» a 600 euro: la titolazione del «Corriere» riguardava un libro moderno, modernissimo, scritto da un professore italo-israeliano di storia medievale e pubblicato un mese prima dalle edizioni del Mulino. In Pasque di sangue. Ebrei d’Europa e omicidi rituali, Ariel Toaff suggeriva che l’«accusa del sangue» rivolta per secoli alle comunità ebraiche della diaspora – l’accusa di rapire e uccidere bambini cristiani, per utilizzarne il sangue nei riti della pasqua – non fosse stata, sempre e dovunque, una pura e semplice invenzione antisemita. Dal Trecento al Quattrocento, si sosteneva in Pasque di sangue, entro una vasta area geografica a cavallo della catena alpina, certi fondamentalisti dell’ebraismo avevano realmente compiuto omicidi rituali, per la valenza insieme mistica e terapeutica attribuita al sangue dalla cultura medievale. Senonché il libro di Toaff aveva fatto scandalo, quanto poche altre monografie accademiche avessero mai fatto nella storia dell’Italia contemporanea.
Il primo lettore in assoluto a recensire Pasque di sangue – e a recensirlo in termini ampiamente elogiativi – ero stato io. Il 6 febbraio di quel 2007, proprio sulle pagine del «Corriere della Sera». Perciò ero rimasto coinvolto, durante le settimane successive, nella polemica scatenata contro Ariel Toaff sia da una sedicente intellighenzia ebraica legata alle comunità israelitiche italiane, sia dai miei stessi colleghi, dalla corporazione universitaria degli storici. Feroce nel metodo quanto pretestuosa nel merito, la polemica si era tradotta in una specie di fatwā laico-religiosa che aveva indotto Toaff, addirittura, a chiedere al Mulino il ritiro del libro dal mercato: con il risultato di aumentarne il valore agli occhi dei bibliofili. Si spiegava cosí il titolo dell’articolo di Torno, su Pasque di sangue in vendita alla Permanente per 600 euro. Bella cifra davvero, per una monografia specialistica che il Mulino aveva mandato in libreria, nei primi giorni di febbraio, al prezzo di copertina di 25 euro.
All’epoca, io ignoravo l’esistenza di Marino Massimo De Caro. Né l’avrei scoperta prima del 30 marzo 2012, prima dello scandalo dei Girolamini. Avevo probabilmente letto, sul «Corriere», i diversi pezzi in cui Torno aveva vantato una collezione galileiana da capogiro; ma non avevo avuto modo di collegare le meraviglie della collezione all’identità di un proprietario. Inoltre, non essendo un bibliofilo, ignoravo l’esistenza di una libreria antiquaria di Verona chiamata Imago Mundi Italia, cosí come ignoravo l’esistenza di una libreria Imago Mundi a Buenos Aires. E piú che mai ignoravo le imprese di De Caro da ladro di libri e da falsario di Galileo. Eppure, ripensandoci oggi – dieci anni dopo – io mi dico che esiste un nesso fra la XVIII Mostra del libro antico, con Pasque di sangue in vendita a 600 euro, e il mio ritrovarmi qui adesso, nell’anno di grazia 2017, a scrivere la storia di De Caro come la relazione pericolosa fra uno storico e il suo impostore. E mi dico che non si tratta di un rapporto casuale. Si tratta di un rapporto causale, governato da un nesso tra la causa e l’effetto.
Perché il «caso Toaff» ha avuto su di me l’effetto di una duplice rivelazione. Da un lato, la disonestà intellettuale con cui un mite professore di storia medievale è stato pubblicamente aggredito per avere compiuto, da studioso vero, una ricerca libera e coraggiosa; la canea scatenata dai maggiori storici italiani contro un collega operante in un ambiente difficile com’è quello di Israele, al punto di mettere a rischio (letteralmente) la sua incolumità fisica, mi sono valse da corso accelerato sull’uso pubblico della storia quale professione di malafede. Dall’altro lato, gli inciampi stessi dell’argomentazione storiografica di Toaff, le difficoltà in cui l’autore di Pasque di sangue si è trovato nel dimostrare la piena pertinenza della sua ricostruzione (fino alla scelta di pubblicare, un anno dopo la prima edizione, una versione emendata del medesimo libro), mi hanno spinto a interrogarmi senza compiacenza intorno allo statuto scientifico del mestiere di storico. E anche, da ultimo, intorno alla mia credibilità di studioso. Dopo il caso Toaff, non sono piú stato altrettanto fiducioso di prima che il buono storico riesca sempre, volendolo, a restare immune dalla contaminazione ambientale. Né che il buono storico riesca sempre, volendolo, a distinguere il vero dal falso.
Una riprova dei rischi del mestiere sarebbe venuta da una conferenza stampa organizzata a Padova il 26 marzo 2007: appena una settimana dopo la chiusura, a Milano, della XVIII Mostra del libro antico. O piuttosto sarebbe venuta da un «ristretto incontro al Palazzo Bo, sede dell’Università patavina», al quale era stato invitato il giornalista scientifico Giovanni Caprara. Cosí Galileo dipinse la Luna: nell’articolo pubblicato l’indomani sulla prima pagina del «Corriere della Sera», il veronese Caprara dava voce – con il corredo di abbondante documentazione iconografica – alle sensazionali rivelazioni di due professori autorevoli, lo storico dell’arte tedesco Horst Bredekamp, della Humboldt-Universität di Berlino, e lo storico della scienza canadese William R. Shea, titolare della Cattedra galileiana dell’Università di Padova. Stando ai quali era stata recentemente scoperta, per il tramite di un libraio antiquario newyorkese, una copia sconosciuta della prima edizione del Sidereus Nuncius di Galileo Galilei. Piú che un esemplare eccezionale, un esemplare unico, le cui cinque incisioni della Luna erano state disegnate e acquarellate, nel Seicento, dall’autore in persona: da un Galileo ormai storicamente qualificabile, oltreché come scienziato di genio, come artista d’eccellenza.
Sul «Corriere» del 27 marzo 2007, i due «scopritori» avevano diritto a un box con i rispettivi ritratti fotografici. Quel che piú conta, i due autorevoli storici avevano l’opportunità di insistere sull’unicità del ritrovamento: «“Quando, dopo le indagini, mi sono reso [conto] di non avere davanti agli occhi un falso, come inizialmente sospettavo, mi sono commosso: da almeno un secolo non si era piú trovato un documento di Galileo tanto importante”, confessa Bredekamp». Sí, la copia rinvenuta del Sidereus Nuncius, contenente i «cinque acquerelli, disegnati e colorati da Galileo Galilei direttamente negli spazi liberi di alcune pagine», appariva incontrovertibilmente come autentica. E fra gli esemplari a noi giunti di quel libro decisivo per la storia intellettuale dell’Occidente, «racconta Bredekamp, […] “il piú prezioso è questa prima copia che era una sorta di prova completata per mano galileiana. Non ci sono dubbi sull’analisi della carta e del colore di origine vegetale che lui scelse e i tratti rivelano un disegnatore raffinato. Sono totalmente sicuro”».
Dov’era stata rinvenuta la «preziosissima opera»? E, soprattutto, dov’era rimasta confinata per quattro secoli, dal marzo 1610 agli albori del terzo millennio? «“È un enigma – dice Shea – e già questo poneva anche me, inizialmente, in una condizione di grande scetticismo”». Salvo inchinarsi all’evidenza delle perizie realizzate, in Germania, da istituti tecnico-scientifici d’avanguardia. E salvo ipotizzare una ragione plausibile per la plurisecolare eclissi dell’opera. «“L’antiquario non rivela la persona da cui l’ha acquistata” racconta Shea, “dice soltanto che proviene dal Sudamerica. È probabile un’origine argentina dove ci sono numerosi italiani provenienti dal Veneto. Forse Galileo aveva regalato il volume a qualche senatore della Serenissima e forse era stata venduta per denaro o per ignoranza”».
Habent sua fata libelli. Dopo lo scoop del «Corriere della Sera», le rivelazioni sul ritrovamento di un esemplare del Sidereus Nuncius acquarellato da Galileo hanno fatto il giro del mondo. Sono state rilanciate dalle pagine culturali dei quotidiani spagnoli «El País» e «El Mundo», del settimanale tedesco «Der Spiegel», del quotidiano argentino «La Nación», del settimanale americano «Time», di varie altre testate della maggiore stampa internazionale. Le guardo oggi sullo schermo del mio computer, quelle pagine culturali, traduco mentalmente le loro enfatiche titolazioni – La Luna vista por Galileo, Descubren los dibujos de la luna realizados por Galileo, Galileis erste Mond-Bilder entdeckt, Después de 400 años, encuentran cinco acuarelas inéditas de Galileo Galilei, Galileo’s Moon View – e provo a immaginarmi come abbia reagito allora, nel leggerle, Marino Massimo De Caro. Provo a vederlo, il sorriso di trionfo disegnato sulla faccia larga e bonaria dell’autore della burla.
E se la Generazione Bim Bum Bam potesse essere definita anche – fra gli altri suoi caratteri – come la generazione dei falsi Modigliani? Come la generazione, cioè, degli italiani che si sono affacciati sul mondo dei loro genitori, sulla vita adulta del Belpaese, attraverso la burla delle sculture ritrovate nel Fosso Reale di Livorno, corrente l’estate del 1984?
Nessuno in Italia avrebbe piú dimenticato quello scherzo. Concepito e realizzato da tre giovanotti livornesi, ventenni buontemponi, sulla base di una leggenda locale secondo cui il vero Amedeo Modigliani, nel 1909, aveva gettato nelle acque del Fosso Reale tre o quattro sue sculture, per la rabbia di non vederle apprezzate dagli amici artisti del Caffè Bardi. Da qui l’idea di Vera Durbè, direttrice del Museo d’arte moderna di Livorno, nel centenario della nascita di Modigliani: far dragare il fossato, annunciando urbi et orbi di voler ritrovare le sculture perdute. E da qui la beffa dei tre giovani toscanacci, che in quattro e quattr’otto scolpiscono una testa a colpi di trapano Black & Decker e la gettano nel Fosso Reale. Si susseguono – in rapida successione – il ritrovamento con la ruspa, in favore di telecamere del Tg, della testa fabbricata con il trapano (e addirittura di un paio d’altre, riemerse come per miracolo). Il pronunciamento di alcuni fra i piú illustri storici dell’arte della Penisola, le sculture sono genuine, questo è Modigliani. Le prime perizie tecnico-scientifiche, che paiono confermare l’autenticità delle teste. L’interesse sempre piú acceso dei media italiani e stranieri. Fino al crudele disvelamento, i tre buontemponi che confessano lo scherzo al settimanale «Panorama», con la fotografia degli emuli di Modí sorridenti accanto al loro capolavoro, prima di gettarlo in acqua.
La pensata di dragare il Fosso Reale non tanto alla ricerca delle leggendarie sculture vere di Modigliani, quanto piuttosto per una trovata di comunicazione; lo scherzo dei tre giovanotti come sfida al sapere dei maestri, autoelogio dell’incompetenza; la crisi dell’autorità dei dotti, trionfalmente sbertucciati dagli incolti; il seme del dubbio intorno al confine (o alla confusione) tra il reale e il virtuale; perfino l’intuizione, piú o meno chiara, della potenza delle fake news: l’intera vicenda dei falsi Modigliani va oggi riletta come l’estemporaneo assaggio di un mondo a venire. Piú che un mondo post-moderno o post-ideologico, già un mondo post-verità: il mondo di Marino Massimo De Caro. «E allora a me aveva sempre affascinato, fin da bambino, anche quel discorso del… dei falsi Modigliani, no?, de… [ride] della burla…» «Nel 1984, o ’85, me lo ricordo, io, […] sui telegiornali dell’epoca». «Mi ricordo che già allora… perché comunque a me l’antico era sempre piaciuto… mi aveva affascinato, anche allora, questa cosa qui»: dixit De Caro, dialogando su Skype. Dopodiché (è fin troppo ovvio) non tutti gli italiani che avevano undici anni nel 1984 sarebbero divenuti, sotto l’influenza burlesca dei falsi Modigliani, falsari a loro volta. L’appartenenza di De Caro alla Generazione Bim Bum Bam non implica l’appartenenza della Generazione Bim Bum Bam alla specie De Caro.
Sculture di Modigliani a parte, la preistoria del falsario di Galileo affonda le sue radici psicologiche – forse – nel trauma subito a Siena dallo studente universitario fuori sede. Nello choc dell’ex ragazzo prodigio di Orvieto risvegliatosi, nella città del Palio, dapprima come matricola fallita di Scienze economiche e bancarie, quindi come studente a rilento di Giurisprudenza. E la preistoria del falsario di Galileo affonda le sue radici nell’amore di quello studente fuori sede e fuori corso per la materialità dei libri antichi – per la carta, la colla, le legature, i frontespizi, le incisioni – molto piú che per la spiritualità dei libri moderni, per le teorie insegnate dai docenti universitari nei loro manuali e nelle loro lezioni. «Un po’, se vuoi, il dibattito… senza per niente paragonarmi… ma il dibattito, no?, che c’era nel Seicento tra gli aristotelici e quelli che volevano la “sensata esperienza”». «Cioè, per me, il mondo accademico sono gli aristotelici. Per loro conta solamente il libro. Invece quello che crea la conoscenza, secondo me, è la quotidianità, è l’esperienza. E quella, a tantissimi manca».
Piú a monte ancora che negli anni d’università, le radici psicologiche della burla del Galileo come sfida all’autorità dei maestri vanno cercate – forse – nell’infanzia di Massimo De Caro: in un freudiano rigetto del modello di vita incarnato dai suoi genitori, e dai loro colleghi di scuola o di sindacato. Tale, quanto meno, suona la spiegazione retrospettiva dello stesso De Caro. Già alle elementari, a Merano, e poi alle medie e al liceo, a Orvieto, «io, in realtà, li guardavo un po’ con disprezzo i professori, e i maestri. Perché? Perché erano quelli con cui passavano il tempo sempre i miei genitori, e sentivo i loro discorsi, no? Che per la maggior parte erano: vogliamo l’aumento di stipendio, vogliamo questo… e quindi…» Dietro i paroloni sull’etica pubblica e sui lavoratori della conoscenza, il figlio di Stefano De Caro e Lucia Motti non coglieva che interessi minuti e mediocri, striminzite logiche corporative. «Ai miei occhi, siccome io ogni giorno avevo a che fare con loro e sentivo i loro discorsi, perdevano quella sacralità che avrebbe dovuto avere il tuo magister, capito?, il tuo didaskalos, capito? Quindi, ecco, diciamo… mi ponevo… non dico al loro livello, ma anche a un livello superiore…» «Non gli riconoscevo autorità, capito qual è il problema?» Tranquillo, ho la sensazione di capirlo sempre meglio.
Infine – a valle di tutto questo – ci sono le praterie esistenziali dell’Argentina: c’è la libera uscita di Massimo De Caro verso un Nuovo Mondo da scoprire, da conquistare, da stupire, da gabbare. A valle c’è il fervore di Buenos Aires, e c’è l’influenza di Daniel Pastore: il giovane librario antiquario di Imago Mundi, ma anche (nelle parole di De Caro su Skype) «un bambino discolo che deve dissacrare tutto. E quindi anche la sua preparazione, la sua cultura… lui la dissacra». Sicché la storia del falso Galileo come burla giocata a un’internazionale dell’accademia è anche la storia della fascinazione esercitata da Pastore su De Caro; ed è la storia dell’aspirazione di De Caro a impressionare l’amico mostrandosi piú dissacrante ancora di lui. «Cioè Daniel, per esempio, diceva che secondo lui non ci sarei mai riuscito, a fare questa cosa qua, e quindi è stata anche una sfida nei suoi confronti, per me». Senza dire della passione di Pastore per Borges, che faceva il paio con la passione di De Caro per Galileo. E che ha forse alimentato, nel libraio dei Due Mondi, qualcosa di simile a una vertigine letteraria.
«Io ho imparato tantissimo su Borges ascoltando lui»: è stato anche attraverso l’influenza di Pastore, presumibilmente, che il falsario del Nuncius ha finito per identificarsi con il personaggio di un racconto fra i piú celebrati della letteratura argentina e novecentesca. Perché riesce quasi banale dirlo, ma questa storia di una finzione editoriale costituisce anche – a suo modo – una variazione sul tema delle ficciones borgesiane. «Io, come ti avevo già detto, mi rivedo molto nel personaggio di Borges… descritto da Borges nella famosa cosa di Don Quijote, no?» De Caro si rivede molto nel racconto incluso da Borges in Finzioni: Pierre Menard, autore del «Chisciotte». «Cioè quello… quello scrittore che voleva fare una copia cosí fedele del Quijote, che alla fine è venuta meglio del Quijote, no? Ed… è… è quello che dico io del mio Nuncius. Cioè io ho voluto fare un Nuncius cosí simile all’originale, che secondo me è piú bello dell’originale!»
A dire il vero, il personaggio di Borges – con buona pace di Massimo De Caro – non voleva affatto produrre una copia esatta del Chisciotte: «Inutile specificare che non pensò mai a una trascrizione meccanica dell’originale; il suo proposito non era di copiarlo». La sfida vertiginosa di Pierre Menard consisteva non già in una fossile riproduzione del già-creato, ma in una prometeica ri-creazione del possibile («la mia impresa non è difficile. Mi basterebbe essere immortale per condurla a termine»). In questo senso, sarebbe fin troppo facile concludere che De Caro, ascoltando il suo amico Pastore, su Borges aveva imparato poco o nulla. Ma sarebbe una conclusione tanto pertinente quanto frettolosa. Perché in realtà, guardando all’esemplare galileiano che De Caro ha finito per produrre, bisogna ammettere che si potrebbero applicare al suo Nuncius, tali e quali, proprio le formule conclusive di Borges nel racconto di Finzioni: «Menard (forse senza volerlo) ha arricchito mediante una tecnica nuova l’arte incerta e rudimentale della lettura: la tecnica dell’anacronismo deliberato e delle attribuzioni erronee». Borgesianamente spingendo il concetto di paternità letteraria fino alle estreme sue conseguenze, anche De Caro ha fatto dell’anacronismo deliberato e dell’attribuzione erronea – forse senza volerlo – la tecnica nuova di un’arte.
Nell’estate del 2004, la reputazione di Massimo De Caro sul mercato internazionale del libro antico era già quella di un trafficante spregiudicato. Tra i librai si sapeva, che l’esemplare del Compasso di Galileo esposto da Imago Mundi alla International Antiquarian Book Fair di Londra altro non era che un falso ben confezionato. Ma a quel punto il dado era tratto, e De Caro già stava lavorando alla sua impresa successiva, la falsificazione del Nuncius. Già si era procurato, dunque, una copia genuina del formidabile trattatello astronomico pubblicato a Venezia nel 1610: acq...