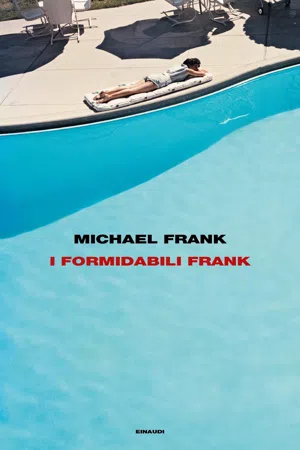All’inizio della primavera del 1969, quindi prima che Sylvia morisse, prima ancora che Huffy morisse, gli zii mi invitarono fuori a cena, per una delle nostre serate speciali insieme. Riaccompagnandomi a casa, mio zio prese una strada che non conoscevo. All’altezza della scuola elementare, invece di andare dritto per le stradine che si insinuavano nella parte vecchia del canyon, girò a destra e proseguí lungo Laurel Pass in direzione di Mulholland Drive. Arrivato lí, girò a sinistra e, dopo alcuni minuti, svoltò di nuovo a sinistra su una strada di recente costruzione che si chiamava Skyline Drive. Proseguí su quell’asfalto nero e sontuoso, ancora intatto, finché, giunto quasi in cima alla salita, si fermò di colpo e parcheggiò.
– Ammiriamo il panorama, – disse.
Scendemmo dalla macchina e raggiungemmo uno spiazzo vuoto. Davanti a noi si estendeva la San Fernando Valley, con la sua distesa infinita di lucine pulsanti accompagnate dal lontano brusio del traffico. Sembrava irreale, una proiezione, uno sfondo cinematografico.
– Guarda che mare di luce, – disse mio zio. – Sei sul tetto del mondo, quassú. Che ne pensi, Mike? Mike, non è spettacolare?
Annuii e mi avvicinai per vedere meglio.
Di colpo mio zio mi afferrò per un braccio. – Attento, Mike. Stai per inciampare sul divano!
Guardai la terra nuda.
– Occhio che vai a sbattere contro la scrivania.
La libreria.
La mia poltrona da lettura.
Il letto di tua zia. (Sapevamo tutti che Irving si rigirava senza sosta nel letto; avevano cominciato a dormire separati già poco dopo essersi sposati).
Il bagno. – Non vorrai mica ritrovarti con un piede nel gabinetto, no?
Era euforico, allegro. Mi ci volle un po’ per capire, e poi: ah.
Mia zia era dietro di noi; faceva su e giú e girava le braccia in aria come ruote di biciclette. – Vedo soffitti alti quattro metri, – disse. – E colonne. E un tetto a mansarda, naturalmente. Palladio. Louis Quatorze. Ho deciso che la chiamerò La Maison Ravetch. Notre maison!
La terra dove ci trovavamo quella sera risaliva a tempi antichissimi, si perdeva nella notte dei tempi. Fino a tre mesi prima, su questa parte della collina non arrivava nessuna strada, c’era solo la natura selvaggia della California: chaparral, querce, pioppi, artemisia, alloro, un mare di verde, d’argento e di marrone, marrone ovunque, che dopo le piogge primaverili si sarebbe chiazzato di rosa, viola e giallo. Alla fine dell’estate e fino all’autunno inoltrato, il terreno sarebbe diventato arido e brullo. Facilmente incendiabile. E a volte, difatti, scoppiavano degli incendi.
Questa terra si trovava su una collina all’interno di un canyon. Sembra quasi un ossimoro, se si pensa bene a queste parole, perché in fondo una collina non è un po’ il contrario di un canyon? Ma qui, a Laurel Canyon, erano presenti entrambi. Tecnicamente le colline facevano parte di una catena montuosa, un gigantesco rilievo che cominciava dall’isola di Catalina e continuava ben oltre la zona urbana di Los Angeles. Il terreno era fatto di sedimenti oceanici, rocce vulcaniche, granito decomposto, e aveva milioni e milioni di anni.
Il canyon era attraversato da un fiumiciattolo, che nella stagione delle piogge si spingeva fino alla parte piú antica del canyon, quella dove vivevamo noi. Il fiumiciattolo era alimentato da una sorgente che nessuno sapeva localizzare di preciso e dalle piogge, nonché dal deflusso degli irrigatori e delle pompe per innaffiare i giardini. Molte delle case lí erano raggiungibili solo passando per dei ponti che le collegavano alla strada. Sotto, l’acqua scorreva sonnolenta verso valle e scompariva in un canale di scolo riversandosi nel Pacifico.
Diverse tra le strade e le case della nostra parte del canyon risalivano agli inizi del secolo. Alcune erano state costruite con le pietre raccolte sulle rive del fiumiciattolo. Altre erano fatte di tronchi o assicelle per rivestimenti. Erano rifugi di campagna, volutamente rustici e semplici. Nei tempi antichi (e cioè: nei primi anni del ventesimo secolo) i losangelini fuggivano dallo stress della vita cittadina e si rifugiavano su queste colline per respirare un po’ di aria pura, per fare passeggiate e andare a caccia, in un’epoca in cui lí c’erano ancora i puma e i cervi erano piú numerosi. Verso il 1913, un imprenditore cominciò ad attrarre i turisti del fine settimana con un tram senza binari (un filobus, cioè) che da Sunset Boulevard li portava fin lassú. Divise le pendici in tanti lotti, lastricò le strade, mise i lampioni, costruí una locanda lungo la via. Nel frattempo spuntò anche un hotel, che subito fu distrutto dal fuoco. Pian piano la città raggiunse il canyon, e le casette appartate vennero ampliate o rase al suolo e ricostruite piú grandi; ne sorsero di nuove. Al posto dei vacanzieri amanti della natura arrivarono le stelle del cinema muto, poi quelle del sonoro, poi i musicisti. Venne aperta la scuola elementare per andare incontro alle esigenze delle famiglie sempre piú numerose, e quel posto si trasformò in una specie di sobborgo urbano, per quanto rimanesse geograficamente e per carattere isolato dal resto della città, tranquillo e bohémien, se non in realtà almeno nello spirito.
Mio padre fu il primo della famiglia a trasferircisi. Nel 1954 si costruí da solo una casetta da scapolo, un’espressione che all’epoca andava molto. Due camere da letto, un camino, parquet di legno duro, una striscia di giardino che arrivava fino al ripido pendio. Su Lookout Mountain Avenue, dove qualche anno dopo l’avrebbe raggiunto sua moglie e dove sarei nato io.
Con l’arrivo del secondo figlio i miei genitori decisero di costruirsi una casa piú grande, sempre nel canyon, ma in un punto piú alto, su un lotto di terreno piú vasto e piú assolato di Greenvalley Road. Nel frattempo i miei zii ci seguirono e costruirono la loro prima casa dall’altra parte della collina, in Wonderland Park Avenue; dopo di loro arrivarono Norm e Linda con le bambine. E dopo ancora il piú vecchio amico di mio padre, Murray, con la famiglia. Ci si conosceva tutti, lí nel canyon, noi bambini andavamo a scuola insieme; vivevamo in un paesino di campagna nel bel mezzo di una città enorme e complicata.
Fino al 1968 le case si fermavano in cima alla collina, in una via che giustamente portava il nome di Crest View. C’era la strada lastricata, e poi improvvisamente il chaparral che si estendeva a perdita d’occhio, come sempre. In alcuni punti c’erano dei sentieri, e delle piste per i cervi, su cui passavano davvero i cervi e anche i coyote, e ogni tanto uno degli ultimi puma. Lí ci inoltravamo a esplorare, io, i miei fratelli, Barrie e Wendy. Lí giocavamo con gli aquiloni, catturavamo i bruchi e prendevamo le farfalle con il retino. Lí conoscevamo la natura, e ci sentivamo liberi.
Poi un giorno su quel terreno si cominciò a costruire. Fu come se la montagna avesse preso a muoversi. E in un certo senso era cosí. La natura selvaggia fu cancellata in modo cosí totale che sembrava che quel posto fosse stato attaccato militarmente. La terra brulla fu compattata, livellata e divisa in lotti separati da piccoli pendii. Furono costruiti marciapiedi, cordoli, eretti nuovi segnali stradali; sotto terra scorrevano linee elettriche, canali di scolo e fognature. Quando soffiava il vento di Santa Ana, la ghiaia roteava in mulinelli simili a tornado, e nell’aria si sentiva profumo di artemisia, eucalipto e inquietudine. Il destino di qualcuno era in attesa di compiersi.
Un altro viaggio in macchina, qualche tempo dopo. Mentre percorrevamo quella stessa strada, nei primi giorni dell’anno nuovo, mio zio indicò un punto oltre il parabrezza. Sulla collina davanti a noi sorgeva un muro, un muro e basta, sorretto da impalcature.
– Guarda, Mike, – disse, di nuovo con quella voce euforica. – La nostra nuova casa. Sta per succedere.
E poi successe. Passo dopo passo, pezzo dopo pezzo. Mi piaceva vederla venire su, quasi quanto ai miei zii. Mi piaceva l’idea che carrettate di materiali grezzi diventavano muri, poi stanze. Mi piaceva l’odore del legname da costruzione, della carta catramata, della lana di vetro, che sembrava zucchero filato (ma era tossicissima). Le colonne c’erano eccome. E il parquet, e soffitti con cornici dagli elaborati intagli. Imparai tutta una serie di parole nuove: lesena, trabeazione, voluta; dorico-ionico-corinzio. Plinto. Architrave. Triglifo, metopa. Rosone, œil-de-boeuf. Fleur-de-lys. Trompe l’œil.
Sembrava di essere ad Atene o a Roma. O nella Londra di Christopher Wren. O nella Parigi prima di Haussmann, la tanto amata Parí (sans gli odiosissimi francesi), l’epicentro di tutto quanto era chic. E invece eravamo nella Los Angeles di fine anni ’60, dove ognuno poteva inventarsi il proprio look, la propria realtà; si poteva saccheggiare a piacimento dall’architettura, dalla storia, dalla letteratura, e persino dalle divinità: Palladio, Mansard, Le Nôtre, Jefferson. Una linea diretta li collegava a mia zia, o cosí sembrava.
In seguito, molto tempo dopo, avrei appreso che in realtà lei si muoveva nell’ambito di uno stile autoctono già esistente che aveva anche un suo nome, o comunque qualcuno alla fine lo aveva chiamato cosí: Hollywood Regency. Era uno stile inventato di sana pianta, un pastiche alla moda che – ovviamente – prendeva spunto non solo dall’architettura vera e propria ma anche dai set cinematografici: poco originale, eccessivo, riadattato al clima (soffitti alti, ampie finestre, piscine e specchi d’acqua riflettenti abbelliti da puttini riccioluti in pietra che reggevano delfini dalla cui bocca zampillava acqua); uno stile vagamente falso e decisamente eccentrico, proprio come un set cinematografico, solo completo in ogni suo lato e pienamente funzionante. Senz’altro su misura per degli sceneggiatori che grazie al loro talento nello scrivere dialoghi avevano guadagnato abbastanza da potersi costruire la maison tra le cui pareti stuccate a mano si sarebbero svolti i loro drammi e le loro scene personali.
I miei zii avevano ingaggiato un architetto, ma il suo lavoro consisteva in pratica nel tradurre in realtà le loro idee, soprattutto quelle di lei: stanze meno numerose ma piú larghe; una piantina disegnata per andare incontro alle necessità di una coppia senza figli che lavorava insieme a casa e piú di tutto desiderava tranquillità e privacy; una terrazza dove intrattenere gli ospiti; una piscina, naturalmente; e nulla che impedisse la vista di quel panorama prepotente.
Giuseppina aveva il castello di Malmaison; mia zia aveva la maison. Era lei l’unica signora incontrastata dell’arredamento. Manteneva il controllo praticamente su ogni millimetro di ogni superficie di ogni stanza, quasi come se lo spazio fisico fosse un’estensione del suo corpo, della sua faccia. In effetti la maison era la faccia che lei mostrava al mondo, strati su strati di collezioni di oggetti, distese di mobili, stampe, disegni e dipinti, tutti d’epoca oppure, se non d’epoca, quanto meno audace o con un suo tratto distintivo o guizzo di genio. Ove possibile, ogni elemento era il non plus ultra: questo tavolo, quel candeliere, quella poltrona. Francia, Inghilterra, Italia, in quest’ordine, erano i Paesi preferiti per la manifattura originaria. Il 1820 era la data limite e gli anni (i secoli) seguenti rappresentavano un declino in qualità caratterizzati dalla tendenza all’involgarimento; le critiche piú aspre erano rivolte a tutto quanto potesse essere considerato anche solo lontanamente mo-der-no. Questi pezzi venivano raccolti in loco, durante le irrinunciabili escursioni di mia zia nelle botteghe di antiquariato (adesso zia Trudy aveva preso il posto di mia nonna come sua accompagnatrice ufficiale), oppure arrivavano direttamente dalla Yurp dopo l’annuale viaggio a Londra o in quell’esotico entroterra conosciuto col nome di continente; talvolta erano acquistati alle aste. Nel corso degli anni questa collezione veniva perfezionata, ripulita, rimpinguata, seguendo alcuni precetti quali
Non è vero che less is more. More is more!
Vai di barocco!
Una cosa da sola è noiosa; a fare colpo sono le collezioni
Le cose migliori vengono a coppie
Cogli l’attimo
che si traducevano in una tendenza a raccogliere ancora di piú e, col passare degli anni, per mia zia sarebbe stato tutto trasformato nella regola:
Segui il principio del piacere, ad ogni costo!
Anche questo significava acquisire secondo l’esperienza e voleva essere un antidoto contro il suo umore sempre piú cupo.
In tutta la casa c’erano solo due stanze dove mio zio aveva voce in capitolo. Una era la biblioteca, i cui scaffali erano stati disegnati da lui in persona e dove esercitava il dominio sulla scrivania, sull’adiacente tavolo della macchina da scrivere, disposto perpendicolarmente, e su un tavolino basso vicino alla poltrona da lettura su cui stavano i libri e i periodici che stava leggendo in quel momento. L’altra era il suo stanzino guardaroba, grande quasi quanto la mia camera da letto, e corredato di cassetti, credenze, ripiani e scompar...