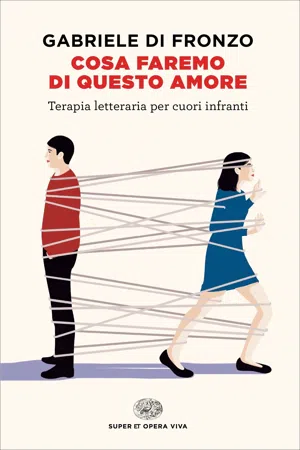1. Segreti palesi.
Piú sono malinconico e piú mi accorgo portato a dissezionare ogni storia, perlomeno cosí tento di allontanarmi dall’emotività del racconto che altrimenti mi franerebbe addosso. Secondo Johann Wolfgang Goethe lo scrittore insinua nei suoi racconti quelli che egli definisce «segreti palesi», episodi cioè in cui l’autore svela il destino di quel personaggio con una tale evidenza che nessuno li vede. Lo faccio con i libri e uguale trattamento dedico a me stesso. Mi metto, allora, sulle tracce delle spie che avrebbero dovuto farmi intuire che Rebecca mi stava lasciando. Io non ne ho avuto nessuna avvisaglia, povero me, eppure qualche premonizione avrei potuto averla. Avrei dovuto essere piú attento, forse, prestare l’orecchio ai piccoli tentennamenti della sua voce mentre mi salutava la mattina prima di uscire per andare a lavoro. Parlava certamente con un tono diverso dal solito. Un voyeur è motivato soprattutto dalle attese: è questo il tempo che dedica nella fiducia di scoprire quel che prima solo ritiene esista e dopo apparirà pressoché dal nulla. Devo concentrarmi. Un accadimento profetico c’è stato. Avevamo messo sulla veranda alcune trappole per catturare le blatte: si trattava di tre cartoncini adesivi al cui centro avevo sbriciolato una pastiglia bianca e blu che attira gli insetti. Il giorno successivo Rebecca vi trovò un passero con le ali aperte. Era ancora vivo, ma la colla cosí appiccicosa che non riuscimmo a liberarlo. Magari fu quello il primo segnale. Oppure il litigio quando lei preferí andare una settimana al mare con una sua amica, invece di rimanere a Torino con me che avrei dovuto ancora lavorare. O il fatto che negli ultimi giorni vissuti insieme, qualunque oggetto avesse in mano, l’asciugacapelli o una bottiglietta d’acqua frizzante, le cadesse in terra e lei ogni volta si rimproverasse, anche se era un portachiavi e non si sarebbe infranto o una mia cintura da niente. C’è una tecnica di riparazione degli oggetti di ceramica in Giappone che si chiama kintsugi. È una pratica tradizionale che prevede che quando una ciotola, una tazza, una scodella si rompe, questa venga aggiustata con l’oro o l’argento liquido. Kintsugi letteralmente è traducibile con l’espressione «riparare con l’oro»: l’articolo di vasellame acquisisce un valore che prima non possedeva, e proprio per merito del fatto che si sia rotto, sbeccato solamente o finito in decine di frantumi, e poi preziosamente incollato. Se continuo a rinvenire i presagi della rottura, a dissotterrarli, a spiare da dentro i cocci, il mio amore tornerà piú pregiato di prima? E poi: per un segno decifrato casualmente, quanti ne esisteranno di inavvertiti e piú gravi?
2. Comiche mute.
Nelle vecchie comiche mute capita a volte di vedere due innamorati che si separano. Il palmo aperto sul petto, lí dove si presume ci sia ancora il cuore, la bocca spalancata come dopo essere riemerso dalle acque piú fonde, il capo reclinato all’indietro. E gli occhi, gli occhi da cane cui sia stata tagliata la coda con una forbice dalle lame zigrinate. Si scoprirà piú tardi che quel paio di forbici era anche arrugginito.
3. Ghirlande marcite.
Leonardo Sciascia nella sua Breve storia del romanzo poliziesco ha esaminato le ragioni per cui un pubblico molto vasto legge i romanzi gialli e noir, definiti cosí a seconda del colore della copertina che in Italia Mondadori e in Francia Gallimard scelsero per connotarli quando iniziarono a essere un genere a sé stante. E lo scrittore siciliano crede di trovare queste ragioni in un paio di righe tratte dal Sistema delle arti di Émile-Auguste Chartier, detto Alain: «l’effetto certo dei mezzi di terrore e di pietà, quando li si adopera senza precauzione, è lo sgomento e la fuga dei pensieri, insomma una meditazione senza distacco, come nei sogni». Sarebbero questi i motivi per cui cosí tanti lettori in giro per il mondo hanno trascorso e continueranno a trascorrere il loro tempo libero seguendo il fiuto di Charles Auguste Dupin, di Sherlock Holmes, di Hercule Poirot, di Perry Mason, di Philip Marlowe, di Nero Wolfe e di Jules Maigret. Quali sono, invece, i motivi per cui leggiamo gli amori infelici? Tenere desto l’interesse, suscitando domande e ritardando le risposte, quando si può fare affidamento su un cadavere è una questione; inventare una suspense per due innamorati che si stanno mandando al diavolo è tutt’altra impresa. Ma, allora, se non per pedinarne le orme, perché leggiamo di uomini e di donne le cui storie miserabili il ritorno di un’onda trascina sulla spiaggia, come fossero ghirlande marcite?
4. Caro amico.
Caro Antoine, la tua dichiarazione d’amore è molto convincente, si sente subito l’uomo d’esperienza. Stasera andrò al concerto, ci sarai? Grazie per i libri. Ah, dimenticavo: mia madre ti trova romantico. Senza dubbio a causa dei tuoi capelli lunghi. A questa sera, caro amico. Colette.
L’amore a vent’anni, François Truffaut, 1962.
5. Non piangere, ché devi essere bella.
Vienna, Caffè Imperial, 8 settembre del 1913. Il conte Max Thun presenta la cugina Sidonie Nádherný von Borutin a Karl Kraus. La giovane baronessa ha ventotto anni e vive con il fratello gemello nel castello di Janowitz, a poca distanza da Praga. Quella sera stessa i due faranno insieme una corsa in automobile verso il Prater, poi vedranno la Svizzera e arriveranno fino alle Dolomiti. Si sono innamorati. Le scrive: «il mio titolo nobiliare è Tuo». Soltanto due amici conoscono il loro segreto, in pubblico, infatti, Sidonie e Karl si danno del lei. Alla ragazza piace viaggiare, fare sport e assistere agli spettacoli teatrali. Nel suo diario appunta che non riesce a dimenticarlo, ma nei confronti dell’uomo terrà sempre un atteggiamento contraddittorio. Le scrive: «mi sembra che la tua ultima lettera mi voglia tenere lontano, o meglio: mi ha fatto quest’impressione». Del carteggio che conta piú di mille lettere sono rimaste unicamente quelle scritte da lui. La ragazza lo allontanerà sempre, pur amandolo. Le scrive: «vivo di quello che sarà il domani ed è sempre un dopodomani, e poi neanche quello». Perché Sidonie è restia dal fidanzarsi con Karl? Può essere perché lei fa parte dell’aristocrazia e lui è borghese; può essere perché lui è ebreo; forse è stato Rainer Maria Rilke, che lei ha conosciuto a Parigi nell’atelier di Auguste Rodin, a dissuaderla; o magari teme di essere travolta dalle «pretese assolute» di Kraus, come le chiama Paola Sorge, l’italianista e germanista, curatrice dell’edizione italiana dell’epistolario. Le scrive: «ma poi ti farò scontare questo dolore della separazione». Il matrimonio tra Sidonie e il cugino, quel Max Thun che li aveva presentati, finisce dopo un pugno di mesi. La loro relazione clandestina durerà ventitre anni. Le scrive: «sono venuto solo per dirti questo: il nostro commiato a Venezia non mi è bastato. Dato che non so se sei riuscita a vedere dal vagone il mio saluto con la mano, sono venuto io stesso rapidamente a Roma per chiedertelo. Quando lo saprò ripartirò di nuovo». Karl le è fedele, devoto, lei gli manca incessantemente. Le scrive: «sono continuamente curioso di te». Si può persino essere fidanzati per una vita intera senza mai incontrarsi. Come se l’uno spingesse l’altro sempre abbastanza lontano, a quella esatta distanza, alla stregua di quel che fa un mulo che spinge davanti a sé un carretto che gli rimarrà vicino ma mai raggiungibile. Le scrive: «non piangere, ché devi essere bella».
6. Il vascello o la lettera.
C’è tutto un mondo della fuga, c’è chi pare aspetti un colpo di pistola sparato in alto d’un tratto e chi centellina il suo allontanamento perché ne sospetta la nocività per chi rimarrà. Qui forse c’entra la pietà. Nel romanzo di Jean Echenoz Me ne vado, Félix Ferrer ha cinquant’anni e nonostante il medico gli abbia suggerito una certa cautela per via di un recente infarto, lascia d’emblée la moglie e parte in viaggio per il Polo Nord. La avverte appena con le tre parole del titolo, con le quali si apre il libro, e poi abbandona il tetto coniugale. A spingerlo tra i ghiacciai è un tesoro di età arcaica nascosto in un vascello fantasma arenatosi su una banchisa. Ma è un pretesto appena piú nobilitante del solito pacchetto di sigarette. Lascia tutto a Suzanne, il cui sguardo «si fissava senza motivo su una presa elettrica», mentre lui, abbandonate le chiavi sul tavolino e abbottonatosi il cappotto, esce chiudendo piano la porta. Oppure l’addio può essere dato per iscritto. Un foglio e dieci righe fitte. Lo riceve cosí il marito in Pasticcio di merli di Raymond Carver, mentre è nel suo studio davanti alla macchina da scrivere. All’uomo però non basta la lettera, scritta a mano dalla moglie e passatagli sotto la porta, per fargli accettare l’idea di cosa stia accadendo. Non può essere stata lei, si dice, qualcuno l’avrà obbligata, a ben vedere non si tratta neppure della sua calligrafia. Quante invenzioni per non dare ragione all’angoscia. Rebecca mi ha fatto una telefonata da una cabina telefonica. È un’immagine cosí fané. Non sembra la fine di un amore di questi tempi. Ero a casa che piantavo un chiodo nel muro del salotto. Ho cercato di ricordare un racconto o un romanzo in cui una ragazza lasci il suo fidanzato in questo modo. Al momento non ho rinvenuto, nella mia memoria e tra i miei calepini, niente di inerente: continuerò a scartabellare, suppongo che un esito positivo questa mia cerca prima o dopo purtroppo lo avrà. Vorrei, come tutti, un finale inedito e proprio come tutti non lo avrò. Mi ha detto che aveva deciso cosí da un paio di mesi, ora me lo stava soltanto comunicando.
7. Lev e Sof?ja in dieci scene piú una.
1. «Mi sono dichiarato. Lei: sí. Lei: è come un uccellino ferito. Scrivere non serve. Tutto questo non può essere né dimenticato né annotato».
(L. N. Tolstoj, Diari, 16/9/1862).
2. «Se solo potessi ucciderlo e creare al suo posto un altro uomo identico a lui, lo farei volentieri».
(S. A. Tolstoja, Diari, 16/12/1862).
3. «… Siamo come due estranei che intrattengono rapporti molto cordiali, ma privi di vera sincerità…»
(S. A. Tolstoja, da una lettera al marito, 22/3/1884).
4. «In famiglia, situazione insopportabile».
(L. N. Tolstoj, Diari, 16/4/1884)
5. «Ho sognato che mia moglie mi amava. Com’era tutto facile e chiaro! Da sveglio le cose non stanno affatto cosí. Ed è questo che distrugge la mia esistenza. A scrivere neanche ci provo. Sarebbe bello morire».
(L. N. Tolstoj, Diari, 17/5/1884).
6. «L’essenziale, mio caro, è che tu ti riguardi in tutto; perché io sia contenta basta una cosa sola: che sia felice, sano e che non ti affatichi troppo».
(S. A. Tolstoja, da una lettera al marito, 23/10/1884).
7. «Certe volte, la notte, quando me ne sto seduta o stesa accanto a lui, sento un grande desiderio di dirgli quanto bene gli voglio, e che al mondo non ho mai amato nessuno come lui. E se certe volte, per effetto di un maleficio, mi sono resa apparentemente colpevole nei suoi confronti, nel mio intimo è sempre stato saldamente radicato un amore profondo e incalcolabile per lui solo, e mai nella mia vita gli sono stata infedele: neppure una carezza che non fosse per lui. Ma è impossibile dirgli alcunché; non devo metterlo in agitazione, per cui mi tocca fare da sola il bilancio di questi trentanove anni di vita matrimoniale che, in definitiva, sono stati felici e puri, nonostante io continui a sentirmi in colpa perché non abbiamo saputo renderci felici l’un l’altro completamente fino alla fine».
(S.A. Tolstoja, da una lettera a T. A. Kuzminskaja, 11/7/1901).
8. «Sto pensando di andarmene. Che fare? Lasciare una lettera? La cosa mi fa paura, tuttavia penso che sia meglio…»
(L. N. Tolstoj, Diario per me solo, 6/8/1910).
9. «Tutto ciò mi dà molta, moltissima pena. Che Dio mi aiuti! Ho che non voglio e non posso promettere nulla, ma farò tutto il possibile per non farla soffrire. Non credo che metterò in pratica il mio piano di partire domani. Eppure dovrei».
(L. N. Tolstoj, Diario per me solo, 16/10/1910).
10. «La mia partenza ti farà soffrire, e me ne rammarico, ma cerca di capirmi e credimi, non posso agire diversamente. La mia posizione in casa stava diventando, anzi era già diventata, intollerabile […] Ti prego, cerca di capirmi e non cercare di raggiungermi, nel caso tu dovessi venire a conoscenza del mio nuovo indirizzo. Il tuo arrivo non farebbe altro che peggiorare la mia situazione, cosí come la tua, senza peraltro indurmi a ritornare sulla mia decisione. Ti ringrazio per i quarantotto anni di vita onesta che hai condiviso con me… e ti prego di perdonarmi se mi sono reso colpevole di qualcosa nei tuoi confronti, cosí come io ti perdono con tutto il cuore per ciò di cui tu possa esserti resa colpevole nei miei, e ti scongiuro di rassegnarti serenamente alla nuova condizione nella quale la mia partenza ti pone, e di non nutrire verso di me alcun risentimento, cosí come io non ne nutro per te».
(L. N. Tolstoj, da una lettera alla moglie, 28/10/1910).
11. «… e se qualcuno chiedeva a S. A. che cosa avrebbe provato e fatto se davvero lui fosse morto a causa di tutto ciò che lei gli faceva passare, lei rispondeva: “Finalmente potrò visitare l’Italia; non ci sono mai stata”».
(V. G. Čertkov, Uhcod Tolstogo).
8. Il vino con il ghiaccio e l’usignolo.
Dice il Dizionario della Lingua Italiana Sabatini-Coletti che il rimorso [ri-mòr-so] è quel sentimento di dolore e di tormento che nasce dalla consapevolezza dei mali commessi. E il rimpianto [rim-piàn-to] è il ricordo nostalgico e doloroso di qualcosa o di qualcuno. Il rimorso è la ragione che addolora David, il giovane americano del racconto Livido di Etgar Keret, che un po’ frettolosamente aveva detto di amare un’amica israeliana. Una sera in albergo avevano pomiciato senza fare sesso e lui si era addormentato con addosso i vestiti. I giorni seguenti lei aveva atteso che la chiamasse, provò anche a leggere Underworld di DeLillo ma non ne concluse neanche il primo capitolo. David era tornato a Cleveland dalla ragazza che stava per sposare e che, proprio in aeroporto, gli disse che aspettava un figlio. La chiama un anno dopo: è a Tel Aviv per un convegno dell’Agenzia ebraica, può passare a trovarla? Lei è a casa con un osso fratturato e il muscolo quasi strappato in due punti. Lui porta una bottiglia di vino bianco caldo e una pizza. Si pente di essersi comportato in quel modo, le confessa che dopo quella notte non si era fatto la doccia perché voleva che il suo odore gli rimanesse addosso e che quando atterrò a Cleveland «aveva ancora il suo profumo nei capelli». Desidera che lei lo perdoni. Guardano un episodio di Lost e finiscono il vino bianco, per raffreddarlo lo stanno bevendo con il ghiaccio, come una Coca-Cola nonostante sia una bottiglia da cento dollari. Visto che con il gesso lei riesce poco a muoversi, David la prende in braccio, «nemmeno fosse un pompiere che la salva da un edificio in fiamme o uno sposo che porta la moglie oltre la soglia di casa la prima notte di nozze», e la porta in bagno. Quando tornano in salotto l’episodio di Lost è finito. Lui glielo racconta, in America è già andato in onda anche se lui prima non gliel’aveva detto. L’aiuta a fare le quattro rampe di scale, escono di casa. Ora che è seduto su una panchina dei giardini Meir, David piange, lei non se ne avvede subito e pensa che stia tossendo, invece lui piange perché le è grato di averlo perdonato. Il rimpianto, invece, è quello che, come un pugnale sottile e leggero, segna le vite dei due giovani protagonisti di Una scampagnata di Guy de Maupassant: Henri, abile canottiere, e Henriette, figlia di una dama delle chincaglierie. Si ritrovano nello stesso bosco in cui un anno prima lui l’aveva accompagnata per stare in ascolto di un usignolo che presto avrebbe taciuto, udendo ai piedi del suo...