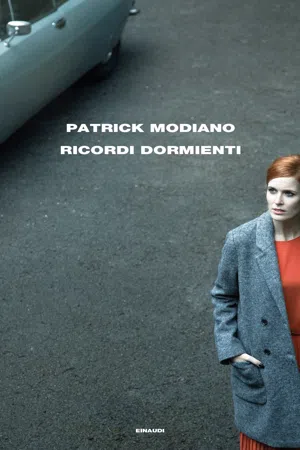Un giorno, sul lungosenna, il titolo di un libro ha attirato la mia attenzione: Il tempo degli incontri. Anche per me, in un lontano passato, c’è stato un tempo degli incontri. In quel periodo avevo spesso paura del vuoto. Una vertigine che non provavo quando ero solo, ma con certe persone che, appunto, avevo incontrato da poco. Per tranquillizzarmi pensavo: prima o poi riuscirò a piantarle in asso. Alcune di queste persone non sapevi fin dove ti potevano trascinare. La china era scivolosa.
Per prima cosa potrei evocare le domeniche sera. Mi mettevano angoscia, come a chiunque abbia vissuto i rientri in collegio, d’inverno, a fine pomeriggio, nell’ora in cui cala il buio. Momenti che in seguito ti tormentano nei sogni, a volte per tutta la vita. La domenica sera alcune persone si riunivano nell’appartamento di Martine Hayward, e io mi trovavo fra quella gente. Avevo vent’anni e mi sentivo un po’ fuori posto. Mi coglieva di nuovo un senso di colpa, come se fossi stato ancora uno studente: invece di rientrare in collegio ero scappato.
Chissà se devo proprio parlare subito di Martine Hayward e dei pochi disparati individui che la circondavano in quelle sere? O è meglio seguire l’ordine cronologico? Non lo so piú.
Verso i quattordici anni mi ero abituato a camminare da solo per strada nei giorni di vacanza, dopo che la corriera della scuola ci aveva lasciati alla Porte d’Orléans. I miei genitori erano assenti, mio padre preso dai suoi affari, mentre mia madre recitava in un teatro di Pigalle. Ho scoperto quell’anno – 1959 – il quartiere di Pigalle di sabato sera, quando mia madre era in scena, e ci sono tornato spesso nei dieci anni successivi. Darò altri dettagli in proposito, se ne avrò il coraggio.
All’inizio avevo paura di camminare solo, e per tranquillizzarmi seguivo ogni volta lo stesso itinerario: rue Fontaine, place Blanche, place Pigalle, rue Frochot e rue Victor-Massé fino alla Boulangerie all’angolo con rue Pigalle, uno strano locale che rimaneva aperto tutta la notte, e dove compravo un croissant.
Lo stesso anno, lo stesso inverno, i sabati in cui non andavo a scuola facevo la posta davanti al palazzo di rue Spontini dove abitava una ragazza di cui non ricordo il nome, e che chiamerò «la figlia di Stioppa». Non la conoscevo, avevo saputo il suo indirizzo dallo stesso Stioppa, nel corso di una delle passeggiate in cui mi trascinavano lui e mio padre, la domenica, al Bois de Boulogne. Stioppa era un russo, amico di mio padre, e si vedevano spesso. Alto, con i capelli bruni e lucidi. Indossava un vecchio cappotto col bavero di pelliccia. Aveva subíto dei rovesci di fortuna. Lo riaccompagnavamo verso le sei di sera fino alla pensione familiare dove alloggiava. Mi aveva detto che sua figlia era mia coetanea e che avrei potuto frequentarla. A quanto pare non la vedeva piú, dato che viveva con sua madre e il nuovo marito di lei.
I sabati pomeriggio di quell’inverno, prima di raggiungere mia madre nel suo camerino a Pigalle, mi appostavo davanti al palazzo di rue Spontini aspettando che si aprisse il portone di vetro con le inferriate nere e spuntasse una ragazza della mia età, «la figlia di Stioppa». Avevo la certezza che sarebbe stata sola, che mi sarebbe venuta incontro e che l’avrei avvicinata in modo naturale. Ma non è mai uscita dal palazzo.
Stioppa mi aveva dato il suo numero di telefono. Qualcuno ha risposto. Ho detto: – Vorrei parlare con la figlia di Stioppa –. Silenzio. Mi sono presentato come «il figlio di un amico di Stioppa». La sua voce era chiara e amichevole, come se ci conoscessimo da tanto tempo. – Richiamami la settimana prossima, – mi ha detto. – Cosí fissiamo un appuntamento. È complicato… Non abito da mio padre… Ti spiegherò tutto… – Ma durante la settimana successiva e le altre settimane di quell’inverno, gli squilli del telefono si sono susseguiti senza alcuna risposta. Di sabato, prima di prendere il metrò per Pigalle, ho di nuovo fatto due o tre volte la posta davanti al palazzo di rue Spontini. Invano. Avrei potuto suonare alla porta dell’appartamento ma, come per il telefono, ero certo che nessuno avrebbe risposto. E poi, da quella primavera, non ci sono state mai piú passeggiate al Bois de Boulogne con Stioppa. Né con mio padre.
A lungo sono stato convinto che si potessero fare incontri veri soltanto per strada. Ecco perché aspettavo la figlia di Stioppa sul marciapiede davanti al suo palazzo, senza conoscerla. «Ti spiegherò tutto», mi aveva detto al telefono. Per alcuni giorni una voce sempre piú lontana ha di nuovo pronunciato quella frase nei miei sogni. Sí, avevo voluto incontrarla perché speravo che mi avrebbe fornito delle «spiegazioni». Forse mi sarebbero servite a capire meglio mio padre, uno sconosciuto che camminava in silenzio al mio fianco, lungo i viali del Bois de Boulogne. Lei, la figlia di Stioppa, e io, il figlio dell’amico di Stioppa, avevamo certamente dei punti in comune. Ed ero sicuro che lei la sapeva un po’ piú lunga di me.
Nello stesso periodo, dietro la porta socchiusa del suo studio, mio padre parlava al telefono. Alcune sue parole mi avevano incuriosito: «la banda dei russi del mercato nero». Quasi quarant’anni dopo mi è capitata fra le mani una lista di nomi russi, grossi trafficanti del mercato nero di Parigi durante l’occupazione tedesca. Šapošnikov, Kurilo, Stamoglu, barone Wolf, Mečerskij, Džaparidze… Chissà se fra loro si trovava Stioppa? O mio padre, sotto falsa identità russa? Me lo sono chiesto un’ultima volta, prima che quelle domande si perdessero senza risposta nella notte dei tempi.
Verso i diciassette anni ho incontrato una donna, Mireille Uruzov, che portava anche lei un nome russo, quello del marito, Eddie Uruzov, soprannominato «il Console», con il quale viveva in Spagna dalle parti di Torremolinos. Era francese, originaria delle Landes. Le dune, i pini, le spiagge deserte dell’Atlantico, un giorno assolato di settembre… Eppure l’avevo conosciuta a Parigi nell’inverno del 1962. Ero partito con trentanove di febbre dal collegio in Alta Savoia, avevo preso un treno per Parigi ed ero approdato verso mezzanotte nell’appartamento di mia madre. Lei non c’era e aveva affidato le chiavi a Mireille Uruzov, che abitava lí per qualche settimana, prima di tornare in Spagna. Quando avevo suonato, mi aveva aperto lei. L’appartamento sembrava abbandonato. Non c’era piú nessun mobile, fuorché un tavolo da bridge e due sedie da giardino nell’ingresso, un letto matrimoniale in mezzo alla camera che dava sul lungosenna, e nella camera accanto, dove dormivo da bambino, un tavolo, alcuni scampoli di tessuto e un manichino da sarta, abiti e vestiti vari appesi alle grucce. Il lampadario diffondeva una luce velata, perché gran parte delle lampadine erano bruciate.
Uno strano mese di febbraio, con la luce velata nell’appartamento e gli attentati dell’Oas. Mireille Uruzov era appena tornata da una settimana bianca e mi mostrava le foto di lei e dei suoi amici al balcone di una baita. Su una foto era in compagnia di un attore chiamato Gérard Blain. Mi aveva detto che recitava dall’età di dodici anni senza il permesso dei genitori, perché era un bambino abbandonato a se stesso. Piú tardi, quando l’ho visto in certi film, mi dava l’idea che non avesse mai smesso di camminare con le mani in tasca e la testa leggermente incassata fra le spalle, come per ripararsi dalla pioggia. Passavo la maggior parte delle giornate con Mireille Uruzov. Raramente mangiavamo nell’appartamento. Avevano staccato il gas e bisognava cucinare con un fornellino ad alcol. Niente riscaldamento. Ma rimaneva ancora qualche ceppo nel camino della camera. Una mattina siamo andati dalle parti dell’Odéon a pagare una bolletta dell’elettricità scaduta da due mesi, per non rimanere a lume di candela nei giorni successivi. Uscivamo quasi tutte le sere. Verso mezzanotte mi portava poco distante da casa, in un cabaret di rue des Saints-Pères, quando lo spettacolo era già finito da tempo. Restavano pochi clienti al bar del pianoterra, sembravano conoscersi tutti e parlavano sottovoce. E lí incontravamo un amico di lei, un certo Jacques de Bavière (o Debavière), un biondo con l’aria sportiva, e Mireille mi aveva detto che era un «giornalista» e che faceva «la spola tra Parigi e Algeri». Suppongo che quando certe notti lei si assentava era per raggiungere quel Jacques de Bavière (o Debavière), che abitava in un monolocale di avenue Paul-Doumer. Un pomeriggio l’ho accompagnata nel monolocale, perché aveva dimenticato lí l’orologio. Jacques de Bavière non c’era. Due o tre volte ci aveva invitati in un ristorante vicino agli Champs-Élysées, La Rose des sables, in rue Washington. Molto piú tardi ho saputo che il cabaret di rue des Saints-Pères e La Rose des sables in quel periodo erano frequentati dai membri di una polizia clandestina legata alla guerra d’Algeria. E, vista la strana coincidenza, mi sono chiesto se Jacques de Bavière (o Debavière) non facesse parte di quell’organizzazione. Un altro inverno, negli anni Settanta, mentre scendevo nella stazione del metrò George V verso le sei di sera ho visto uscire un uomo che mi è sembrato somigliare a Jacques de Bavière un po’ invecchiato. Ho fatto dietrofront e l’ho seguito con l’intenzione di accostarlo per sapere che fine avesse fatto Mireille Uruzov. Viveva ancora a Torremolinos con suo marito Eddie, «il Console»? Si stava dirigendo verso il Rond-Point e zoppicava leggermente. Mi sono fermato all’altezza del dehors del caffè Marignan, e l’ho seguito con gli occhi fino a quando si è perso tra la folla. Perché non l’ho accostato? Mi avrebbe riconosciuto? Non posso rispondere a queste domande. Per me Parigi è disseminata di fantasmi, numerosi quanto le stazioni del metrò e tutti i relativi puntini luminosi che si accendevano quando capitava di premere i tasti sul tabellone dei cambi di linea.
Io e Mireille Uruzov prendevamo spesso il metrò alla stazione Louvre per recarci nei quartieri a ovest di Parigi, dove andava a trovare alcuni amici di cui ho dimenticato i volti. Mi rimane soltanto il ricordo preciso di quando attraversavo con lei il Pont des Arts, poi la piazza davanti alla chiesa di Saint-Germain-l’Auxerrois, e qualche volta il cortile del Louvre con, giú in fondo, la luce gialla del comando di polizia, la stessa luce velata che illuminava l’appartamento. Nella mia vecchia camera, sui ripiani vicino alla grande finestra a destra, c’erano alcuni libri, e oggi mi chiedo per quale miracolo si trovassero ancora lí, dimenticati, mentre tutto il resto era scomparso. Libri che mia madre leggeva quando era arrivata a Parigi nel 1942: romanzi di Hans Fallada, libri in olandese, e poi alcuni volumi della collana per ragazzi la Bibliothèque Verte che allora mi appartenevano: Il cargo del mistero, Il visconte di Bragelonne…
Laggiú, in Alta Savoia, cominciavano a preoccuparsi per la mia assenza. Una mattina ha squillato il telefono e Mireille Uruzov ha risposto. Il canonico Janin, superiore del collegio, desiderava avere mie notizie perché da una quindicina di giorni non ne aveva piú.
Mireille gli ha detto che «non stavo bene» – una ...