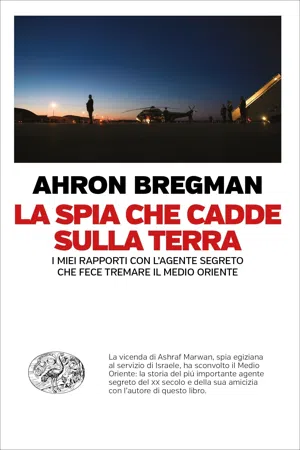Sono passati tanti anni, ma ricordo la scena come fosse ieri.
Siedo al tavolo della cucina con mia madre, che sorbisce brodo di pollo. Io no, osservo il digiuno. Non mangiare né bere per un’intera giornata non è uno scherzo per un quindicenne, e sono soltanto le due e qualcosa del pomeriggio. È Yom Kippur e siamo nel 1973. A un tratto qualcuno chiama mia madre da sotto il balcone. Riconosco la voce, è Mazel, la vicina. Mia madre prende il piatto ed esce sul balcone. Ma non serve, perché Mazel è agitata e parla a voce molto alta. «Accendete la radio… Accendete la radio! – grida. – È appena scoppiata la guerra!»
Cosí traumatico! Cosí inaspettato! Cosí diverso dal 1967, quando le nostre truppe avevano sconfitto gli eserciti arabi con tanta rapidità ed eleganza. All’epoca avevo nove anni e una mattina mio padre mi aveva svegliato indicando una foto su un giornale piegato a metà e dicendo che l’uomo della foto, Moshe Dayan, ci avrebbe presto portati a una grande vittoria contro gli arabi. Ricordo di aver guardato la foto, mezzo addormentato, e di aver visto un tizio con una benda nera su un occhio, come un pirata; ero un bambino, sapevo che i pirati vincono sempre le guerre e tanto mi bastava. Adesso invece, sei anni dopo, il pirata compare sullo schermo della nostra tv in bianco e nero, sconfitto, a testa china, e gli trema la voce mentre spiega che le nostre truppe al fronte combattono il nemico invasore e che «lottiamo per la vita!» Lottiamo per la vita? Noi?
Negli anni successivi il trauma di Yom Kippur continuò a incidere profondamente sulla nostra vita collettiva, perché la perdita di quasi tremila giovani uomini toccò ogni settore della comunità israeliana, ancora piccola. Nel frattempo sono cresciuto, passando dal liceo all’esercito all’università, e in seguito mi sono concentrato sulla storia delle guerre di Israele, scrivendo anche dei libri sull’argomento. In questo modo mi sono reso conto che, di tutti i conflitti israeliani, la Guerra del Kippur del 1973 è il piú appassionante: la storia di un imponente attacco a sorpresa da parte degli arabi, che prende completamente alla sprovvista Israele, e di una reazione e un contrattacco quasi miracolosi che conducono le truppe israeliane fino alle porte del Cairo e di Damasco. Ma soprattutto è una vicenda di spionaggio degna di John le Carré, al centro della quale c’è una brillante superspia il cui nome è avvolto nel mistero ed è top secret in Israele.
Dopo il suo avvertimento del 5 ottobre 1973, quando a Londra aveva informato Zvi Zamir che l’indomani sarebbe scoppiata la guerra, Ashraf Marwan tornò in Egitto. Lí continuò a lavorare senza sosta per il presidente Sadat come ambasciatore itinerante, trasmettendo messaggi personali ai leader arabi per coordinare le mosse, nel tentativo di approfittare del riuscito attacco a sorpresa contro Israele. Ma la guerra era appena finita che già Marwan e il Mossad ristabilivano i contatti. Ora gli israeliani avevano una nuova richiesta per lui: volevano che spiasse anche la Siria. Temevano infatti che la fragile tregua sulle Alture del Golan venisse violata e che il Paese riprendesse la guerra. Cosí Dubi Asherov, il referente di Marwan, gli assegnò varie missioni di spionaggio in Siria per scoprire le intenzioni dei nemici.
Marwan si mise subito all’opera. Si recò a Damasco per incontrare il presidente Hafiz al-Assad; il leader siriano gli parlò apertamente, e dopo l’incontro Marwan fece rapporto agli israeliani. C’erano buone notizie: Assad non voleva riprendere le ostilità e probabilmente avrebbe rispettato il cessate il fuoco. In effetti di lí a poco Israele e la Siria firmarono altri accordi che rafforzarono la tregua sul Golan. Marwan, però, non dimenticava l’Egitto. Proprio mentre nella Penisola del Sinai si svolgevano i colloqui tra Israele ed Egitto per porre fine alle ostilità, lui forní agli israeliani le informazioni che li aiutarono ad avere la meglio nei negoziati.
La crisi era superata, e Israele, Egitto e Siria accettarono una pace precaria. Intanto, al Cairo, la fama di Marwan continuava ad aumentare. La sua carriera nell’amministrazione di Anwar al-Sadat era in ascesa, ma lungo il percorso si era fatto molti nemici, che lo temevano, non si fidavano di lui e lo detestavano; in città lo chiamavano «Dottor Morte». Ormai era anche ricco sfondato, visto che gestiva l’acquisto di armi per l’Egitto e in questo modo guadagnava ingenti commissioni, denaro che depositava in conti esteri. Al tempo stesso, con il progressivo miglioramento delle relazioni tra Israele ed Egitto – nel 1979 i due Paesi firmarono un trattato di pace e Israele restituí all’Egitto il Sinai occupato –, Marwan perse gran parte della sua utilità come spia per Israele. Di fatto era diventato un peso; se lo avessero scoperto, la pace tra i due Paesi sarebbe stata in grave pericolo. Cosí, pur senza tagliare i ponti, capitava sempre piú di rado che gli israeliani si servissero di lui.
Ciò che accadde dopo avrebbe cambiato tutto, sia per l’Egitto sia, ancora una volta, per Ashraf Marwan.
Nel 1981 il presidente Anwar al-Sadat venne assassinato dai fondamentalisti islamici durante una parata militare organizzata per commemorare la vittoria contro Israele del 1973, o almeno quella che gli egiziani consideravano tale. A Sadat succedette il vicepresidente Hosni Mubarak. Il nuovo leader non invitò Marwan a entrare nella cerchia dei suoi fedelissimi, e quell’anno Marwan lasciò Il Cairo con la famiglia. Era diretto a Londra, ma prima si fermò a Parigi, comprò una casa lussuosa, vi sistemò Mona e i figli e poi proseguí da solo per l’Inghilterra.
Naturalmente, Marwan conosceva bene Londra: aveva studiato lí e la sua carriera di spia per gli israeliani si era svolta per lo piú in quella città. Tuttavia adesso era un uomo facoltoso, con un patrimonio stimato fra i trecento e i cinquecento milioni di sterline, distribuiti in vari conti. All’inizio si stabilí in una casa confortevole di Hampstead, a nord di Londra, e lo si vedeva spesso in un pub della zona, il Duke of Hamilton, dove sorseggiava tranquillamente un whisky mentre leggeva i giornali arabi e il «Financial Times». Ben presto, però, si mise ad acquistare immobili; cominciò a costruire un impero immobiliare e commerciale, diventando persino comproprietario della squadra di calcio del Chelsea. Per giunta si dedicava a tempo pieno al traffico di armi, violando le sanzioni dell’Onu e inviando armi in Africa e altrove. Questa attività preoccupava il vecchio datore di lavoro di Marwan – il Mossad –, dato che l’organizzazione vide la propria spia fare amicizia con Gheddafi, il colonnello libico che era un nemico giurato di Israele. Quando gli operatori del Mossad cominciarono a sospettare che Marwan fornisse armi a Gheddafi, si misero a spiarlo; entrarono in casa sua per fotocopiare dei documenti, al fine di capire se vendesse davvero armi alla Libia, e installarono cimici e telecamere nascoste.
Da Londra, Marwan conservò stretti legami con l’élite egiziana: uno dei figli sposò la figlia di Amr Moussa, ex ministro degli Esteri e poi segretario generale della Lega Araba, mentre l’altro figlio, Gamal, era amico intimo e socio in affari di Gamal Mubarak, figlio del presidente egiziano. Nei primi anni Ottanta Marwan non intrattenne quasi alcun contatto con il Mossad, tranne in un’occasione, quando si trovò di colpo in difficoltà economiche e chiese aiuto agli israeliani; quella volta gli versarono in un’unica soluzione ben mezzo milione di dollari, per gli anni in cui aveva lavorato gratis. Fu l’ultimo pagamento che ricevette dal Mossad.
C’è ancora un episodio, che segna la fine della carriera di Marwan come spia per gli israeliani.
A metà degli anni Novanta il Mossad decise di ravvivare il rapporto quiescente con Marwan, perché gli israeliani si resero conto che la sua rete di contatti in Medio Oriente e oltre poteva far comodo anche a loro. Cosí «Alex» – Dubi Asherov, il vecchio referente dell’egiziano – venne mandato a Londra per rinnovare la collaborazione.
Dal giorno in cui era entrato nel Mossad, nel 1970, Marwan aveva posto due condizioni: in primo luogo, avrebbe interagito solo con «Alex»; in secondo, non avrebbero mai dovuto registrarlo, di nascosto o in qualsiasi altro modo. La prima richiesta era stata soddisfatta, dato che gli israeliani, seppure con riluttanza, avevano accettato che Asherov fosse l’unico tramite di Marwan, e cosí fu per ventotto anni, finché l’egiziano non smise di lavorare con il Mossad. La seconda richiesta non venne nemmeno presa in considerazione, visto che nell’appartamento in cui si svolgevano quasi tutti gli incontri con la spia, vicino al Dorchester Hotel, gli israeliani avevano installato dei registratori nascosti di cui Marwan ignorava l’esistenza1. Adesso però Danny Yatom, il nuovo direttore del Mossad, preoccupato per il rapporto troppo stretto fra Asherov e Marwan e intenzionato a sapere tutto quello che i due si dicevano, ordinò ad Asherov di tenere un registratore in tasca e di usarlo quando parlava con l’egiziano2.
Asherov e Marwan uscirono a cena e la serata iniziò sotto i migliori auspici; i due erano lieti di rivedersi, ne avevano passate tante insieme. Poi, la catastrofe: appena il nastro arrivò alla fine, un difetto del meccanismo fece partire la conversazione appena registrata. Asherov si sentí sprofondare per l’imbarazzo e corse alla toilette per zittire il marchingegno, lasciando Marwan solo al tavolo, offeso a morte. Al ritorno si profuse in scuse, ma sapeva benissimo che ormai il danno era fatto. Quello fu il loro ultimo incontro. Tradito e amareggiato, Marwan non volle piú vedere nessuno del Mossad. Il solo israeliano con cui ebbe a che fare da allora non fu un operatore del Mossad, ma un accademico: ero io.
Come altri studiosi dei conflitti israeliani, anch’io sapevo che un tempo, prima della Guerra del Kippur, c’era stata una «prodigiosa» spia araba che lavorava per il Mossad e che aveva fornito un avvertimento cruciale riguardo al conflitto. Nelle mie prime opere sulle guerre di Israele non ne avevo fatto parola, visto che non avevo niente da aggiungere. Tutto cambiò nel 1998, quando intervistai Eli Zeira per un documentario a puntate trasmesso dalla Bbc intitolato The Fifty Years War. Israel and the Arabs.
In Israele Zeira è molto conosciuto: un generale dell’esercito a riposo, intelligente e carismatico, che ha partecipato a tutti i conflitti israeliani fin dal 1948. Nel periodo precedente la Guerra del Kippur del 1973 era a capo della Direzione di Intelligence Militare (Aman, in ebraico). Il suo compito era fornire pareri al primo ministro e al governo in generale sulla probabilità che scoppiasse una guerra con gli arabi.
Negli anni Settanta la carriera di Eli Zeira era in ascesa e molti pensavano che un giorno sarebbe diventato capo di stato maggiore o che magari sarebbe addirittura entrato in politica. C’era un problema, però: era un uomo arrogante e sicuro di sé, non certo l’ideale per il direttore dell’intelligence militare, che deve essere bravo ad ascoltare e soprattutto cauto – persino esitante – con le analisi e i consigli, visti gli oneri e le responsabilità che ne derivano. Nei mesi prima della Guerra del Kippur, l’eccessiva sicurezza di Zeira lo portò a pensare che gli arabi non avrebbero osato attaccare Israele, e di conseguenza anche la premier e il governo finirono per crederci. Come disse lo stesso Zeira alla premier Golda Meir, il rischio di un conflitto era «piú basso del basso»: in pratica, pari a zero. Ma si sbagliava, e l’attacco da parte di Egitto e Siria colse il Paese quasi completamente impreparato.
Quando la guerra finí e il prezzo pagato emerse in tutta la sua gravità – non solo in termini di denaro ma anche di vite umane –, l’opinione pubblica montò in collera. Presto cominciarono a cadere delle teste, e la prima fu quella di Zeira. Una commissione nazionale d’inchiesta, guidata da Shimon Agranat, giudice capo della Corte Suprema, puntò il dito contro di lui accusandolo di essersi aggrappato ostinatamente a una convinzione errata, che aveva impedito ai leader israeliani di attaccare finché non era stato quasi troppo tardi. Zeira venne dipinto come un personaggio spregevole, il principale responsabile del disastro del Kippur. Umiliato, rassegnò le dimissioni. Secondo i pochi amici che continuarono a frequentare casa sua, a nord di Tel Aviv, era un uomo distrutto.
Negli anni seguenti Zeira mantenne un profilo basso, stando per conto proprio e rifiutando tutti gli inviti a dire la sua sulla Guerra del Kippur. A soli quarantacinque anni, era ancora giovane e pieno di energie, con un’intelligenza pronta che adoperò per trasformarsi in un uomo d’affari di successo. Nel frattempo lavorava in segreto a un libro di memorie, e quando il volume fu pubblicato, con il titolo The Yom Kippur War. Myth vs. Reality, si attivò con decisione per liberarsi della macchia del Kippur e dimostrare che la catastrofe non era stata colpa sua.
Le sue affermazioni erano di grande interesse: in qualità di direttore dell’intelligence militare, Zeira doveva sí esprimere un parere sulla probabilità di una guerra con gli arabi, e in effetti riteneva che il rischio di un attacco a Israele fosse molto basso; tuttavia la premier avrebbe potuto trascurare la sua opinione, specie perché, solo dieci giorni prima della guerra, un illustre visitatore di identità sconosciuta era andato da lei per avvertirla di un’imminente invasione araba. Golda Meir, sosteneva Zeira, aveva scelto di ignorare l’avvertimento, dunque perché accusare lui? E chi era il misterioso visitatore che aveva messo in guardia la premier? Dopo la guerra, in Israele corse voce che fosse stato nientemeno che Hussein di Giordania, arrivato apposta in elicottero a Tel Aviv per vedere Golda Meir e informarla: il sovrano temeva che in caso di guerra il mondo arabo gli avrebbe fatto pressione perché partecipasse alla lotta contro Israele, e lui non ne aveva alcuna intenzione. Ma non c’erano prove a sostegno di questa ipotesi.
Ora, nel 1998, al termine dell’intervista per la Bbc, e senza che io gli chiedessi niente, Zeira disse di potermi dimostrare in maniera inconfutabile che era stato proprio Hussein ad avvisare Golda Meir della guerra ormai vicina. Capii subito che Zeira voleva usarmi per provare che, cosí come aveva ignorato l’avvertimento del re di Giordania, la premier israeliana avrebbe potuto ignorare anche il parere dello stesso Zeira sull’impossibilità della guerra; pertanto, se il Paese non era preparato all’attacco, la colpa era solo di Golda Meir. Pensando di avere per le mani uno scoop eccezionale, fui ben contento di farmi sfruttare da Zeira, e quando mi propose di passare da lui quella sera, per esaminare e copiare la trascrizione originale del dialogo tra Hussein di Giordania e Golda Meir, non me lo feci ripetere due volte. Zeira aveva paura di finire nei guai se si fosse scoperto che la mia fonte era lui, perché la trascrizione era un documento top secret, mai pubblicato prima. Cosí, anziché riceverlo direttamente dalle sue mani, mi venne l’idea di mandare la mia assistente Nava Mizrachi a prendere nota dei paragrafi piú significativi. In questo modo, rassicurai Zeira, avrei potuto dire che non era stato lui a darmi il documento, e che lo avevo ottenuto da qualcun altro; non sarebbe stata una bugia, solo una manipolazione dei fatti.
Ecco l’avvertimento di guerra offerto da Hussein di Giordania alla premier israeliana, pubblicato per la prima volta nel 1998 nel mio libro The Fifty Years War:
HUSSEIN […] da una fonte siriana estremamente sensibile, da cui abbiamo già ricevuto informazioni in passato che poi abbiamo trasmesso3 […] tutte le unità [siriane] che dovrebbero essere impegnate nell’addestramento sono invece, da almeno due giorni, in posizione di preattacco […] pronte al...