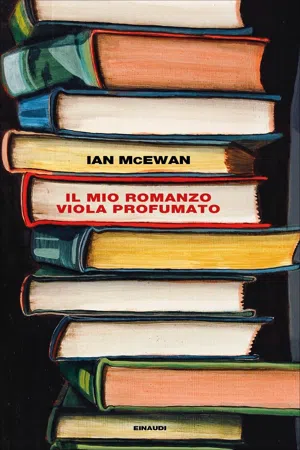Un paio d’anni fa mi trovavo a Venezia in piazza San Marco seduto davanti a una tazza di caffè e osservavo il passaggio di migliaia di turisti come me. Quasi tutti avevano un apparecchio fotografico. A decine scattavano foto non già del Palazzo Ducale tanto splendidamente descritto da John Ruskin, bensí di se stessi davanti a quel palazzo. Tenevano i cellulari il piú lontano possibile o si facevano aiutare da appositi estensori. Le meraviglie di Venezia non erano complete senza la testimonianza di un io in mezzo a loro. Guardatemi, sono qui. Molti tra quei turisti, specie i piú giovani, sarebbero andati su Facebook il giorno stesso per far conoscere al mondo le gesta dei loro insostituibili, specialissimi io. Quanto al sottoscritto, a mia volta avevo trascorso la mattinata a contemplare autoritratti del XVI e XVII secolo, in svariati musei. Che cos’è dunque un io, un’entità biologica incontrovertibile o per certi versi invece un prodotto culturale, affinato dall’arte e dalla letteratura in modo particolare? Non c’è dubbio infatti che nella letteratura di un passato premoderno, l’io non rappresentasse affatto un tema di rilevanza primaria. In un’era come la nostra, che idolatra la celebrità e l’autopromozione attraverso la rete, stiamo forse vivendo il colmo di quel che significa essere un io.
Esiste un altro ente mentale che raggiunga i livelli di paradosso dell’io? Di una schiacciante ovvietà da un lato, ma fastidiosamente inafferrabile dall’altro. Ogni mattina, svegliandoci, ce lo calziamo addosso, o viceversa l’io indossa noi, come un paio di scarpe comode. Anzi, per la precisione, ci svegliamo e ci ritroviamo già quelle scarpe ai piedi. Nemmeno nel sonno sfuggiamo pienamente all’io che, nei nostri sogni, svolge un ruolo di testimone o di ente attivo, spesso entrambe le cose. Eppure siamo in difficoltà a definirlo, questo io. Di certo lo sono i filosofi. E il compito di descriverlo, di comunicarlo ad altri io − nei quali per definizione non potremo mai penetrare − è questione complessa, immancabilmente incompleta che, come andrò a sostenere tra poco, è approdata nella nostra letteratura in modo sistematico, consapevole ed esteso solo agli albori dell’era moderna, con il che intendo grosso modo il XVI secolo. Laddove con «nostra» assumo una prospettiva genericamente eurocentrica che affonda le proprie radici nel mondo greco-romano. Per la letteratura del mondo intero il mio cervello non basta.
Potremmo essere tentati di far coincidere l’io con la coscienza stessa, ma sappiamo che l’aderenza non sarebbe perfetta: non tutte le parti dell’io ci risultano costantemente attingibili. La coscienza comporta senza dubbio la consapevolezza dell’io, e l’identità accoglie tutto ciò che la coscienza ha da offrire, ma continua a non essere l’io, almeno non l’io propriamente detto. Né d’altra parte lo è il carattere, coi suoi tratti in terza persona, utile per la descrizione degli altri, o per comprenderne e prevederne il comportamento, ma privo della qualità soggettiva, percepita, del sé. Se è di sinonimi approssimativi che siamo in cerca, questi non mancano di sicuro: il cuore, l’anima, la mente, l’individualità.
Pensiamo alla frequenza con cui la lingua ricorre a espressioni come autostima, autocritica, autoaccusa, autoreferenzialità, autolesionismo: l’elenco è assai lungo e non può che essere il prodotto linguistico di altri io, ovviamente. Quando Bob Dylan canta «Yer gonna make me give myself a good talking» rivolgendosi all’amata che lo sta lasciando, noi capiamo bene cosa intende. E sappiamo anche che a fare e ad ascoltare la chiacchierata di cui parla sarà per forza lo stesso io.
I neuroscienziati insistono che non esiste nel cervello nessun luogo deputato a ospitare l’io, quello che era stato il ruolo della ghiandola pineale nella descrizione cartesiana dell’anima. Nessun homunculus acquattato e guardingo dentro di noi. Al contrario, sembra che l’io sia piuttosto ovunque e in nessun luogo nel cervello, spalmato su vaste e complesse reti neurali. È tuttavia assodato che i traumi subiti dalla corteccia prefrontale possono causare alterazioni profonde nella percezione soggettiva dell’io. Lesioni che compromettono o addirittura cancellano la memoria autobiografica devasteranno massicciamente la struttura dell’identità, suggerendo l’idea che tempo, memoria e continuità siano elementi essenziali di quel che significa essere un io.
Con il che ci inoltriamo in un altro territorio controverso. L’io come forma narrativa, come storia che raccontiamo a noi stessi, costituisce l’ortodossia contemporanea. Nessuno ha scritto in proposito meglio né piú esaustivamente del filosofo Galen Strawson. Stando alla sua analisi, non mancano di certo sostenitori convinti e autorevoli, tanto in campo umanistico quanto in ambito psicoterapeutico, della teoria secondo la quale ciascuno di noi sarebbe il testo che personalmente compone. Qualche esempio di dichiarazione «narrativista» secondo Strawson: «Ciascuno di noi costruisce e vive una “narrazione” […] noi siamo tale narrazione», dice Oliver Sacks; «l’io è un racconto incessantemente riscritto», scrive Jerome Bruner in The Remembered Self; e ancora, da svariate altre fonti accademiche: ciascuno «crea la propria identità dando forma a una narrazione autobiografica»; siamo tutti «romanzieri esperti e raffinati»; «il protagonista d’invenzione al centro dell’autobiografia è l’io».
Uno degli aspetti seducenti di questa visione è che conferisce al soggetto un lusinghiero livello di efficacia performativa. Ci sentiamo corroborati al pensiero di essere costruzioni volontarie di noi stessi. La romanziera americana Mary McCarthy ebbe a scrivere: «prima o poi cominciamo in un certo senso a scegliere e a inventarci l’io che vogliamo».
Va da sé che l’idea di un io autoriale incanta i romanzieri. Ci sentirete alle tavole rotonde dei vari festival di letteratura sostenere regolarmente che siamo, tutti senza esclusione, piú di ogni altra cosa, creature narranti, che mettiamo al mondo noi stessi scrivendoci e che, in assenza di questo racconto dell’io, andremmo incontro a una sorta di decesso mentale e all’inevitabile dissoluzione della nostra umanità. Vale tuttavia la pena ricordare che i romanzieri sono pagati per inventare storie.
Personalmente, per un discreto lasso di tempo, sono stato un «narrativista» poco convinto in occasione di quelle tavole rotonde. Sentivo che avrei dovuto mostrare una partecipazione piú solidale ed entusiastica. Il mio disagio aveva ben due ragioni di essere. Prima di tutto, un certo scetticismo nei riguardi del libero arbitrio neces...