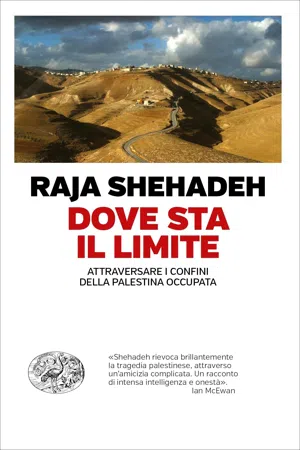Circa due mesi dopo l’inizio della prima intifada, ci trovavamo in una saletta riunioni tutti insieme, lo staff di Al-Haq al gran completo e io, per parlare delle sparatorie, dei pestaggi, degli arresti, del coprifuoco, della demolizione di case e delle sanzioni economiche che si stavano verificando in Cisgiordania. Da quando il ministro della Difesa, Yitzhak Rabin, come un padre severo che rampogna i figli indisciplinati, aveva proclamato la sua politica di «forza, potenza e percosse», il nostro consueto modo di operare era diventato obsoleto.
Per molti anni avevamo preso in parola il governo israeliano, quando affermava di non violare deliberatamente i diritti umani come prassi e definiva gli abusi «un’eccezione». Consapevoli dello scetticismo con cui l’opinione pubblica internazionale avrebbe accolto quanto un’organizzazione palestinese aveva da dire su Israele, sottoponevamo i dossier delle violazioni alle autorità israeliane, le quali rispondevano mettendo in discussione le nostre tesi o giustificando le proprie azioni. Sostenevano che erano coerenti con la legge. Spesso asserivano che si trattava di azioni necessarie per la sicurezza. Come potevamo ora appellarci a un governo che aveva dichiarato nel modo piú inequivocabile possibile che i suoi agenti avrebbero usato la forza? Un governo i cui soldati avevano sparato, nelle prime due settimane dell’intifada, circa un milione e 200 000 proiettili (quasi 100 000 al giorno) con cui avevano ucciso svariate decine di palestinesi e ne avevano feriti molti di piú?
Come potevamo immaginare che sarebbe venuto un giorno in cui migliaia di soldati avrebbero traversato città, villaggi e campi profughi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, infrangendo tutte le norme accettate sui diritti umani, fermando i passanti per umiliarli, percuoterli o arrestarli, sparando sui dimostranti disarmati e imponendo lunghi coprifuoco a intere comunità, dietro precisi ordini dei loro ufficiali e politici di piú alto grado? A che serviva produrre un altro dossier, quando questo stato di cose era ben noto in tutto il mondo? Qual era il ruolo di un’organizzazione per i diritti umani in un momento come quello?
Mentre le nostre discussioni si protraevano senza giungere a una conclusione, udimmo un forte grido proveniente dalla strada. Ci alzammo all’istante e corremmo sul balcone.
C’erano due soldati nella via, di fronte al nostro palazzo.
– Cos’è successo? – chiese ad alta voce Jonathan Kuttab, condirettore di Al-Haq, in ebraico.
I soldati non risposero, ma fecero cenno a tre commilitoni posizionati proprio sotto il nostro balcone. I cinque proseguirono. Poi vedemmo un giovane emergere dalla porta del nostro palazzo con in mano la spesa in un sacchetto di plastica. Aveva il viso insanguinato.
Riziq, uno dei nostri ricercatori, scese di corsa i tre piani di scale per raggiungerlo. Lo seguimmo tutti. Mentre scendevamo, vedemmo una piccola pozza di sangue su uno dei pianerottoli.
Il giovane era scomparso. Riziq entrò in una palestra, dall’altro lato della strada, per chiedere se qualcuno l’aveva visto. Era una stanzetta mal ventilata che puzzava di sudore, piena di giovani impegnati a sollevare pesi e addestrarsi nell’autodifesa. Dissero che non l’avevano visto.
Ora per le strade era buio. In giro non c’era anima viva. Riziq provò in altre case e alla fine trovò il giovane. Accompagnò lui e suo fratello alla sede di Al-Haq. Le nostre macchine fotografiche erano pronte a documentare le ferite che aveva subito. Mentre alcuni di noi cercavano di medicarlo, il giovane imprecava a gran voce, e cosí faceva il fratello, ma la loro rabbia era indirizzata contro di noi.
– Diritti umani? Se dei soldati possono malmenare un uomo sulle vostre scale e voi non siete in grado di intervenire, a che servite? – dicevano.
Restammo in silenzio.
Il giovane ci spiegò che stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa, quando si era imbattuto in cinque soldati vicino al portone del nostro palazzo. Dovevano aver pensato che l’edificio fosse vuoto, perché l’avevano costretto a entrare a spintoni, poi avevano lasciato cadere qualcosa sul pavimento e gli avevano intimato di raccoglierlo. Quando si era chinato, uno dei soldati gli aveva dato un calcio in faccia. Era stato quello il momento in cui aveva gridato. Non avevano ancora finito, ma sentendo del movimento ai piani superiori si erano fermati e l’avevano lasciato andare.
Ora conoscevamo i fatti: era un esempio di come venivano messe in pratica le politiche di Rabin. Io e Jonathan lasciammo gli altri in sede e decidemmo di andare in cerca dei soldati. Li raggiungemmo alla rotonda di Manara, nel centro della città, dove avevano fermato un altro giovane. Ci riconobbero.
– Abbiamo visto cosa avete fatto, – dicemmo.
– Cosa avete visto? – chiese uno dei soldati piú giovani.
A quel punto intervenne un soldato alto con i baffi spioventi e chiese: – Voi chi siete?
Ci presentammo.
– Cosa volete? – chiese ancora.
– I vostri nomi e il nome della vostra unità.
Ci guardò con tutta l’autorità del soldato che sa di avere la legge dalla sua parte. Ci sventolò il manganello davanti agli occhi e disse: – Se non ve ne andate all’istante, vi arresto. State intralciando il nostro lavoro.
Inspirai a fondo. Mi sembrava di stare per esplodere.
Decidemmo poi di provare con il commissariato di polizia, e ci mettemmo in macchina. Percorremmo le strade buie e deserte, sotto i lampioni arancio. Era la città dov’ero cresciuto. Come aveva fatto a cambiare cosí tanto? Mi sembrava cosí diversa, ora, infestata di criminali con licenza di ferire e persino di uccidere.
Parcheggiammo l’auto in una stradina laterale e proseguimmo a piedi alla volta del commissariato della polizia israeliana, nel centro di Ramallah. Un alto pino scuro incombeva su di noi. Era la strada che portava alla mia scuola di un tempo. Questa era la buganvillea accanto alla quale passavo ogni giorno, andando e tornando dalle lezioni. Perché ora aveva un’aria cosí minacciosa?
Vedemmo un soldato che faceva i suoi bisogni in piedi, accanto al commissariato, il viso sfacciatamente girato verso di noi. Un pullman carico di altri soldati era parcheggiato lí a due passi. Accanto c’era una jeep dell’esercito. I soldati dovevano essere almeno una quarantina in totale. Io e Jonathan eravamo gli unici civili, ma i soldati non ci prestarono la minima attenzione. Dal pullman provenivano delle voci. Stavano scandendo «Rotseem cola [Vogliamo una cola]». Altri soldati entravano e uscivano dall’edificio. Si sentivano delle urla provenire dall’interno. Sembrava un incubo.
– Voi chi siete? – ci chiese un ufficiale.
Volevo andarmene da quell’Israele in miniatura e tornare nella mia città palestinese, ma non potevo. Non volevo che Jonathan rispondesse. Avevo paura. Non era il momento di dire che eravamo avvocati, non era il momento di mettere alla prova il sistema.
– Andiamo via, – dissi a Jonathan.
Lui rimase dov’era. Disse al soldato chi eravamo e perché eravamo lí: per sporgere denuncia.
Denuncia: firmare moduli, fornire una dichiarazione, rilasciare nomi, cognomi e credenziali, fare in modo che i poliziotti indagassero sulla scena del reato. A che scopo? Si sarebbero dati la pena anche solo di scrivere qualcosa?
Ma Jonathan insisteva. Ripeteva all’ufficiale che eravamo stati testimoni di un reato penale. Avevamo visto i colpevoli. Eravamo venuti a denunciare l’accaduto. Volevamo sporgere formale denuncia, per avviare un’indagine della polizia.
Nel frattempo i soldati sul pullman continuavano a scandire «Vogliamo una cola, vogliamo una cola», ora con il martellare dei pesanti scarponi sul fondo del mezzo come accompagnamento.
– Fatemi un favore, andate via, – disse l’ufficiale. – Sparite! – urlò, spingendoci.
Ce ne andammo. Non avevamo scelta.
Fu nello stesso edificio, il commissariato di Ramallah, che dodici anni dopo due soldati israeliani sarebbero stati linciati durante la seconda e piú violenta intifada. L’esercito israeliano, come ritorsione, fece saltare la costruzione di epoca ottomana con una bomba da una tonnellata sganciata da un grosso elicottero da combattimento. Il commissariato fu ridotto in macerie, la buganvillea distrutta.
Al momento, però, quella visita al commissariato di Ramallah fu seguita da giorni di grande intensità, pieni di emozioni forti e della determinazione a fare tutto quello che potevamo.
Andavo a pranzo da mia madre piú che altro per tenerle compagnia. Quasi quattro anni prima, mio padre, mentre stava rincasando dall’ufficio, era stato assassinato sul vialetto di casa da un collaborazionista al soldo di Israele. Per quanti sforzi avessimo fatto per spingere le autorità israeliane a indagare a fondo e ad assicurare il colpevole alla giustizia, non era valso a nulla e nessuno era mai stato incriminato per l’omicidio di mio padre. Anche se quell’evento tremendo era avvenuto quattro anni prima, mia madre era tuttora inconsolabile. La polizia israeliana non aveva ancora arrestato l’assassino. Ma avevo il sospetto che il governo provasse sollievo per la morte di un moderato come mio padre, un fautore della pace. La sua morte, per me, segnò la fine delle speranze di una soluzione pacifica.
Avevo fatto tutto quello che potevo per far aprire l’indagine e portarla avanti. Mia madre stava sprofondando nella propria disperazione. Temevo, se non fossi stato attento, che mi avrebbe trascinato con sé. Dopo uno dei nostri pranzi, sonnecchiavo al sole sul divano nella veranda a vetri. Di tanto in tanto davo un sobbalzo con la testa, risvegliandomi dai sogni e dalla sensazione della paura. Ero pieno di rabbia. Mi mettevo a rimuginare sulle piú vaste implicazioni del conflitto e sulle mie reazioni.
Israele combatteva per tenersi questa terra. Noi combattevamo per porre fine all’occupazione secondo le leggi internazionali, che ci davano il diritto di resistere. È cosí che la vedevo. Sapevo che avrei potuto farmi trascinare in una battaglia piú aspra, che avrebbe provocato ulteriori spargimenti di sangue e sofferenze. Avrebbe richiesto maggior resistenza di quella di cui ero stato capace fin lí. Non potevo continuare a essere solo un osservatore. La mia rabbia, il mio senso del dovere e della giustizia non me lo permettevano.
Eppure, combattere in quel modo non era il mio ruolo, lo sentivo. Io avrei dovuto scrivere. Era bello prendere parte a una lotta comune, ma sapevo di dover stare attento alla misura in cui mi sarei concesso di lasciarmi coinvolgere. Non mi fidavo della mia capacità di mantenere il controllo. Non potevo fidarmi, non sapevo se sarei stato capace di affrontare tanta crudeltà rimanendo sano di mente. Alla fine di ogni giorno mi sentivo sfinito. Tornavo a casa, nel mio monolocale, rimanevo seduto al buio per un po’, poi facevo la doccia, mettevo il pigiama e mi dedicavo ad aggiornare il mio libro, Occupier’s Law, sulle implicazioni dell’occupazione sul piano legale e su quello dei diritti umani.
Il giorno dopo quello passato a tormentarmi a casa di mia madre, andai alla sede centrale dell’Amministrazione civile israeliana per la Cisgiordania, a Beit El, per seguire due casi di violazione di marchi registrati. Le questioni relative alla proprietà intellettuale erano parte dell’attività commerciale del nostro studio. Lungo il tragitto, pensai a quanto dovesse apparire strano a chi non viveva qui il fatto che, anche in un periodo cosí travagliato, si continuasse a lavorare su problemi banali come la registrazione di un marchio. Mi ero sempre chiesto come affrontasse mio padre i casi di controversie condominiali nel suo studio di Jaffa poche settimane prima della Nakba. Eppure, finché le catastrofi non avvengono, la vita va avanti. I registri dei tribunali dell’epoca del mandato britannico mostrano che si erano tenute udienze di ogni genere fino all’ultimo momento possibile. Come potevano le persone preoccuparsi tanto delle loro dispute piú banali, mentre le loro vite stavano per essere ribaltate da cima a fondo? Del resto, come avrebbero potuto sapere cosa stava per accadere?
All’ingresso, un giovane soldato ascoltava musica jazz. Intorno a sé aveva riviste di jazz in inglese e in ebraico. Il volume della radio era molto alto. C’era un altro soldato, piú grande di età, con la barba. Aveva l’aspetto truce e camminava avanti e indietro, con aria annoiata.
– Chiudi la po...