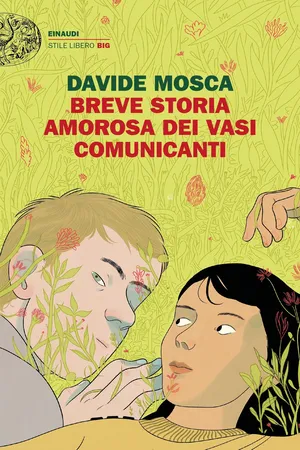Il cellulare vibrò verso mezzanotte. Era silenzioso, ma vedevo la luce pulsare nell’oscurità della stanza. Mi piaceva rimanere seduto per terra, al buio, con le finestre aperte, a osservare la sagoma del mare. Mi ricordava che c’era sempre la possibilità di fuggire, passare la frontiera, ricominciare daccapo.
Non era mia mamma, non era Alex.
– Dormivi? – esordí Margherita. Era lei.
– Guardavo fuori dalla finestra.
– Che cosa c’è?
– Il Messico, credo.
– Ti sbagli, c’è Genova. Domattina mi piacerebbe andarci per visitare le varie università. Ti andrebbe di accompagnarmi in auto?
Mi intrigava quel suo continuo mettermi di fronte a bivi, alcuni semplicemente accennati. Potevo accettare o meno, andare in un senso o in un altro, ma avevo sempre la premonizione che da quella semplice scelta in qualche oscuro modo sarebbe dipesa la mia vita. E io avevo un disperato bisogno di sentirmi in bilico, di poter imboccare una strada o l’altra, perché allora significava che c’era, una strada, mentre in tutti quei mesi trincerato in casa e nel mio corpo non c’erano state alternative di alcun tipo, se non quella tra mangiare o non mangiare. Ora mi godevo il brivido della possibilità, il rischio dell’esistenza.
Prima o poi abbiamo tutti l’impressione che qualcosa ci chiami su una strada. Era bello tornare a percepire quel genere di voci. Margherita era la mia.
– Non sto cercando un autista, – disse, dato che io non rispondevo, perso nelle mie suggestioni. – È che…
– Ti accompagno volentieri. Ci siamo lasciati male con Genova. Magari facciamo pace.
– Come si fa a litigare con una città?
– A te non è mai capitato?
– Sono sicura che rimedierò.
La mentalità dei genovesi mi ha sempre affascinato. C’è la loro città, e poi il resto del mondo. Non esiste nemmeno la provincia, figurarsi l’Italia o addirittura l’Europa. Quando la Liguria ha smesso di essere una colonia, per Genova è diventata di colpo terra straniera. Per questo motivo mi sono sempre sentito forestiero per le sue strade acciottolate e sconnesse, sebbene ci abbia studiato e lavorato.
– Ma a me piace sentirmi forestiero, – spiegai a Margherita. Avevamo parcheggiato in prossimità del Mandraccio, il porto vecchio, ed entravamo in città per la turrita Porta dei Vacca. – Lo sapevi che Genova possiede il centro storico piú grande d’Europa?
– Non credo lo sappia nessuno.
– È cosí superba che non si degna nemmeno di vantarsi.
– Ora capisco.
– Cosa?
– Ne parli come di una ex fidanzata.
Mentre rimbalzavamo da una segreteria all’altra, in cerca di informazioni che nessuno pareva possedere, notavo dal titillio dei tendini che il suo nervosismo lievitava, un’irascibilità che era sempre parte di quell’attrito perenne tra lei e il mondo.
Provavamo lo sconforto crescente di chi si trova a porre domande in una lingua e a ricevere risposte in un’altra. Infervorata, cercava di districarsi tra corsi, discipline, orari, regole e tasse. Il maggiore cruccio era la regolamentazione per gli studenti lavoratori, che ogni segreteria pareva ignorare, come se si trattasse di un caso raro – perché mai un universitario avrebbe dovuto lavorare a tempo pieno e voler frequentare le lezioni?
– Il diritto è dunque un diritto dei ricchi. I poveri fessi che devono lavorare non hanno diritti invece? – disse a una segretaria.
La trascinai via, prima che la situazione degenerasse. – Se dovessi sommare tutte le ore in cui ho campeggiato nelle varie segreterie durante le pratiche per i miei passaggi da una facoltà all’altra, credo che arriverei tranquillamente a un paio di settimane. Forse un mese, – le dissi per distrarla.
– Un mese ad annoiarti a morte.
– Dipendeva dal libro che leggevo nell’attesa.
Facemmo su e giú per palazzi cinquecenteschi e cortili rinascimentali, con tappe regolari nei bar per quella che era diventata la nostra ordinazione classica: due caffè e un bicchiere di acqua frizzante, a cui lei non rinunciava mai. Mi piaceva fare quell’ordinazione senza nemmeno il bisogno di consultarla: mi dava una sensazione di segreti condivisi, di famigliarità, di lunga frequentazione. Entrambi lo prendevamo amaro, il caffè. Io per piacere, lei per dovere.
Verso l’una la vidi agitarsi. – Avrai fame, immagino. Vorrai mangiare –. Lo disse come se si trattasse di una sciagura.
– Non è un problema. Facciamo una passeggiata a caccia di bellezza? Siamo stanchi di uffici.
– Stufi marci, siamo. Conosci un posto?
Ne conoscevo diversi. Avrei voluto rivedere luoghi ameni dove ero stato per la maggior parte del tempo triste. Volevo fare la pace con la città e con quello che ero stato, rimettere a posto il terreno su cui ero poi franato. Piú di ogni cosa volevo un panorama, ritagliare cartoline da portarmi appresso.
Salimmo verso l’Albergo dei Poveri, il seicentesco edificio nato per accogliere i bisognosi, dove avevo frequentato i primi anni della facoltà di Giurisprudenza, che lí era stata parzialmente e temporaneamente ospitata in uno dei ciclici tentativi di recuperare quel meraviglioso e inutile palazzo, monumento alla carità e al fallimento.
A metà strada mi pentii, perché la salita era ripida e io faticavo. Il sudore mi correva in rivoli lungo la schiena. Dopo la scarpinata dell’Appennino ligure, un’altra scalata. Gli esseri umani non fanno mai molti errori, ma lo stesso errore molte volte. A ogni manciata di metri mi fermavo con la scusa di ammirare il panorama e raccontare storie. Per fortuna la mia scorta di storie non finiva mai, come la sua pazienza.
Quando arrivammo in cima boccheggiavo, la gola secca e le ascelle pezzate. Cercavo di tenere le braccia attaccate al corpo e le parlavo con la testa leggermente spostata di lato, temendo per il mio alito.
Superammo le aule ancora in uso, ormai appena una manciata, e attraverso una porta difettosa entrammo nella parte del complesso che non era stata recuperata. Vagammo per i saloni deserti e abbandonati. – È un posto buono per i fantasmi.
– Non ti piace?
– Mi sento a casa.
Visitammo anche la chiesa annessa all’edificio. Altari di marmo biancheggiavano nell’oscurità.
– Sei credente?
– Quando chiedevano a Jung se credesse in Dio, lui rispondeva: «Io non credo, io so».
– Tu sai?
– No, io credo, – dissi facendole l’occhiolino.
All’uscita scendemmo per la Valletta, il giardino incolto dove sprazzi di bosco insidiavano le serre che crogiolavano al sole. Ci sedemmo sotto un pino marittimo. Guardavamo la città in silenzio, una cascata di palazzi che ruscellavano verso il mare.
– Studiavi quassú?
– I primi anni di Giurisprudenza.
– E poi?
– Sono passato a Lettere.
– Andavi bene a Giurisprudenza?
– Media del ventinove. È bene?
– Abbastanza. Pensavo di piú.
– Di piú c’è solo il trenta.
– Appunto. Quanti esami ti mancavano quando hai cambiato?
– Cinque.
– E allora perché hai cambiato?
– Ventinove, cinque, trenta… non volevo una vita di numeri. La volevo di lettere. Volevo fare lo scrittore.
– E non potevi prima finire gli studi? Lasciarti la strada aperta?
– Volevo chiuderla, semmai, – dissi. Ciò che avevo iniziato all’epoca l’avevo terminato durante il mio annus horribilis. Abbandonare ogni porto sicuro, nell’inconsapevole credenza che nessuno può scoprire nuovi mondi, se non accetta di perdere di vista la terraferma. – Credevo che se avessi imboccato la carriera avvocatizia avrei abbandonato la mia vocazione, perché per scrivere ci vuole una certa fame e io avrei finito per saziarmi del mio lavoro e delle soddisfazioni sociali ed economiche. Feci come quelli che prima di migrare bruciano la propria casa per essere certi di non tornare indietro alle prime difficoltà. Solo che io tornai.
Pareva divertita. – Davvero?
– Sí, dopo una manciata di esami a Lettere mi dissi che ero stato un imbecille e un pusillanime a non terminare Legge. Cosí mi presentai in segreteria, ma mi dissero che i termini erano scaduti. Dovetti brigare tra cavilli e sofismi con l’aiuto di un professore che mi aveva preso in simpatia. Ma alla facoltà di Legge era dura brigare. Ci tenevano alla forma. Fui ammesso, ma non avrei avuto accesso alle sessioni di esami prima di sei mesi. Li passai a intristirmi e a studiare.
– E poi?
– Al momento di perfezionare la nuova iscrizione per sostenere i due esami che avevo preparato, ero cosí triste che lasciai perdere –. Mi avevano chiamato dalla segreteria, forse su insistenza del mio professore. Adesso può iscriversi, mi avevano detto. Adesso non posso piú, avevo risposto. – Mi sentivo sovraccarico di una strana energia, ma era veleno. Mi ero avvelenato.
– Non c’è il lieto fine in questa storia, vero?
– C’è la parte buffa. Ho trenta esami e nemmeno una laurea.
Mi guardò con quella sua seducente aria miope. Il mondo sembrava sempre fuori fuoco ai suoi occhi. – Ho chiesto un consiglio sull’università alla persona giusta, – mi disse bussandomi sul ginocchio.
Il suo tono era leggero, non sarcastico. Intendeva dire proprio quello che aveva detto.
Gli appuntamenti capitavano. Ci vedevamo al bar Atene, al suo ristorante, in giro, quasi sempre senza stabilirlo prima.
La settimana dopo tornammo insieme a Genova. Parcheggiamo al porto come la volta precedente e imboccammo l’universitaria via Balbi con il passo sicuro degli indigeni, che già possedevano geografie e ricordi comuni.
Se torni in un posto con la stessa persona significa che c’è una direzione, per quanto ignota. È proprio il ritorno a caratterizzare ogni partenza. Tornare al punto di partenza per vederlo con occhi nuovi. È quello che ci succederà quando torneremo in paradiso, pensavo.
Sbrigammo le procedure con inaspettata e relativa facilità. Lei si iscrisse a Filosofia, dopo avermi parlato per ore di criminologia, salvo scoprire che non esisteva, o non proprio. – Sempre di menti malate mi occuperò, – fu il suo commento alla mia debole osservazione.
Invece io avviai il passaggio a Storia, dove parevano felici di accogliermi. Dopo quel limbo di un paio d’anni, decisi di rimettermi alla ricerca di storie e saghe.
Il sole tagliava via Balbi in due strisce parallele. Scendemmo per il lato in ombra. Prendemmo un paio di birre per festeggiare. Le bevemmo sugli scalini della chiesa dell’Annunziata, guardando, oltre la rotonda, il mare luccicare tra i palazzi antichi e i nostri prossimi mesi, forse anni.
– Che stai guardando? – mi chiese.
– Quello che guardi tu, il futuro.
– E cosa vedi nel futuro? – Sembrava scorgere in me qualcosa che io stesso ignoravo. Mi faceva sentire migliore di quanto non fossi, piú vivo.
– Platone diceva che se guardi nella parte migliore dell’altro, ossia la pupilla, vedi la tua immagine riflessa.
– E questo cosa vuol dire?
Questa volta fui io a bussare sul suo ginocchio. – Lo chiedo a te.