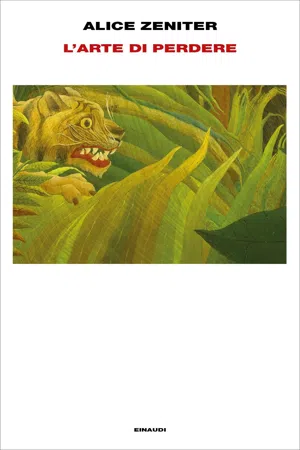Non ricordo piú come cominci l’Eneide, quali siano le prime avventure di Enea e dei suoi compagni quando lasciano Troia – o piuttosto il luogo dove in passato sorgeva Troia e dove restano solo macerie, odore di sangue e di fumo. Ricordo solo il primo verso che ho tradotto come esercizio di versione latina ormai piú di dieci anni fa: Arma virumque cano… Canto le armi e l’eroe. Suppongo che dopo ci fosse una proposizione relativa, «l’eroe che…», grazie alla quale si dipanava tutta la vicenda, ma mi sono rimaste in mente solo queste tre parole. Nonostante il silenzio in cui si è trasformato quel lungo poema intessuto di peripezie, è ovvio che alla fine del suo faticoso vagabondare Enea arriva nel Lazio e che la sua stirpe vi fonderà Roma.
Tra il momento in cui Alí mette piede in Francia, nel settembre del 1962, e quello in cui Naïma si rende conto di non conoscere la storia della sua famiglia piú di quanto io mi ricordi dell’Eneide che cosa accade? Una vicenda senza eroe, forse. Una vicenda che – comunque – non è mai stata cantata. Comincia in un riquadro di tela e di filo spinato.
Il campo Joffre – chiamato anche campo di Rivesaltes – dove, dopo i lunghi giorni di un viaggio insonne, arrivano Alí, Yema e i loro tre figli è un recinto pieno di fantasmi: quelli dei repubblicani spagnoli che sono scappati da Franco per finire parcheggiati lí, quelli degli ebrei e degli zingari che Vichy ha rastrellato nella zona libera, quelli di alcuni prigionieri di guerra di varia origine che la dissenteria o il tifo ha falciato lontano dalla linea del fronte. Dall’epoca della sua creazione, trent’anni prima, è un luogo dove vengono rinchiusi coloro di cui non si sa che fare, nell’attesa, ufficialmente, di trovare una soluzione, nella speranza, ufficiosamente, di potersene dimenticare finché non scompariranno da soli. È un luogo per gli uomini che non hanno Storia perché nessuna delle nazioni che potrebbero offrirgliene una vuole accettarli. Oppure un luogo per coloro a cui due Storie attribuiscono status contraddittori, come le migliaia di uomini, donne e bambini che ha accolto a partire dall’estate del 1962.
L’Algeria li chiamerà ratti. Traditori. Cani. Terroristi. Apostati. Banditi. Impuri. La Francia non li chiamerà affatto, o ben poco. La Francia si cuce la bocca circondando di filo spinato i campi di accoglienza. Forse è meglio che non li chiami. Nessuno dei nomi proposti può designarli. Gli scivolano addosso senza riuscire a dire di loro un bel niente. Rimpatriati? Il paese in cui sbarcano molti non l’hanno mai visto: come sostenere, quindi, che ci ritornano, che tornano a casa? E poi questo nome non li differenzierebbe dai pied-noir, che esigono di essere distinti da quella massa scura e crespa. Francesi musulmani? Significa negare che fra loro ci sono atei e persino qualche cristiano e non dice nulla della loro storia. Harki?… Curiosamente è il nome che gli resta attribuito. Ed è strano pensare che una parola indicante in origine «movimento» (harka) si fissi lí, nel posto sbagliato e a quanto pare per sempre.
Gli harki propriamente detti, cioè le truppe inquadrate in harka – specie di detentori di un contratto paramilitare a tempo determinato rinnovabile, come Naïma capirà in seguito –, costituiscono solo una parte delle migliaia di persone che popolano il campo. Stanno gomito a gomito con i moghazni che lavoravano per le Sas (sezioni amministrative specializzate) o le Sau (sezioni amministrative urbane), i membri dei Gms (gruppi mobili di sicurezza) e dei vecchi Gmpr (gruppi mobili di polizia rurale) chiamati familiarmente Jean-Pierre, gli abitanti dei Gad (gruppi di autodifesa, a cui l’esercito francese aveva consegnato fucili e bombe a mano per proteggere il loro villaggio), gli «ausiliari musulmani» dello Stato francese (caid, cadí, amín e guardie campestri), gli eletti locali, i piccoli funzionari, i militari di carriera, i Pim (prigionieri internati militari, uomini del Fln catturati dall’esercito che venivano costretti a prendere parte agli attacchi sotto stretta sorveglianza), i marabutti, i capi di zàuia, le scuole religiose… E a questo battaglione maschile già eterogeneo va aggiunto l’insieme delle famiglie che sono anch’esse arrivate lí, donne, bambini, vecchi. Tutti ormai designati con il termine harki.
Il figlio del fornaio è un fornaio?
Un parrucchiere che cambia lavoro è sempre un parrucchiere?
Chi vende abiti è un sarto, con la scusa che i due mestieri si assomigliano?
Il campo è una città precaria, cresciuta nella fretta sulle macerie dell’utilizzazione precedente, le nuove baracche appena assemblate sono già insufficienti. Ogni giorno, o piuttosto ogni notte, poiché i trasferimenti avvengono in segreto, il campo si riempie sempre piú, alimentato dal flusso continuo dei camion coperti arrivati direttamente dalle città di Marsiglia o di Larzac, che vengono svuotate per evitare la catastrofe umanitaria. In autunno quella città di fragilità e di emergenza, quella città popolata di gente perduta, conta quasi diecimila abitanti, ed è quindi la seconda del dipartimento, subito dopo Perpignan.
Hamid e la sua famiglia percorrono un corridoio di tende che si socchiudono per lasciar comparire facce curiose e stanche. Gli sguardi insistono e indugiano, squadrando i loro lineamenti, valutando la dimensione dei fagotti che Alí porta sottobraccio. Hamid e Dalila, irritati da quella schiera di occhi aguzzi, fanno le linguacce agli osservatori. Kader, spaventato, piagnucola fra le sottane di Yema. Ben presto anche loro li imiteranno: occhieggeranno i nuovi arrivati nell’attesa di una sagoma nota o nella speranza che il suo bagaglio contenga una delle troppo numerose derrate che lí mancano.
Quando un soldato indica la tenda dove possono «sistemarsi» (la voce del soldato esita e si affievolisce nel pronunciare quella parola), Alí dice:
– Grazie, signore.
Non è possibile a Rivesaltes dimenticare la guerra da cui sono fuggiti. Tutto la ricorda. I rituali del campo, la sua durezza, le sue recinzioni sono emanazione dell’esercito. Le famiglie, ufficialmente «in transito», sono spossessate della libertà di movimento. «Sarà opportuno sottoporre le uscite e le entrate a una certa sorveglianza; le uscite saranno autorizzate solo per gravi motivi», ricorda Pompidou in una nota. Ciò che Alí balbetta nel suo francese frammentario non è mai «grave» per i militari ai quali si rivolge. La pantomima con cui cerca di colmare le lacune linguistiche lo scredita. Allora rimane lí, nel recinto di Rivesaltes, tentando di abituarsi a quel ritmo di vita imposto, tentando di dare alla famiglia l’immagine di un uomo forte mentre non è piú responsabile di nulla, nemmeno degli infimi dettagli della vita quotidiana.
Al mattino assistono all’alzabandiera, accompagnato da una tromba goffa e bolsa, e in piedi al freddo guardano il vessillo tricolore salire cigolando lungo l’asta metallica. I pasti sono annunciati da una sirena amplificata dagli altoparlanti appollaiati in cima a pali. Allora si vedono uscire dalle tende o dalle baracche di lamiera e cartone che non proteggono affatto (e soprattutto non dal vento, quel vento tenace che entra dentro la testa, quella tramontana il cui nome affascina Hamid quanto lo irrita il suo soffio) orde di nullafacenti con in mano una gamella di alluminio. Ci sono regolari distribuzioni di vestiario, stracci scaricati a palate su teloni messi per terra, per vestire migliaia di intirizziti colti alla sprovvista dal fango e dal freddo.
Nei corridoi fra le tende i bambini si sono riuniti in bande e misurano la loro altezza ai fili spinati che circondano il campo. Hamid supera di poco il quarto. Kader sfiora a malapena il terzo. Durante la giornata a volte si può sentirli ridere, vederli passare di corsa fra le baracche, come uno stormo di uccelli selvatici, ma quando la luce cala, quando il cielo si spegne, i suoni di Rivesaltes si trasformano.
Le notti del campo sono un teatro d’ombre e di grida. È come se orchi invisibili percorressero i corridoi, penetrassero nelle tende e stringessero le loro grosse mani annerite di sangue e di polvere da sparo intorno alle gole, premessero i loro palmi enormi contro i petti – sfondando le casse toraciche – o baciassero con le loro larghe bocche dai denti marci, dall’alito di morte, i visetti dei bambini. È lontano il tempo in cui c’era solo un orco comune che si chiamava Sétif. Ormai ognuno porta con sé il suo orco personale, un orco tascabile che è salito con lui sulla nave e che esce di notte. Allora si levano le grida, da una tenda all’altra, poi le voci delle mamme che cantano la ninnananna, le proteste dei vicini che chiedono silenzio, i mormorii soffocati dagli strati di tela.
Gli orchi della notte sono nati dai ricordi ma si rafforzano con le paure del presente e con quelle del futuro. Quando coloro che, in mancanza di meglio, vengono chiamati harki hanno chiesto perché li parcheggiassero lí, dove fosse la Francia, il resto del paese, gli è stato risposto che era per il loro bene, che il Fln li cercava ancora e che bisognava proteggerli. Da allora, ogni notte, tremano all’idea di essere sgozzati silenziosamente, a uno a uno, per finire il lavoro. Al mattino, d’istinto, si portano una mano alla gola.
Per tenere occupati quegli uomini e quelle donne sempre piú numerosi, vengono organizzati corsi di iniziazione alla Vita della Madrepatria dove gli uomini potranno imparare ad abbreviare un messaggio se vogliono mandare un telegramma e le donne a usare una macchina per cucire o un ferro da stiro. Ai bambini invece insegnano immediatamente – come se fosse una questione di vita o di morte – le vecchie canzoni popolari. L’utilità di quei corsi, benché gli allievi non lo sospettino ancora, non sta nell’insegnamento che possono dispensare ma nella pubblicità accuratamente orchestrata intorno alla loro esistenza. Si tratta di mostrare ai francesi che i nuovi arrivati dalle usanze misteriose sono subito presi in carico, perché diventino a loro volta bravi francesi, in grado di leggere, scrivere, tenere in ordine la casa e canterellare. All’inizio, infatti, ci sono telecamere puntate sul campo. I telegiornali parlano delle vicissitudini di quelle persone arrivate lí a migliaia. I cameramen adorano i primi piani delle loro facce bizzarre: il nero dei capelli folti, il portamento, la profondità degli occhi, il gesto con cui le donne si coprono parte del viso con lo haik bianco o con i fazzoletti colorati che si sono annodate in testa, i denti distanziati dei bambini, i neonati tenuti in braccio, i corpi che fluttuano oppure si strizzano in indumenti della Croce Rossa della misura sbagliata. Il silenzio, soprattutto. Ciò che i telegiornali filmano è l’assenza di una lingua nella quale parlare. Il silenzio di coloro che attendono.
Il sito dell’Institut national de l’audiovisuel è strapieno di queste immagini, girate nel campo di Rivesaltes, in quello di Larzac, nei primi insediamenti forestali dove vengono mandati a lavorare gli harki. In uno di quei video d’archivio, ripreso nel documentario Musulmans de France, de 1904 à nos jours, si può vedere Hamid, minuscolo ma riconoscibile dalla palpebra leggermente cascante sull’occhio sinistro, che si spolmona in mezzo a una cinquantina di bambini dentro un prefabbricato:
On y danse, on y danse!
Sur le pont d’Avignon, on y danse tous en rond!
Nessun bambino sorride e raramente quella canzone è sembrata tanto sinistra.
«Cosa preferisci? – chiede un giornalista ai bambini che riesce a bloccare (alcuni non vogliono parlargli, è evidente che hanno paura di lui). – La Francia o l’Algeria?»
Quando gli rispondono «la Francia», dice: «Allora devi essere contento». E quando gli rispondono «l’Algeria» si stupisce: «Davvero? E perché?» E di fronte all’imbarazzo del bambino suggerisce:
«Perché fa piú caldo?»
Rivolge la stessa domanda agli adulti, con solo un po’ meno paternalismo. E gli adulti rispondono, con solo un po’ meno imbarazzo e paura dei bambini: «La Francia». Un uomo, con le folte sopracciglia nere aggrottate, si morde le labbra come per non gridare e risponde:
«Non l’Algeria, no. Mai piú. Bisogna dimenticare l’Algeria».
È qualcosa che gli richiede sforzi enormi. Tutta la faccia è contratta. Per dimenticare un intero paese avrebbe bisogno che gliene offrissero uno nuovo. E invece non hanno aperto loro le porte della Francia, solo le recinzioni di un campo.
«Non me l’ero immaginata cosí».
È una frase che torna spesso fra le tende ma che nessuna telecamera coglie. Gli uomini la masticano e la sputano a malincuore, le donne la sospirano fra loro. La maggior parte, anche senza aver mai messo piede fuori dal villaggio, aveva un’idea, un’immagine di che cosa fosse la Francia. E non assomigliava affatto al campo di Rivesaltes.
Dal villaggio sul crinale la Francia non era né terrificante né sconosciuta. Non era veramente l’estero e men che meno el ghorba, l’esilio. Durante gli anni del conflitto i ministri francesi avevano dichiarato uno dopo l’altro che l’Algeria era la Francia, ma per la maggior parte degli abitanti la frase funzionava in senso inverso. La Francia era l’Algeria, o perlomeno un’estensione dell’Algeria dove da un secolo emigravano gli uomini, da principio i contadini che lavoravano parecchi mesi nei campi prima di tornare al villaggio, poi gli operai delle fabbriche. Per Yema era una grande città piú lontana di Algeri, ancora piú lontana di Costantina, ma dove si incrociavano e reincrociavano gli algerini. Alí stesso ci era andato nel 1944 durante la guerra. Non aveva alcunché di impressionante. La Francia, diceva il vecchio Rafik al villaggio, è come il mercato: si resta piú tempo ma si torna con le merci.
«Non me l’ero immaginata cosí…»
Come mai niente, lí, assomiglia ai racconti che gli sono stati fatti? I vecchi hanno forse mentito?
Ogni mercoledí si svolge la strana cerimonia detta «procedura di dichiarazione ricognitiva di nazionalità». Davanti a un giudice e al suo assistente gli abitanti del campo sono invitati a rispondere a un’unica domanda:
«Vuole mantenere la nazionalità francese?»
Si è detto a quegli uomini, arruolati per amore o per forza, a volte complici senza saperlo di una guerra che non si dichiarava come tale, che erano francesi. Poi hanno perso l’Algeria. Ora gli chiedono se – magari – non vogliono rinunciare alla Francia. Loro non capiscono che cosa gli rimarrebbe. Tutti hanno bisogno di un paese.
– Vuole mantenere la nazionalità francese?
– Sí, signore, – risponde Alí.
– E lei, signora?
Il giudice...