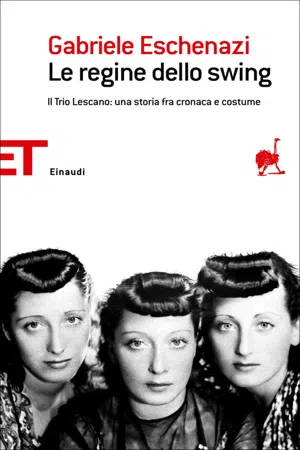![]()
Dagli altari alla polvere nell’Italia fascista e razzista
È vietato l’esercizio di qualsiasi attività nel campo dello spettacolo a italiani ed a stranieri o ad apolidi appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, nonché a società rappresentate, amministrate o dirette in tutto o in parte da persone di razza ebraica.
È l’articolo 1 di una legge emessa il 19 aprile del 1942. È il sigillo che il regime pone alla sua politica di discriminazione nei confronti degli artisti ebrei, che affonda le sue radici nelle leggi razziali del 1938 e in alcune avvisaglie degli anni precedenti. Le sorelle Lescano giungono in Italia proprio nel momento in cui la cultura e con esse la musica vedono restringersi giorno dopo giorno gli spazi di libertà pur tra molte contraddizioni. Dal 1935 il mondo musicale italiano finisce sotto il controllo del Minculpop attraverso l’Ispettorato per il teatro poi trasformato in Direzione generale dei teatri e della musica. Contemporaneamente sono istituiti il Sindacato nazionale fascista dei musicisti e la Corporazione dello spettacolo alle dipendenze del ministro delle Corporazioni. Tutta la vita musicale del Paese passa attraverso queste istituzioni: conservatori, teatri, festival, concorsi, scuole. I programmi dei corsi di studi, che riguardano la preparazione professionale dei musicisti non subiscono variazioni e inizialmente fino alle leggi razziali del 1938 anche nei teatri c’è spazio per direttori d’orchestra e musicisti stranieri di ogni estrazione: americani, sovietici, neri, ebrei. Il regime fascista trova ancora utile lasciare alle masse una valvola di sfogo. Autarchia e antisemitismo indirizzano il regime verso una crescente diffidenza nei confronti di tutto ciò che non è di pura produzione italiana. Questa politica si avverte soprattutto in radio, dove già nel 1933 vengono banditi tutti i brani di musica scritti da compositori ebrei.
Una commissione nominata dal Minculpop controlla e autorizza tutte le canzoni da trasmettere con l’obiettivo di impedire che la tradizione canora italiana sia in qualche modo contaminata da musica straniera, in particolare dal jazz. Quest’ultimo è sempre piú popolare e difficile da contrastare anche perché lo stesso regime conta nelle sue fila molti estimatori, non ultimo il figlio del Duce Romano Mussolini, che fin da bambino (nel 1937 aveva dieci anni) conosce il jazz sintonizzandosi sulle radio straniere e ascoltando 78 giri americani, di Duke Ellington in particolare, procurati via Inghilterra dalla sorella Edda. E non si trattava, almeno per lui, di una passione segreta come afferma in un’intervista a Toenke Berkelbach.
Voglio smentire la leggenda secondo la quale io ascoltavo i dischi jazz di nascosto da mio padre. Non che avesse una passione per il jazz, ma di certo non lo odiava né cercò di ostacolarne l’arrivo in Italia1.
In realtà l’atteggiamento del fascismo verso il jazz è a lungo ambivalente come spiega Gianni Borgna.
Sul piano ufficiale c’è la grottesca e comica definizione data al jazz da un giornalista, di nome forse Alberto Consiglio, che definí il jazz «afro-demo-pluto-giudo-masso-epilettoide». Era inserita in un articolo, che uscí nel 1930 sul «Popolo d’Italia», organo ufficiale del Partito nazionale fascista, e dove si diceva anche «dobbiamo farla finita con questa esterofilia. Di tutte le dabbenaggini che arrivano d’oltre oceano». Uno dei bersagli era Josephine Baker associata con disprezzo ai «negri che ballano con i gonnellini di banane». La conclusione era un invito a tornare ai mandolini e in genere alle nostre tradizioni. Poi però per contro c’era la trasmissione Eiar Jazz, che veniva messa al bando ogni qualche mese e poi riprendeva ancora le trasmissioni.
page_no="39" La svolta negativa per il jazz risale al 1938 quando a seguito degli accordi con la Germania di Hitler, Mussolini decide un progressivo allineamento ideologico dell’Italia all’Asse. L’Occidente nel suo complesso è il nemico. Sono da avversare non solo i suoi eserciti, ma tutta la sua cultura in generale, che contamina gli italiani anche attraverso la musica che entra nelle case clandestinamente attraverso le onde radio. Sulle colonne del «Popolo d’Italia» si parla di una battaglia autarchica da combattere su tutti i fronti compreso quello della musica leggera nella quale l’Italia non «aveva nulla da imparare all’estero», dovendosi anzi «gloriare del suo stesso patrimonio tradizionale». L’autarchia in questo campo come in tutti gli altri ha una giustificazione economica. C’è da dare lavoro ai musicisti locali e aiutare lo sviluppo dell’industria discografica italiana. All’autarchia è associata un’avversione per l’Occidente e naturalmente per gli ebrei. Altri articoli sul «Popolo d’Italia» del 1938 e 1939 definiscono il jazz «una delle armi giudaiche piú forti e sicure» e si loda il regime per «aver sempre combattuto affinché dalla radio fossero eliminate quelle idiozie patologiche di netta marca giudaica, che ci giungono continuamente dall’estero»2.
Si prepara il terreno per l’attacco definitivo agli ebrei italiani che giunge con le leggi razziali del 1938. In estate il Manifesto della Razza elenca i 10 principî base della nuova politica fascista antiebraica. Al nono punto si legge:
Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. (...) Gli ebrei rappresentano l’unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli italiani.
Per gli ebrei tutte le attività lavorative sono regolamentate e in qualche caso proibite come per notai e giornalisti. Gli artisti ebrei non hanno piú spazio.
Gli enti operanti nel teatro, nella musica, nel cinema, nella radio, ecc., afferenti direttamente o indirettamente allo Stato, licenziarono subito tutti i dipendenti stabili (dai dirigenti agli operai) ebrei ed annullarono tutti i contratti temporanei ad artisti ebrei»3.
Le imprese private temporaneamente escluse dall’applicazione di questa norma, vi rientrano con un’apposita estensione nel giugno del 1940. La discriminazione riguarda progressivamente tutte le opere di autori ebrei, che vengono bandite dall’intero settore dello spettacolo nel giugno del 1940.
I provvedimenti persecutori interessano 51 000 persone, l’uno per mille della popolazione italiana del tempo. Ancora piú grave è la situazione degli ebrei stranieri. Un decreto del 7 settembre 1938 vieta agli ebrei stranieri di trasferirsi in Italia mentre chi è già presente sul territorio italiano in data posteriore al 1° gennaio 1919 deve lasciare il Paese entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto. In un anno, dei circa 10 000 ebrei stranieri presenti in Italia, 6400 sono costretti a emigrare. Non è il caso del Trio Lescano, che riesce a rimanere in Italia e proseguire il momento d’oro della propria carriera musicale.
L’articolo 2 del decreto sugli ebrei stranieri del 7 settembre 1938 stabilisce che «è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica». Questo articolo sembrerebbe escludere in un primo momento che gli stranieri figli di matrimoni misti possano essere considerati ebrei, ma poi le leggi razziali del 17 novembre 1938 stabiliscono che «è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera». La norma, però, rileva qualche mese dopo la Demorazza (Direzione generale per la demografia e per la razza del ministero dell’Interno), è in contrasto col Codice Civile, che prevede che lo stato, la capacità giuridica delle persone e i rapporti di famiglia degli stranieri siano regolati dalle leggi del Paese, al quale essi appartengono. Mussolini è quindi costretto a una marcia indietro e il 23 giugno del 1939 stabilisce che il figlio di matrimonio misto tra due stranieri può essere, in determinati casi, classificato di «razza ariana»4.
Sandra, Giuditta e Caterina, straniere, figlie di madre ebrea e padre cattolico beneficiano di questa porta lasciata socchiusa dal regime agli ebrei stranieri. Il loro caso viene esaminato da una Commissione speciale incaricata di dirimere casi controversi di cittadinanza. In una seduta dell’11 ottobre 1939 questa commissione si esprime in favore della «non appartenenza alla razza ebraica» delle tre Lescano5. A questa decisione giunge dopo aver esaminato: un’attestazione del ministro d’Ungheria a Roma, che le definiva non appartenenti alla razza ebraica in base alla legge razziale ungherese, l’albero genealogico paterno e un certificato che indicava nell’8 maggio 1916 il battesimo di Sandra, nel 19 settembre 1913 quello di Giuditta e nel 10 marzo 1920 quello di Caterina. Tutti i battesimi erano avvenuti molto prima della proclamazione delle leggi razziali del 1938 e sono quindi considerati validi. In piú Sandra, Giuditta e Caterina, dice la commissione, «sono nate da genitori entrambi stranieri di cui uno solo appartenente alla razza ebraica».
Della richiesta di «appartenenza alla razza ariana» c’è traccia anche in un documento riservato del 14 ottobre 1939, indirizzato al ministero degli Interni e firmato dal Prefetto di Torino, probabilmente senza sapere della decisione della Commissione in favore delle Lescano. Nel testo si legge:
Le sorelle Leschan, suddite ungheresi, hanno dichiarato di aver prodotto a codesto ministero per il tramite della loro legazione a Roma documentata istanza tendente a ottenere il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana. Poiché le Leschan avrebbero dovuto abbandonare il Regno essendo scaduta la proroga loro concessa prego far conoscere se in pendenza della suddetta istanza possano o meno continuare a risiedere in Italia6.
Il regime accoglie le loro richieste con un Decreto del ministro per l’Interno datato 15 novembre 1939 che le dichiara «non appartenenti alla razza ebraica». Traccia dello status che viene loro attribuito si trova anche in un documento dell’anagrafe del comune di Torino, dove risultano inserite nella categoria «misti non ebrei».
Si tratta di uno status che risparmia alle tre sorelle ogni persecuzione, ma lascia loro l’etichetta di osservate speciali. I compresi in quella categoria, infatti, finiscono sotto il costante controllo della Demorazza che compie verifiche sui loro comportamenti in rapporto all’ebraismo. I «misti non ebrei» come le Lescano, per il regime, sono dunque degli ibridi e non degli «ariani puri». Su di loro il rischio deportazione continuerà a incombere.
Della stessa benevolenza fascista verso i «misti» non si giova la madre Eva, «ebrea pura», che rimane pericolosamente ostaggio dello status di ebrea straniera tanto che il 26 dicembre 1939 viene iscritta a Torino nel registro generale dei reati per violazione dell’art. 19 della legge razziale, che imponeva a tutti gli ebrei di autodenunciarsi come tali pena fino a un mese di arresto e 3000 lire di multa. Alla denuncia non risulta sia seguito alcun provvedimento restrittivo, ma si tratta di un campanello di allarme per le tre ragazze olandesi impegnate a ottenere un prolungamento del permesso di soggiorno per mamma Eva.
Il 9 gennaio 1940 la Prefettura di Torino scrive al ministero dell’Interno:
Per debito di ufficio trasmetto istanza prodotta dalle sorelle Leschan con la quale invocano una proroga per l’ulteriore soggiorno nel Regno a favore della loro madre. La De Leeuwe di religione israelita risiede nel Regno dal 1935 serbando regolare condotta morale e politica. I motivi addotti nelle istanze dalle figlie rispondono a verità7.
Essere al vertice del successo e anche per questo essere apprezzate dal principe Umberto e dai gerarchi del regime non basta a ottenere corsie preferenziali per smarcare tutta la famiglia da un’identità messa all’indice dal fascismo. Intanto al Trio le difficoltà arrivano non solo dalla propria origine, ma paradossalmente anche dalla propria musica, o meglio dalle parole delle canzoni. Nel 1939 Maramao perché sei morto, una canzone che eseguono con Maria Jottini e firmata da Mario Panzeri e Mario Consiglio viene sospettata di essere antiregime. L’accusa è quella di deridere Costanzo Ciano, presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e padre di Galeazzo Ciano, genero di Mussolini. Si tratta in realtà di un equivoco generato a Livorno da alcuni studenti, che sistemano di nascosto un cartello con le prime parole del ritornello della canzone vicino alla base di un monumento progettato per rendere onore alla memoria di Ciano padre. «Maramao perché sei morto, pane e vin non ti mancava, l’insalata era nell’orto...» dice la canzone riferendosi alla scomparsa di un gatto, ma questa evidenza non è sufficiente per dissipare i timori del governo fascista sempre pronto a vedere fantasmi da tutte le parti. L’autore Mario Panzeri viene convocato dal capo della censura, Salvatore Criscuolo, per dare spiegazioni. Dimostra di aver composto la canzone prima della morte di Ciano e il caso viene archiviato tanto piú che si tratta della ripresa di una storiella tramandata da secoli in Lazio e Abruzzo. In piú si aggiunge il fatto che anche Galeazzo Ciano non è insensibile al fascino delle cantanti e non insiste sull’accusa.
In questa fase le sorelle olandesi non subiscono direttamente alcuna conseguenza, ma è il segnale che anche loro devono essere attente a cosa cantano. Le cosiddette «canzoni della fronda» danno fastidio al regime. Lo aveva dimostrato già nel 1936 quando se l’era presa con Gorni Kramer e la sua Crapa Pelada. Troppo evidente sembrava l’allusione alla «testa pelata» del Duce perché la canzone, per di piú molto jazzistica, passasse inosservata. In piú la descrizione di tortelli e frittate da spartire sembrava un’allusione alla spartizione dei territori coloniali da parte delle potenze europee, non gradita a Mussolini. Kramer paga con l’esclusione dalla radio mentre la canzone finisce in una lista nera, insieme al brano di Fedora Mingarelli Un’ora sola ti vorrei, che nella prima strofa proseguiva con «per dirti quello che non sai», una frase sconveniente se pronunciata per strada sotto un ritratto del Duce. Incredibile la censura che colpisce nel 1939 Tiempe belle, una canzone del 1916, che parla di «tempi belli» intesi come i tempi dell’amore e interpretata invece come una scomoda allusione all’epoca prefascista. Per non sbagliare il regime promulga il 18 marzo 1939 una legge che stabilisce che tutti i testi originali da incidere su disco debbano essere preventivamente approvati dai prefetti incaricati di trasmettere al Minculpop l’elenco delle canzoni approvate. Cadono sotto la mannaia della censura nel 1940: Signora illusione per le parole; Illusione dolce chimera sei tu riferibile ai proclami di vittoria del regime; Silenzioso per Abbassa la tua radio per favore intesa come un invito ad ascoltare Radio Londra. Nel 1942 tocca a Il tamburo della Banda d’Affori di Panzeri (ancora lui!) che sembra alludere alla camera dei fasci composta da 550 membri come i 550 pifferi segnalati nella canzone. Del Trio Lescano al regime non piace nel 1940 Pippo non lo sa peraltro composta dai recidivi Panzeri e Kramer e cantata con Silvana Fioresi. Questa volta il problema è essenzialmente l’identità di questo Pippo che «quando passa ride tutta la città». La censura identifica Pippo con Achille Starace, capo di stato maggiore della milizia, che spesso sfila mostrando con orgoglio la sua divisa nera. La radiodiffusione della canzone viene proibita. Il mistero su Pippo rimane tale fino a quando nel 1962 Gorni Kramer dà una sua spiegazione ripresa nel sito Galleria della Canzone:
Era il 1939, ero a Viareggio, dove mi esibivo al Kursaal. Ma capivo di non ingranare. I giovani v...