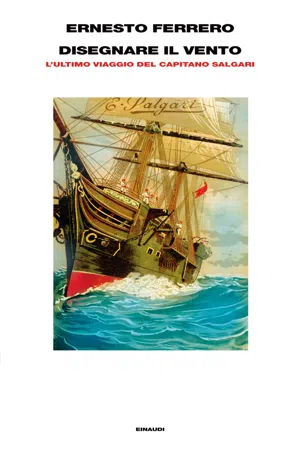![]()
Dai quaderni di Angiolina
30 aprile 1911
Sono arrivata presto in corso Casale, volevo cercare di rimetterlo a lavorare, ma era appena uscito. Una vicina mi ha detto che l’aveva visto prendere la tramvia verso il centro. Era già importante che non fosse andato verso il fiume. Non potevo aspettare un’altra tramvia, mi sono messa a correre lungo il corso Casale. Ho pensato che in città non doveva essere andato, con la città aveva chiuso, non voleva piú sapere di niente. Doveva essere andato verso la collina.
Ho cominciato a salire piú in fretta che potevo su da via del Lauro, cercando di respirare lungo. Per fortuna avevo voti buoni anche in ginnastica.
Cercavo di mettermi nella testa di un abitudinario come lui. Le stesse passeggiate, le stesse gite negli stessi posti. L’anno prima Aida aveva insistito che andassi a fare merenda con loro, i ragazzi volevano giocare con me perché il capitano non aveva piú voglia di passeggiate e di mascherate. Mi avrebbero fatto vedere un posto dove ci sono le tigri e i leopardi. Era autunno, raccoglievano foglie gialle e rosse, facevano a gara a chi trovava la foglia piú bella. Romero voleva andare per castagne, quando ne raccoglieva abbastanza le vendeva al signor Demo per i suoi dolci. Parlavano del bosco Rey come fosse il Borneo, era il loro preferito. Avevo dovuto rinunciare per chiudere una contabilità che era rimasta arretrata, ma Nadir mi aveva fatto giurare che alla prima occasione ci saremmo tornati. Secondo lui non c’erano solo tigri in quel bosco, c’erano anche i bhajusa, i formidabili bisonti indiani.
page_no="178"
Alla prima occasione.
Sentivo il sangue che pulsava con violenza alle vene del collo, me le sono toccate, erano gonfie come un torrente di primavera, mi sentivo il veterinario di me stessa. Sono riuscita ad arrivare in cima prima di quanto pensassi. Fortuna che le gemme degli alberi sono appena sbocciate, tante piccole virgole di un verde tenero, umido. Il bosco è ancora nudo, solo qualche primula per terra, dei crochi bianchi e viola pallido, era stato il capitano ad attirare la mia attenzione su di essi durante una passeggiata spiegando come si riproducono.
C’era un gran silenzio, il solo rumore lo facevano i miei scarponcini franando nel terriccio umido e smosso. Cercavo degli avvallamenti, dei luoghi dove ci si può nascondere. Ho corso su e giú dieci minuti come un bracco. Ci fosse stato ancora Niombo lo avrebbe trovato subito.
Finalmente l’ho visto. Prima ancora di vedere lui ho visto il lucore iridescente delle viscere che erano uscite dalla sacca intestinale. È facile adesso scrivere sacca intestinale, le nozioni che impariamo a scuola sono delle astrazioni, degli eufemismi. Nella furia di colpirsi il piú in fretta possibile, s’era svestito a metà. Aveva tolto la giacca, e deposto bene in ordine per terra canna e cappello, ma non aveva nemmeno scostato la camicia di flanella, sotto cui occhieggiava una pelle di cera, vizza, malata.
Deve aver capito che aprendosi soltanto il ventre sarebbe andata per le lunghe. Si era praticato lo sventramento come un gesto simbolico, il richiamo a un codice d’onore. Chissà quante schede aveva sul Giappone e i samurai.
«Ogni cosa al suo posto». Allora si dev’essere avventato al collo con il rasoio che teneva nella destra, ben stretto nelle grosse dita. Il rasoio aveva un manico d’avorio, identico a quello di mio padre.
Da lí il sangue stava ancora uscendo a fiotti, a grosse polle. I tagli erano profondi. Il cuore pompava bene. Il mese scorso ho parlato con un amico studente di medicina, gli ho chiesto quanto tempo ci vuole per svuotare un uomo del suo sangue. Tre minuti, ha detto. E per andare fuori conoscenza? Anche meno.
Mi sono inginocchiata vicino a lui, non sapevo da che parte cominciare. Ha socchiuso gli occhi già velati – una fessura –, mi ha visto, ha dato come un gorgoglío di tosse, mi è sembrato dicesse: aiutami. E poi ancora: finiscimi.
Io non sapevo né come aiutarlo né come finirlo. Allora lui ha preso il rasoio e me l’ha spinto in mano, poi tremando ha preso la mia mano e se l’è calcata di nuovo sul collo, di qui e di là.
Ho allentato istintivamente la stretta. Il rasoio è caduto, lui ha fatto per riprenderlo ma si è abbandonato senza piú forze.
Gli ho preso la testa e me la sono stretta al petto, la grossa testa rotonda, bianca e grigia. Ho pensato al rumore che fanno i salvadanai quando i bambini li scuotono per capire quante monete ci sono dentro. Io invece gliela tenevo ben ferma come per evitare che scappassero le centinaia e migliaia di personaggi e animali e piante che ci stavano dentro, che lo abbandonassero anche loro.
Sentivo che si stava rilasciando, gli ho dato un piccolo bacio sulla fronte sudata. Gli ho sussurrato: sssssssst, come si fa con i bambini per farli addormentare. Presto il sangue ha smesso di uscire.
Non so quanto tempo l’ho tenuto cosí. Avrei voluto essere su una barca, al largo, affidarlo al mare, come in quella pagina bellissima de Il Corsaro Nero. Il bosco s’era riempito di trilli e cinguettii, prima non li avevo sentiti, ero assordata dal battito del sangue alle mie orecchie, mi dava spavento come se fosse il sangue di lui a rombarmi dentro. Adesso era come si fossero svuotate anche le mie vene.
L’ho adagiato sul muschio, piano, piú dolcemente che potevo. Era pesante, come fosse pieno di pietre; o forse mi sentivo stremata io. Sembrava che riposasse dopo il picnic, su un fianco, mentre i bambini sono a giocare nel bosco. Gli ho chiuso gli occhi e gli ho dato un altro piccolo bacio sulla tempia.
Avevo la camicia tutta macchiata. In un ruscello lí vicino mi sono lavata le mani e ho ripreso lo scialle con cui ero salita, lo avevo appeso a un ramo. Mi avrebbe protetto per il tempo necessario.
In casa non c’era nessuno. Ho messo tutto in un mastello d’acqua, lavato e risciacquato tre volte. L’acqua era sempre rosa.
Poi sono andata da mio padre in fabbrica. Come mi sono fermata sull’uscio del suo ufficio sono svenuta. Di quel giorno non ricordo altro.
Il 29 la città si è messa in festa per l’apertura dell’Esposizione Universale, figurarsi se poteva aver testa per il capitano. I sovrani sono arrivati a Porta Nuova, c’era Giolitti, mezzo esercito e la cavalleria e popolo festante.
Il funerale del capitano è stato il giorno prima, a spese del Comune. Autorità non ne sono venute. Un suicidio pochi giorni prima di un evento cosí è una di quelle cose imbarazzanti che non si devono fare. Un giornale ha avuto il coraggio di scrivere che il defunto aveva «un aspetto caratteristico da cinese, faceva vita ritirata, ma disordinata e spendereccia».
Nella cassa di legno chiaro il viso era disteso, come l’avevo lasciato. La redingote era abbottonata alta, non si vedeva niente; sul petto, la croce di cavaliere. I ragazzi hanno deposto dei fiori gialli che avevano raccolto nei campi, i primi a fiorire, ancora esili. Il cortile e l’androne erano pieni di studenti, anche del Politecnico, con i suoi libri sotto il braccio. Si stringevano tra loro, smarriti, come fossero parenti; qualcuno piangeva.
Al momento di chiudere la cassa Fathima ha avuto un attacco della sua tosse ed è svenuta di nuovo.
I giornali hanno pubblicato le «lettere alle morose». Ha fatto impressione quella indirizzata agli editori in cui si diceva che si erano arricchiti sulla sua pelle mantenendo lui e la sua famiglia in una continua semi-miseria e anche piú. Chiedeva soltanto che per compenso dei guadagni che lui aveva dato loro pensassero ai suoi funerali. Li salutava spezzando la penna.
Hanno pubblicato anche la lettera ai direttori dei quotidiani torinesi, credo che abbia preso l’idea da Franzoj, che tanto ammirava. «Vinto dai dispiaceri d’ogni sorta, ridotto alla miseria malgrado l’enorme mole di lavoro, con la moglie pazza all’ospedale, alla quale non posso pagare la pensione, mi sopprimo». Pregava i signori direttori di aprire una sottoscrizione per togliere dalla miseria i quattro figli e passare una pensione a sua moglie finché rimarrà in ospedale. Ringraziava sentitamente e si firmava «il devotissimo cav. Emilio Salgari».
La pubblica sottoscrizione ha fruttato 42 000 lire. Hanno contribuito tra gli altri il signor Puccini, la poetessa Guglielminetti e il Re, che ha versato mille lire: grosso modo, il guadagno di mezzo romanzo.
Gli editori hanno dichiarato di sentirsi offesi, ma le loro brave offerte le hanno fatte anche loro. Non si sono sforzati troppo: Donath ha dato 200 lire, Bemporad 500, ed è finita lí.
A me è dispiaciuto che nell’ultima lettera avesse rinunciato ai gradi di capitano che aveva guadagnato sul campo.
Tra le tredici lettere ce n’era anche una per me.
page_no="182"
![]()
22 aprile 1911
Cara Superina,
in questi mesi e anni ti ho sentita sulle mie tracce come la piú astuta delle guerriere pellerossa, come la pugnace Minnehaha. Non hai lasciato alcunché di intentato. Non avevi torti da vendicare, volevi soltanto salvarmi: non dai Thugs o dai rapaci coloni bianchi, ma da me stesso. Questa è una di quelle tali imprese che a nessun essere umano è dato di portare a compimento.
C’è qualcuno – non so chi sia, non ho mai avuto confidenza con le sfere superne – che scrive la nostra storia, e nessuno può cambiarla. Io non avevo niente da insegnarti, perché l’intelligenza e la sensibilità non si insegnano e non si trasmettono, meno che mai a chi già le possiede. Esse stanno annidate in te come un bambino nel grembo materno. A te toccherà portarle alla luce, farle diventare qualcosa che possa aiutare i tuoi simili, cosí come i tuoi gesti affettuosi hanno confortato me.
Ti sono grato dal profondo del cuore di avere diviso con me un ultimo tratto di mare. Ho scoperto in te le qualità del buon marinaio che io non sono stato. Ti prego di porgere il mio ricordo anche al tuo gentile signor padre e di dirgli ancora il mio apprezzamento per i suoi eccellenti prodotti.
Non dimenticare troppo presto il tuo sventurato amico.
Rispettosamente ti abbraccia per sempre il tuo devotissimo
cap. Emilio Salgari
page_no="183"
![]()
Nota.
Un tragico destino ha continuato ad accanirsi sulla famiglia Salgari anche dopo la morte di Emilio. Ida Peruzzi è rimasta in manicomio fino alla sua morte, avvenuta nel giugno 1922 per un cancro all’utero, probabilmente diagnosticato troppo tardi. Fathima non è scampata alla tubercolosi che già le aveva fatto abbandonare le ambizioni musicali: la rubrica dello stato civile de «La Stampa» annota il suo decesso alla data del 15 luglio 1914, qualificandola come «cucitrice». Una breve nota di cronaca ricorda il triste destino della «bimba di Salgari», deceduta in sanatorio, e ricorda che il giornale aveva aperto una sottoscrizione per gli orfani.
Altri due figli di Salgari seguono il padre nel suicidio. Nel 1932 Romero, dopo aver tentato di uccidere la moglie, il figlio Mimmo e il cognato, si toglie la vita (già nel 1922 aveva tentato il suicidio ingerendo una pastiglia di permanganato di potassio). Omar, l’ultimogenito (il piú attivo dei figli nella «fabbrica dei falsi» che usciranno con regolarità fino al secondo dopoguerra), si lancia da un balcone a Torino. Intanto nel 1936 Nadir era rimasto vittima di un incidente motociclistico.
Questo «romanzo con personaggi veri» mescola, come d’uso, persone, fatti, situazioni, documenti autentici e altri d’invenzione, che tuttavia si sforzano di riuscire verosimili e concorrere a quella ricerca di una verità umana e poetica in cui dovrebbe consistere il lavoro letterario.
Molti sono i libri, i saggi, gli studi, le ricerche che ho utilizzato, e ai quali dichiaro qui i miei debiti di gratitudine. Due, anzitutto, sono le biografie disponibili: quella pionieristica di Roberto Antonetto e Giovanni Arpino, Vita, tempeste e sciagure di Salgari, il padre degli eroi, uscita da Rizzoli nel 1982, quando l’astro salgariano si stava offuscando, e ora ripresa da Viglongo, benemerito editore salgariano per eccellenza; e quella di Silvino Gonzato, Emilio Salgari. Demoni, amori, tragedie di un «capitano» che navigò solo con la fantasia (Neri Pozza, 1995), ricca di una documentazione inedita. Eccellente è anche il profilo critico di Bruno Traversetti, Introduzione a Salgari (Laterza, 1989). Articolato tematicamente è il saggio di Ann Lawson Lucas, La ricerca dell’ignoto. I romanzi d’avventura di Emilio Salgari (Olschki, 2000). Un inquadramento generale è offerto da Giuseppe Zaccaria in Il romanzo d’appendice (Paravia, 1977).
A sdoganare Salgari, reo di «scrivere male» e di scaldare la testa dei ragazzi, in una collana di letture per la scuola media aveva provveduto Daniele Ponchiroli sin dal 1971 con Avventure di prateria, di giungla e di mare (Einaudi). Il ricordo delle letture giovanili ha dettato pagine acutamente empatiche a Pietro Citati (Il profumo del nagatampo, ora in Il Male assoluto, Mondadori, 2000; Salgari scrittore maledetto, in «la Repubblica», 2 agosto 2000) e a Claudio Magris (Salgari o il piccolo grande stile, in Itaca e oltre, Garzanti, 1982). Sugli illustratori salgariani si veda il saggio di Antonio Faeti, Guardare le figure (Einaudi, 1972). La collaborazione con il pittore Alberto Della Valle è documentata da Paola Paollottino in L’occhio della tigre (Sellerio, 1994).
Negli ultimi trent’anni Salgari ha goduto di una serie di ricerche e approfondimenti condotti con amorevole dedizione, che hanno trovato il loro piú appassionato protagonista nel veneziano Giuseppe Turcato, il cui ingente Fondo è conservato presso la Biblioteca Civica di Verona. Il lavoro di Turcato ha trovato dei validi continuatori, tra gli altri, in Felice Pozzo, Vittorio Sarti e Claudio Gallo, che ha raccolto in A Tripoli! le note di politica estera del Salgari giornalista sotto lo pseudonimo di «Ammiragliador» (Perosini, 1994), e in Viva Salgari! le memorie e testimonianze già raccolte da Turcato (Aliberti, 2005). Vittorio Sarti ha offerto una Nuova bibliografia salgariana (Pignatone, 1994).
Tra le raccolte di saggi da segnalare Gian Paolo Marchi (La spada e il sambuco, Grafiche Fiorini, 2000) e Felice Pozzo (Emilio Salgari e dintorni, Liguori, 2000). In A pranzo con Salgari (Perosini, 2000) Elsa Müller ha ricostruito le pratiche alimentari degli eroi salgariani. Approfondimenti e notizie utili sono reperibili anche nel catalogo della mostra I pirati in biblioteca. Fonti salgariane, a cura di S. Gonzato e P. Azzolini (Verona, 1991), e nei saggi raccolti nei Quaderni salgariani n. 1 pubblicati da Viglongo nel 1998.
Rilevanti anche i contributi ospitati nei vari volumi che raccolgono gli atti di convegni: Scrivere l’avventura: Emilio Salgari (Assessorato per la Cultura di Torino, 1980), «Io sono la tigre», a cura di S. Gonzato (Banca Popolare di Verona, 1991), La valle della luna. Avventura, esotismo, orientalismo nell’opera di Emilio Salgari, a cura di E. Beseghi (La Nuova Italia, 1992), Il caso Salgari, a cura di F. Pozzo (CUEN, 1997), L’ombra lunga dei paletuvieri (Tipografia Mriotti, 1998), I miei volumi corrono trionfanti, sulla fortuna di Salgari all’estero (Palazzo Barolo di Torino, 2003; Edizioni dell’Orso, 2005), Emilio Salgari tra sport e avventura, a cura di C. Cappelletti (Viglongo 2010). In occasione di quel convegno (2006) l’Università di Verona ripubblicava il volumetto biografico di Berto Bertú, Salgàri, apparso nel 1928 per le Edizioni Augustea, che intendevano attribuire al fascismo matrici risorgimentali e patriottiche. Infine, il convegno internazionale di Liegi ha indagato la produzione degli ultimi anni: Un po’ prima della fine. Ultimi romanzi di Salgari tra novità e ripetizione (1908-1915), a cura di L. Curreri e F. Foni (Luca Sossella editore, 2009).
Tra le numerosissime edizioni salgariane mette conto di ricordare almeno quella curata e annotata negli anni Settanta da Mario Spagnol per Mondadori, con la collaborazione di Giuseppe Turcato. Una ventina di romanzi sono stati raccolti tematicamente: il Primo e Secondo ciclo della Jungla, Il ciclo dei corsari, Il ciclo del Far-West, i Romanzi d’Africa e i Romanzi di guerriglia. Spagnol ha tracciato una prima rassegna delle fonti salgariane in Filologie salgariane (in AA.VV., L’isola non trovata. Il libro d’avventure nel grande e piccolo Ottocento, Emme Edizioni, 1982).
Tra i saggi introduttivi a singole opere, da segnare quelli di Emanuele Trevi a Il Corsaro Nero (Einaudi, 2000), di Michele Mari a Romanzi di giungla e di mare (Einaudi, 2001) e di Sergio Campailla a Tutte le avventure di Sandokan (Newton Compton, 2010).
page_no="187"