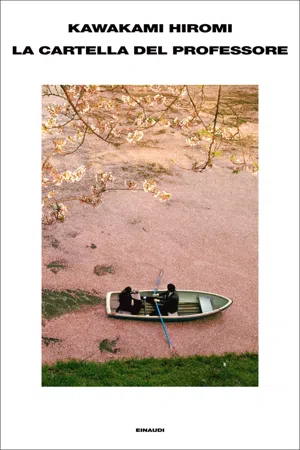![]()
Sull’isola (II)
– Guardi, il polpo viene a galla! – mi fa il professore indicandolo. Io annuisco.
Credo che questo piatto si possa chiamare una zuppa di polpo. Lo si taglia a fettine sottilissime che si buttano nell’acqua bollente della marmitta, e appena vengono a galla le si prende in fretta con le bacchette. Le si mangia dopo averle bagnate nell’aceto, cosí che il sapore dolce del polpo, fondendosi nella bocca con l’agro dell’aceto, crea una mescolanza davvero insolita.
– Quando la immerge nell’acqua calda, la carne del polpo tagliata fine diventa bianca, vede? – mi dice il professore, nello stesso tono che ha quando beviamo fianco a fianco da Satoru.
– Sí, è vero! È bianca –. Da parte mia invece non mi sento affatto a mio agio. Dovrei ridere? Tacere? Non so nemmeno io come comportarmi.
– Prima, proprio un attimo prima, non le sembra che diventi rosa?
– Sí, – rispondo a bassa voce. Il professore mi guarda con un’espressione divertita, poi pesca nella marmitta tre fettine in una volta.
– È stranamente docile stasera, Tsukiko.
Dopo un’infinità di tempo, finalmente è tornato giú dalla collina. Quando i gabbiani ormai tacevano ed era calato il buio. A me sono sembrate ore, ma forse erano trascorsi solo cinque minuti. Sono rimasta ad attenderlo davanti all’ingresso del ryōkan. Poi ho sentito il rumore leggero delle sue scarpe mentre arrivava con passo sicuro nell’oscurità.
– Prof! – l’ho chiamato.
– Ah, Tsukiko, – ha risposto lui. – Eccomi qui.
– Bentornato.
Siamo entrati insieme nella locanda.
– Che magnifici abaloni! – dice ora abbassando il fuoco sotto la zuppa di polpo. Su un piatto medio sono posate quattro conchiglie, piene di sashimi di abalone.
– Forza, Tsukiko, non faccia complimenti.
Mette un po’ di wasabi su una fetta di abalone, poi la bagna nella salsa di soia. Mastica lentamente. Mentre mastica, ai lati della bocca gli si formano le pieghe tipiche degli anziani. Addento anch’io un abalone. Probabilmente la mia bocca è ancora quella di una donna giovane. Mi piacerebbe che diventasse come quella di una vecchia, penso con forza.
Zuppa di polpo. Abalone. Mirugai. Kochi. Scampi bolliti. Gamberoni fritti. I piatti vengono serviti uno dopo l’altro. Dopo il kochi, le bacchette del professore cominciano a rallentare. Beve a piccoli sorsi tenendo la tazzina appena inclinata. Io invece divoro senza fermarmi tutto quello che arriva, vuotando tazzina su tazzina.
– Le piace, Tsukiko? – mi chiede col tono del nonno compiaciuto di veder mangiare di buon appetito la nipotina.
– È ottimo, – rispondo bruscamente. Poi, mettendoci un po’ piú di calore, ripeto: – Sí, è ottimo.
Quando è arrivata la verdura bollita e quella sott’aceto, eravamo entrambi al limite delle nostre capacità. Abbiamo rifiutato il riso e preso soltanto la minestra di miso. Sorseggiando lentamente il brodo, che aveva un forte gusto di pesce, abbiamo finito il sake che restava.
– Be’, credo sia ora di ritirarsi, – ha detto il professore pigliando la chiave della sua stanza e alzandosi. Mi sono alzata anch’io, ma dovevo essere piú sbronza di quanto pensassi, perché vacillavo un po’. Appena ho cercato di fare un passo ho inciampato e sono finita con le mani sul tatami.
– Ehi! – ha esclamato il professore guardandomi dall’alto.
– Perché non mi aiuta, prof, invece di dire «ehi!», – gli ho risposto alzando un po’ la voce, al che lui ha riso.
– Finalmente è tornata a essere la solita Tsukiko, – ha detto, e mi ha teso la mano.
Mi ha praticamente tirato su per le scale. Quando siamo arrivati davanti alla sua stanza, a metà corridoio, ci siamo fermati. Il professore ha infilato la chiave nella serratura. L’ha girata con uno scatto. Io mi tenevo dietro di lui, malferma sulle gambe.
– Le terme di questo ryōkan pare che siano speciali, – ha detto voltandosi.
– Ah, – ho risposto col tono di chi ha la testa nelle nuvole, continuando a barcollare nel corridoio.
– Ora si riprenda un poco, poi vada a fare un bagno.
– Ah.
– E cerchi di farsi passare la sbornia.
– Ah.
– E, quando esce dal bagno, se trova che la serata è ancora lunga, venga pure nella mia stanza.
Volevo rispondere con il solito «ah», invece mi è uscito un «eh?», mentre sgranavo gli occhi.
– Eh? Co-come ha detto? Cosa significa?
– Non significa niente in particolare, – ha risposto il professore voltandomi le spalle e sparendo al di là della porta, che si è chiusa davanti alla mia faccia.
Sono rimasta nel corridoio, sempre barcollando leggermente. Nella mia mente offuscata dall’alcol, mi sono ripetuta le parole «venga pure nella mia stanza». Aveva proprio detto cosí. Sí, potevo andare nella sua stanza, ma per fare cosa? Una partita a carte o qualche gioco di società? Continuare a bere? Conoscendolo, non mi sarei stupita se di punto in bianco mi avesse proposto di leggere dei canti nō o roba del genere.
«Non aspettarti nulla, Tsukiko», ho mormorato fra me avviandomi verso la mia camera. Ho aperto la porta, acceso la luce, e in mezzo alla stanza ho visto un futon già steso. La mia sacca era stata spostata davanti al tokonoma.
Mentre indossavo lo yukata e mi preparavo ad andare al bagno termale, ho continuato a ripetermi «non ti aspettare nulla, non ti aspettare nulla».
L’acqua termale era dolce sulla pelle. Mi sono lavata la testa, sono entrata e uscita dalla vasca diverse volte, poi nello spogliatoio mi sono asciugata bene i capelli col fon, cosí senza che me ne accorgessi è passata piú di un’ora.
Tornata nella mia stanza, ho aperto la finestra lasciando entrare l’aria della notte. E il rumore delle onde, che si sentiva piú forte. Sono rimasta a lungo appoggiata al davanzale.
Da quando il professore e io eravamo diventati cosí intimi? I primi tempi lo sentivo molto distante. Era un personaggio che apparteneva al lontano passato, ai tempi del liceo, un uomo anziano che non conoscevo. Anche dopo aver preso l’abitudine di scambiare con lui qualche parola, non sapevo quasi che faccia avesse. Era un essere vago che stava tranquillamente seduto al bancone, sullo sgabello accanto al mio.
Soltanto la sua voce mi era rimasta nelle orecchie fin dall’inizio. Una voce che aveva una bella inflessione, un po’ alta ma non priva di toni gravi. Fluiva giungendo fino a me da quell’essere indefinito che mi sedeva accanto.
A partire da quando, avvicinandomi a lui, ho cominciato a sentire il calore che emanava dal suo corpo? Attraverso la sua camicia inamidata, percepivo la sua presenza. Una presenza che mi affascinava. Che aveva la sua stessa forma. La forma del prof. Distaccata, eppure calorosa. Una presenza che non sono mai riuscita ad afferrare saldamente. Quando sto per prenderla, mi sfugge. Quando la sento lontana, di nuovo si avvicina.
Ma anche supponendo che fossi stata con lui pelle contro pelle, avrei per questo una piú salda percezione della sua presenza? Tanto per cominciare la presenza è qualcosa di vago, di ambiguo, sfugge comunque, in qualunque caso.
Una grossa falena è entrata, attirata dalla lampada accesa. È svolazzata qua e là per tutta la stanza lasciando cadere polvere dalle ali. Ho tirato il cordoncino della lampada smorzando la luce, che da un cerchio bianco e splendente è diventata un lumicino arancione. La falena si è attardata ancora un poco, poi è volata via, all’esterno.
Ho atteso un momento, ma non è tornata.
Dopo aver chiuso la finestra, mi sono sistemata bene lo yukata, ho messo un velo di rossetto e preso un fazzoletto. Ho chiuso a chiave la porta della stanza cercando di fare il meno rumore possibile e sono avanzata nel corridoio. Sulla lampada del corridoio erano posate diverse piccole falene. Prima di bussare alla porta del professore, ho fatto un profondo respiro.
– Prof? – ho detto.
– È aperto, – mi ha risposto lui dall’interno. Allora ho girato con precauzione la manopola.
Seduto sul tatami, teneva i gomiti appoggiati al basso tavolo. Dava le spalle al futon steso di lato e stava bevendo della birra.
– Sake non ce n’è? – ho chiesto.
– Sí che ce n’è, nel frigo, ma io per stasera col sake ho chiuso, – ha risposto versandosi altra birra dalla bottiglia di media grandezza. Nel bicchiere si è formata una bella schiuma. Sono andata a prendere un bicchiere dal vassoio posato sul frigo.
page_no="128" – Ecco, – ho detto mettendoglielo sotto il naso. Lui ha sorriso e anche per me ha fatto schiumare la birra.
Sul tavolo erano posati dei formaggini triangolari avvolti in carta argentata.
– Li ha portati lei? – ho chiesto, al che lui ha fatto cenno di sí.
– Quanti preparativi!
– Li avevo nella cartella, me ne sono ricordato al momento di uscire.
È una notte tranquilla. Ci arriva soltanto, attutito dai vetri, lo scroscio delle onde. Il professore apre la seconda bottiglia. Quando toglie la capsula, il rumore risuona per tutta la stanza.
Una volta vuotata anche la seconda bottiglia, sia lui sia io non parliamo piú. Ogni tanto si sente infrangersi un’onda piú forte.
– Che pace, – finisco col dire. Il professore fa un cenno d’assenso.
– Sí, che pace, – osserva anche lui dopo un po’, e questa volta sono io ad annuire.
La carta argentata che avvolgeva i formaggini ora è stropicciata e appallottolata. Raccolgo tutti i pezzetti formando una palla piú grossa. Mi torna in mente che da piccola avevo fatto una palla grossissima con l’involucro dei bastoncini di cioccolato. Avevo stirato con molta cura i pezzi di carta e li avevo incollati. E quando trovavo della carta dorata la mettevo da parte. La riponevo nel cassetto piú basso della scrivania, forse per incollarla poi alla stella sulla punta dell’albero di Natale. Peccato che quando Natale è arrivato, sotto i quaderni e il portapenne la carta era tutta spiegazzata, me lo ricordo bene.
– Che pace, – abbiamo detto per l’ennesima volta, ma insieme. Il professore si è risistemato sul suo cuscino. Mi sono seduta meglio anch’io. Giocherellando con la palla argentata, l’ho guardato in faccia.
Le sue labbra formano un «ah», ma senza suono. Un «ah» silenzioso. Gli angoli della sua bocca mi fanno sentire la vecchiaia. Un’impressione molto piú forte di prima, quando mangiava gli abaloni. Abbassa in silenzio lo sguardo.
Il rumore delle onde non cessa mai.
– È ora di dormire, non crede? – ha detto lui pacatamente.
– Sí –. Cos’altro potevo rispondere? Mi sono alzata, ho richiuso la porta alle mie spalle e mi sono avviata verso la mia stanza. Sulle lampade ora c’erano molte piú falene di prima.
In piena notte, mi sono svegliata di soprassalto.
Avevo un po’ di mal di testa. Nella stanza ero sola. Ho cercato di ritrovare quell’ineffabile presenza del professore, ma non ci sono riuscita.
Ora che ero sveglia, stentavo a riaddormentarmi. Vicinissimo all’orecchio sentivo il ticchettio del mio orologio posato accanto al cuscino. Che cosa strana.
Sono rimasta ferma per un po’, poi mi sono toccata i seni sotto lo yukata. Seni né troppo morbidi né troppo sodi. Ho spinto in giú la mano, a carezzarmi il ventre. Un ventre liscio e levigato. Ancora piú giú. Mi sono sfiorata l’inguine col palmo. Toccarmi da sola però non mi dava alcun piacere. Mi sono chiesta cos’avrei provato se fosse stato il professore a carezzarmi, con uno scopo ben preciso, ma avevo l’impressione che nemmeno cosí sarebbe stato gradevole.
Sono rimasta distesa per una mezz’ora. Speravo di addormentarmi di nuovo, cullata dal rumore delle onde, ma non riuscivo a chiudere occhio. Chissà se anche il professore giaceva sveglio nell’oscurità...
Appena concepito, questo pensiero è andato gonfiandosi. Avevo l’impressione che da un momento all’altro lui dovesse chiamarmi dalla sua stanza, dove mi attendeva. Se si lascia libero corso agli stati d’animo notturni, finiscono col prendere proporzioni gigantesche. Non sopportavo di stare sdraiata ma neppure in piedi. Senza accendere la luce, ho aperto in silenzio la porta della camera. Sono andata al gabinetto in fondo al corridoio e ho fatto pipí, pensando che questo mi avrebbe forse calmato. Invece niente, ero piú agitata di prima.
Sono tornata nella stanza, mi sono di nuovo messa un velo di rossetto, poi sono andata fino alla stanza del professore. Poggiando l’orecchio contro la porta, ho cercato di capire se all’interno qualcosa si muovesse. Come una ladra. Ho sentito un rumore: non era il respiro di una persona addormentata. Tendendo l’udito, mi sono resa conto che il rumore ogni tanto diventava piú forte.
– Prof? – ho detto in un bisbiglio. – Come sta, prof? Tutto a posto? Non è che si sente male, per caso? Vuole che venga lí?
Di colpo la porta si è aperta. Abbagliata dalla luce che proveniva dalla stanza, ho chiuso le palpebre.
– Non stia lí nel corridoio, Tsukiko, entri, – ha detto lui invitandomi con un cenno della mano. Appena ho riaperto gli occhi mi sono riabituata alla luce. Il professore stava evidentemente scrivendo qualcosa. Il tavolo era cosparso di fogli. Quando gli ho chiesto cosa stesse facendo, ha preso un foglio dal tavolo e me l’ha mostrato.
Sul foglio c’era scritto: Ecco il polpo – appena arrossato.
– Le ultime cinque sillabe non mi vengono, – mi ha detto mentre leggevo con attenzione. – Cosa potrei scrivere, dopo appena arrossato?
Mi sono lasciata cadere su un cuscino. Mentre io mi struggevo per lui, lui si struggeva per il polpo o quel diavolo che era.
– Prof, – ho detto a voce molto bassa. Ha alzato la faccia distrattamente. Su uno dei fogli posati sul tavolo aveva disegnato maldestramente un polpo. Un polpo con una bandana a pois legata intorno alla testa.
page_no="131" – Cosa c’è, Tsukiko.
– Prof, se...
– Sí?
– Prof, lei...
– Mhn.
– Prof!
– Ho capito, ma mi dica cosa c’è.
– Cosa gliene pare di l’eco del mare?
Non riesco assolutamente ad arrivare al dunque. Ammesso che esista, un «dunque», tra lui e me.
– Ecco il polpo – appena arrossato – l’eco del mare... Cosí? Mhn...
Senza badare alla mia espressione esasperata, o forse fingendo di non badarci, il professore ha scritto il suo haiku sul foglio. L’ha scritto recitandolo ad alta voce: – Ecco il polpo, appena arrossato, l’eco del mare. Be’, non è niente male. Lei ha sensibilità per la poesia, Tsukiko.
– Ah, – ho risposto. Senza farmi vedere da lui ho preso un fazzoletto di carta e mi sono pulita la bocca, togliendo il rossetto. Borbottando fra sé, il professore rimaneggiava i tre versi.
– Tsukiko, cosa ne pensa di L’eco del mare – appena arrossato – ecco il polpo?
Cosa ne penso? Che non me ne frega niente! Apro la bocca ora senza rossetto per dire un ennesimo, debole «ah». Mentre scrive tutto contento il...