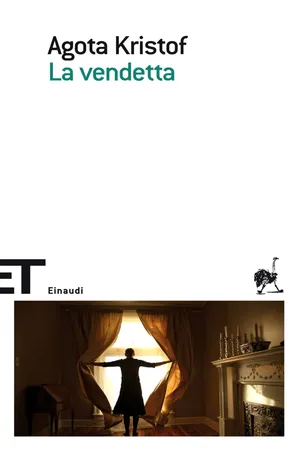![]()
Numeri sbagliati
Non so che cos’abbia il mio numero di telefono. Dev’essere simile a tanti altri numeri. E a me non dispiace. Nella mia monotona esistenza ogni chiamata è una distrazione. Da quando sono disoccupato a volte mi annoio un po’. Non sempre, a dire il vero. Le giornate passano incredibilmente in fretta. Ogni tanto mi domando addirittura come abbiano potuto mettere otto ore di lavoro in una giornata di per sé già cosí corta.
Le sere, in compenso, sono lunghe e silenziose. Per questo sono contento quando il telefono squilla. Anche se il piú delle volte è quasi sempre un errore, e io sono soltanto un numero sbagliato.
La gente è distratta.
– Officina Lanthemann? – mi domandano.
– No, grazie, – dico io, impacciato. (Bisognerebbe perdere questa mania di dire grazie a ogni piè sospinto). – Ha sbagliato numero.
– Questa poi, – dice l’uomo all’altro capo del filo, – sono rimasto in panne sull’autostrada tra Serrières e Areuse.
– Mi dispiace, – gli dico, – non saprei come aiutarla.
– Ma è l’officina Lanthemann o cosa? – e s’innervosisce.
– Mi scusi se non sono l’officina Lanthemann, ma se posso esserle utile…
Al telefono cerco sempre di essere gentile, anche quando non serve a nulla. Non si sa mai. Delle volte può nascere un rapporto, un’amicizia.
– Sí, può portarmi una tanica di benzina.
La voce è speranzosa, crede di essersi imbattuto in un buon pollo, e non ha torto.
– Mi spiace, signore, io di benzina non ne ho, ho giusto un po’ di alcol.
– E se lo beva, imbecille! – e riattacca.
Sono tutti cosí, i numeri sbagliati. Dal momento che non hai sottomano quello che desiderano non gli interessi piú. Avremmo potuto fare due chiacchiere.
Ricordo ancora il piú bel numero sbagliato che mi è capitato. Avevo lasciato suonare piuttosto a lungo. Attraversavo un periodo di grande pessimismo. Una donna. Alle dieci di sera.
Ho tirato fuori la mia voce da uomo navigato, in verità piena di angoscia.
– Pronto?
– Marcel?
– Sí? – dico io, guardingo.
– Oh! Marcel, è una vita che ti cerco.
– Anch’io.
È vero, la cerco da sempre.
– Anche tu? Lo immaginavo. Ti ricordi, in riva al lago?
– No, non mi ricordo.
Ho risposto cosí perché sono profondamente onesto, non mi piace barare.
– Non ti ricordi? Eri ubriaco?
– È possibile, mi ubriaco abbastanza spesso. Comunque non mi chiamo Marcel.
– Ma certo, – ribatte lei, – nemmeno io mi chiamo Florence.
Bene, è già qualcosa, so come non si chiama. Sto per riattaccare quando d’un tratto lei dice:
– È vero, lei non è Marcel. Però ha una bella voce.
Al che io mi zittisco. Ma lei continua:
– Una voce molto gradevole, profonda, dolce. Mi piacerebbe vederla, fare conoscenza.
Io rimango zitto.
– Pronto? Perché non parla piú? So bene che ho sbagliato numero, lei non è Marcel, voglio dire, non quello che mi aveva detto di chiamarsi Marcel.
Ancora silenzio. Soprattutto da parte mia.
– Pronto? Come si chiama? Io mi chiamo Garance.
– Non Florence? – le domando.
– No, Garance. E lei?
– Io? Lucien. (Non è vero, ma nemmeno Garance, credo).
– Lucien? È un bel nome. Senta, e se ci incontrassimo?
Non dico niente. Il sudore dalla fronte mi cola negli occhi.
– Potrebbe essere divertente, – dice Garance, – non crede?
– Non so.
– Non sarà sposato, spero?
– No, sposato, no. (Io sposato, che idea!)
– Allora?
– Sí, – rispondo. – Sí che cosa?
– Potremmo incontrarci, se vuole. Ride:
– Lei è un timido, mi sa. Mi piacciono i timidi. (Marcel dev’essere tutt’altro). Ascolti, le faccio una proposta. Domani pomeriggio tra le quattro e le cinque sarò al Café du Théâtre. Domani è sabato, non lavora, immagino.
E immagina giusto. Il sabato non lavoro, e gli altri giorni nemmeno.
– Mi metterò… – continua – vediamo, una gonna scozzese con una camicetta grigia e un gilet nero. Mi riconoscerà subito. Sono bruna, capelli di media lunghezza. Aspetti. (Non faccio altro). Davanti a me, sul tavolo, avrò un libro con la copertina rossa. E lei?
– Io?
– Sí, come farò a riconoscerla? È alto, basso, robusto, magro?
– Io? Come preferisce. Diciamo di media statura, né magro né robusto.
– Ha baffi, barba?
– No, niente. Mi rado ogni mattina. (Ogni tre o quattro mattine, a seconda).
– Porta dei jeans?
– Si capisce. (Non è vero, ma a quanto pare le piacciono).
– E un maglione nero, credo.
– Sí, nero, il piú delle volte, – rispondo per farle piacere.
– Bene, – dice, – capelli corti?
– Sí, corti, ma non cortissimi.
– Biondo o bruno?
Mi irrita. Sono bruno - grigio topo, ma questo non posso dirlo.
– Castano, – butto lí.
E se non le piace si arrangi. Tutto sommato preferivo il tizio in panne.
– È piuttosto vago, – dice lei, – ma la riconoscerò. E se si mettesse un giornale sottobraccio?
– Che giornale? (Adesso esagera. Io i giornali non li leggo).
– Diciamo Le Nouvel Observateur.
– D’accordo, prenderò Le Nouvel Observateur. (Non so che cosa sia, ma lo troverò).
– Allora a domani, Lucien, – dice. E prima di riattaccare aggiunge: – Trovo tutto ciò appassionante.
Appassionante! C’è gente che usa certe parole con grande facilità. Io non potrei mai parlare cosí. Ci sono un sacco di parole che non so dire. Per esempio: «appassionante», «esaltante», «poetico», «anima», «sofferenza», «solitudine» e cosí via. Semplicemente, non riesco a pronunciarle. Mi vergogno, come se fossero parole oscene, parolacce, tipo «merda», «porcata», «schifoso», «puttana».
L’indomani mattina mi compro dei jeans, e un maglione nero. Il commesso mi dice che mi stanno molto bene, ma io non ci sono granché abituato. Vado anche dal barbiere. Mi suggerisce uno shampoo colorante. Lo lascio fare, castano scuro, pazienza, se viene male non ci andrò. Invece viene bene. Ho i capelli di un bel castano, a parte il fatto che non ci sono abituato.
Torno a casa, mi guardo allo specchio. Le ore passano, continuo a guardarmi. E l’altro, lo sconosciuto, mi guarda a sua volta. Non mi piace. È meglio di me, piú bello, piú giovane, ma non sono io. Io ero peggio, meno bello, meno giovane, ma ci ero abituato.
Le quattro meno dieci. Devo andare. E cosí mi cambio alla svelta, mi rimetto il mio abito logoro di velluto marrone, non compro il giornale Ancien Observateur e alle quattro e un quarto sono al Café du Théâtre.
Mi siedo, guardo.
Arriva il cameriere, ordino un bicchiere di rosso.
Guardo. Vedo quattro uomini che giocano a carte, una coppia che si annoia lo sguardo perso nel vuoto e, a un altro tavolo, una donna sola con una gonna sul grigio, a pieghe, una camicetta grigio chiaro, un gilet nero. Porta anche una lunga collana composta da tre catenine d’argento. (Non aveva accennato alla collana). Davanti a lei, una tazza di caffè e un libro con la copertina rossa.
Non sono in grado di darle un’età, per via della distanza, però intuisco che è bella, molto bella, troppo bella per me.
Vedo anche che ha dei begli occhi tristi, con un fondo come di solitudine, e ho voglia di andarle incontro ma non riesco a decidermi, perché ho messo i miei vecchi vestiti di velluto logoro. Vado in bagno, dò un’occhiata allo specchio e mi vergogno dei miei capelli castani. Mi vergogno anche di quello slancio che ho avuto verso di lei, verso quei «begli occhi tristi, con un fondo come di solitudine», solo uno stupido capriccio della mia fantasia.
Torno nella sala, mi siedo a un tavolo molto vicino per osservarla.
Lei non mi guarda. Aspetta un giovane in jeans e maglione nero con un giornale sottobraccio.
Consulta l’orologio del bar.
Non posso fare a meno di fissarla, il che, mi pare, la infastidisce, perché chiama il cameriere e paga il suo caffè.
In quel momento la porta si apre, o meglio, i due battenti della porta si spalancano come in un western e un giovane, piú giovane di me, entra e si ferma davanti al tavolo di Florence-Garance. Indossa jeans e maglione nero, sono quasi stupito che non abbia una colt e degli speroni. Inoltre ha capelli neri alle spalle, e una bella barba dello stesso colore. Dà una scorsa agli astanti, me compreso, e sento distintamente quello che si dicono.
Lei dice:
– Marcel!
Lui risponde:
– Perché n...