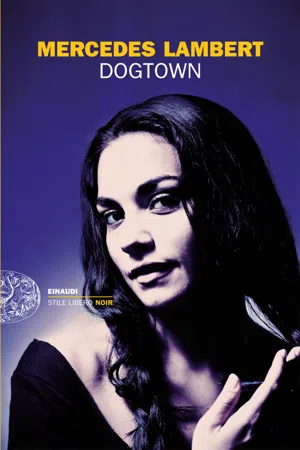![]()
9.
Mi feci preparare un altro Mai Tai dal dispenser.
Poi rimasi a guardare il ghiaccio che si scioglieva sul fondo appiccicoso del bicchiere, tra il rum nauseabondo e dolciastro e il succo di frutta che prendevano un colore marrone, mentre tentavo di escogitare il da farsi.
Perché non andavo alla polizia, come avevo minacciato di fare a Monica Fullbright? Perché non sapevo in cosa potesse avermi coinvolta, la mia cliente, e avevo paura. Ero stata assunta per cercare una guatemalteca di nome Carmen Luzano. Ma non ero riuscita a trovarla, cosí Monica Fullbright – in maniera molto opportuna – mi aveva detto dov’era. Una volta sul posto, avevo scoperto il cadavere di una donna. Pur non essendo un’esperta, avevo capito subito che doveva essere morta da un pezzo, vista la rigidità del suo braccio, e ripensare al tonfo di quel braccio sul pavimento, quando Lupe aveva girato il cadavere, mi faceva ancora venire la nausea. La morta non era Carmen Luzano ma un’attrice, Cathy Vega. Monica Fullbright la conosceva, Cathy Vega, ma mi aveva detto di no. Eppure aveva chiamato Cathy lasciandole un messaggio in cui dichiarava di volerla vedere.
Cathy Vega era morta in circostanze orribili. Secondo me l’aveva uccisa Monica Fullbright, che adesso stava cercando di utilizzarmi come alibi. Se fossi andata a riferire i miei sospetti – e piú di questo non potevano essere, stante l’attuale mancanza di un cadavere – la polizia mi avrebbe messo sotto torchio accusandomi di aver violato il segreto professionale. Il che avrebbe significato la fine della mia carriera, oltre che la dimostrazione che mio padre ci aveva visto giusto. Rischiavo addirittura di essere incriminata per favoreggiamento.
Alla lunga riuscii a cavarmi dalla sedia per andare a recuperare la macchina. Era calata la sera, ma faceva ancora caldo. Luci bluastre gettavano un velo tremolante su ogni cosa: l’effetto era quello di un negativo in bianco e nero. Il parcheggio era pieno a metà. Sulla Vermont c’era un gran traffico. Coreani dall’abbigliamento costoso su auto di grosse dimensioni. Famiglie di neri e ispanici strizzate dentro station wagon o pick-up scoloriti, dirette verso un supermercato dove avrebbero speso le loro magrissime buste paga. La mia macchina era ancora dove l’avevo lasciata, ma pendeva sulla sinistra. Gomma anteriore a terra. La cambiai, insozzandomi di morchia i pantaloni bianchi. Alla stazione di servizio mi dissero che non la potevano riparare. Andava buttata, a causa di un profondo squarcio. Provocato, per esempio, da un punteruolo per il ghiaccio.
Mi guardai attorno. Di andare a casa, neanche a parlarne. Il tizio che mi aveva seguito mi stava ancora dando la caccia, e non volevo fargli sapere dove abitavo. Era stata Monica Fullbright, a sguinzagliarmelo addosso? Stava cercando Cathy Vega? Potevo recarmi al club in cui si esibiva la coinquilina della morta, beccare il primo set suonato dal deejay e tentare di mimetizzarmi fra tutti quegli allupati in pelle nera che erano soliti sfoggiare allo Scream la loro pallida, strafatta personalità notturna, ma preferivo un luogo in cui fosse meno difficile stare in guardia da quell’uomo. Dovevo averlo alle calcagna da quando ero uscita dal condominio di Cathy. E, finché non fossi riuscita a risalire dal numero di targa alla sua identità, preferivo non vederlo piú. Con delle salviette di carta azzurra mi misi a sfregare rabbiosa le chiazze nere sui pantaloni, ma con l’unico risultato di allargarle ancora di piú. Mi ero sporcata anche uno dei sandali Maude Frizon. Alla fine decisi di tornare in studio. Tanto, se l’ispanico era stato mandato da Monica Fullbright, l’indirizzo del mio ufficio lo sapeva già. Quantomeno avrei potuto rimettermi in pari con un po’ di lavoro arretrato.
Il portone del palazzo era chiuso, ma al piano superiore si scorgeva una luce nell’ufficio di Harvey Kaplan. Provai un incredibile sollievo: quando c’è tempesta, come dice il proverbio, ogni buco è un porto, e io l’avevo raggiunto sana e salva. Chi mi vietava di parlare con Harvey? La figura paterna e comprensiva che mi era sempre mancata. Nel muovere i primi passi di una nuova carriera è fondamentale l’assistenza di un mentore, di una sorta di padrino. Perché non Harvey Kaplan? Di conversazioni piú che ragionevoli ne avevamo già avute. Era stato lui a darmi qualche suggerimento in vista della mia prima udienza preliminare: un banale e maldestro furto d’auto commesso da un povero vato che abitava sulla Berendo, nei pressi delle superstrade. Aveva fregato una vecchia Toyota color arancio collegando i cavi d’accensione, poi, strafatto di eroina messicana, aveva finito per assopirsi al volante all’imbocco di un vicolo tra la New Hampshire e il Washington Boulevard. Mi ero già dimenticata il suo nome. Non aveva ottenuto la libertà provvisoria e stava per farsi due anni a Chino. È cosí che funziona. Loro finiscono in un carcere di stato e noi ce ne andiamo a pranzo. E, secondo Manny Washington, Harvey Kaplan era stato un asso dei tribunali.
Nel salire le scale al buio, udii della musica. La porta di Harvey era chiusa. Bussai piano. Aprii, sbirciai all’interno. Sdraiato sul divano, lui russava a bocca aperta circondato da una nuvola di hashish densa come foschia d’inizio giugno. Una gamba gli si contraeva come quella di un cane in preda agli incubi. Sul bracciolo del divano c’era una coperta ricamata, che gli stesi addosso. Prima di andarmene, spensi la radio, sintonizzata su una stazione di vecchi successi che trasmetteva i Beatles e Simon & Garfunkel. Coo coo ca choo.
Le scartoffie relative all’istanza della signora Peterson erano ancora sparpagliate sulla mia scrivania, assieme al volume che mi aveva prestato Harvey. Accesi la lampada da tavolo, aprii il libro e mi misi al lavoro. Ero arrivata alla parte in cui mi sarei dovuta far venire in mente un motivo per giustificare la prevalenza dei diritti costituzionali di quella donna sulla sicurezza delle pazienti ricoverate nella clinica abortista, quando una pietra non particolarmente grande piombò sulla scrivania attraverso la finestra.
Spensi all’istante la lampada e mi gettai a terra. Un altro sasso. Strisciai lungo la parete fino ad arrivare accanto alla finestra e provai a dare un’occhiata fuori. Nel cerchio di luce sotto il lampione stazionava Lupe Ramos in un altro dei suoi assurdi paludamenti: un paio di pantaloni viola da torero, questa volta, tacchi alti color argento e un top giallo scollato sulla schiena. Di sicuro pensava di essere Rita Hayworth nella versione postmoderna di Sangue e arena.
– Ehi, Whitney. Whitney? Vieni giú.
– Zitta! Ma che cazzo fai? – Voleva che uscissi di testa per via dei cinquanta dollari che le dovevo? Per come avevo buttato via i soldi, quel giorno, tra drink e piste balorde, ero quasi tornata al verde.
– Sono nei guai.
– Va’ via, ho da fare.
– Scendi.
– Sto lavorando –. Accennai ad andarmene.
– Ricordati i cinquanta dollari che mi devi, – disse lei, alzando la voce. Una coppia che stava uscendo da Sam’s, al pianterreno, sollevò lo sguardo per vedere con chi stesse parlando.
Scesi. – Che è successo? Di nuovo beccata dagli sbirri?
Con fare nervoso, lei si gettò dietro le spalle i lunghi capelli neri. – Mio fratello mi cerca. Vuole uccidermi.
– Come? – Mi avvicinai al falso pepe, togliendomi dalla luce del lampione.
– Ho detto a mia madre che faccio la cameriera in un bar.
– La cameriera in un bar? – Scoppiai a ridere. – Non l’avevo mai sentito definire cosí.
– Esatto, la cameriera. Ma cosa credi, che vado a raccontarle che per soldi scopo coi clandestini? Sí, le ho detto che facevo la cameriera in uno di quei bei posti a Hollywood tipo il Ciro’s o il Mocambo. Quelli frequentati dalle stelle del cinema. Solo che è da trent’anni che posti del genere non esistono piú, e neanche quei divi. Niente Marilyn, niente Lana. O Rita –. Con un sospiro si aggiustò la spallina del top. – Fatto sta che mia madre ci ha creduto, ma il problema è che qualcuno deve avermi vista in giro e l’ha raccontato a mio fratello.
Per non guardare in faccia Lupe, imbarazzata com’ero, lanciai un’occhiata in strada. Allora, dopotutto, avevamo qualcosa in comune. Spontaneamente, io non dico mai nulla ai miei familiari. E lei credeva davvero di vivere in una città cosí piccola che il fratello l’avrebbe potuta trovare senza difficoltà? Perché non si spostava in un altro cantone? Forse voleva sapere se l’avevo visto. – Che aspetto ha?
– Hector Ramos? Manos Ramos? Mai sentito nominare?
Scossi il capo.
– Faceva il pugile. Un medio-leggero. Due volte sfidante per il titolo locale.
Scossi ancora il capo.
– Be’, non importa. Ormai ha gettato la spugna. Troppo vecchio. E troppe botte in testa, non so se mi spiego. Ma a calci in culo mi sa prendere ancora.
– Ah sí? – dissi, insospettita.
– Stasera devo togliermi dalla strada. Portami a casa tua, e facciamo pari con la plata che mi devi.
– Ma non posso! Perché non senti il tuo ragazzo? Com’è che si chiama? Alfredo?
– Da Alfredo è il primo posto dove andrà a guardare. Forza, domattina me ne vado –. Lupe giunse le mani con fare supplicante, appena sotto le labbra piene. Linda Darnell nella cappella, poco prima della fatale corrida.
– No… – esitai, chiedendomi quanto sapesse o sospettasse, Lupe, di ciò in cui ero coinvolta.
Con gesto di sfida, fece scattare una mano verso di me. – Non ho mica i pidocchi, sai.
– È solo che ho da fare.
Mosse un passo in avanti. – Vale a dire? Ti aiuto io. Gratis.
Non mi serviva, il suo aiuto. E neanche lo volevo. Ma la sola idea che l’avessero vista con me e fosse ormai in altrettanti casini mi suscitava un senso di colpa.
– La morta che abbiamo trovato… – esitai.
– Ancora con questa storia? La vita in strada è cosí. Di’ alla tua cliente che era al Club tropical e passa ad altro. Che te ne importa, in fin dei conti? Mica te ne fregava qualcosa, che era una puttana.
– Non è stata una morte accidentale, secondo me.
– Qué mala suerte! – imprecò lei, pestando il piede per terra. – Lo sapevo che era meglio continuare con i pompini. Già mi ero chiesta perché non ci fosse il cucchiaino, accanto a quella tipa. Con cosa se la scaldava la roba?
Il mio silenzio dovette renderla ancor piú nervosa, perché cominciò ad andare su e giú. Una macchina grigia rallentò, suonandole il clacson, ma Lupe non alzò neppure lo sguardo.
– Chi è stato? Dici che sanno di me? – Si fermò di colpo, mettendosi le mani sui fianchi.
Mi restava difficile guardarla negli occhi e continuare a parlare. – Non lo so. Un tizio mi ha seguita, oggi.
– Seguita! E io, allora? – domandò infuriata. – Mi ci hai ficcato tu, in questa storia. E adesso mi porti via di qui.
– Non ti preoccupare, ho detto. Risolvo io il problema. So già cosa fare –. Chissà se anche alle sue orecchie queste parole sembravano vacue quanto alle mie.
– E cosa? Cos’è che fai? – mi chiese pressante.
Avevo combinato un casino. Me l’ero portata in centro. Non la volevo tra i piedi, e neanche volevo sentirmi responsabile per lei. – Ho bisogno di tempo, per decidere se puoi stare a casa mia, – tergiversai.
– Okay, ma togliamoci dalla strada anche se non andiamo da te –. Poi si guardò attorno, innervosita. Una delle sue colleghe nere dall’altra parte della via, quella che assomigliava a Diana Ross sotto steroidi, la salutò con la mano. Lupe le restituí il saluto, con fare distratto. – Qual è il piano?
Da quanto era buio, sotto il falso pepe, sembrava di essere nel ventre materno e ugualmente al sicuro.
– Allora, me lo vuoi dire? Non ho ancora sentito nulla. E secondo me un piano non ce l’hai, – incalzò impaziente.
– E invece sí, – risposi secca e sulla difensiva. Peccato che non ce l’avessi, un piano.
– Bene –. Si mise a braccia conserte. – Allora vengo con te. Sono molto ubbidiente. E poi, come diamine fai la prossima volta che ti tocca parlare spagnolo? Adesso, da queste parti, voi gabachas siete in minoranza, lo sapevi?
– Va bene, vieni, – dissi, sospirando sconfitta. – Ma parlo solo io, capito?
La macchina di Lupe, una vecchia Fiat rossa che aveva la portiera del passeggero dipinta con una sola mano di grigio, si trovava sulla Wilton, a un paio di isolati di distanza. Passammo davanti a un vecchio palazzo in mattoni rossi attorno alle cui porte crescevano strelitzie. Un cane giallastro attraversò di corsa la strada, rincorso rumorosamente da un paio di ragazzini messicani. Lupe infilò la chiave nella serratura, aprí la portiera e avviò il motore.
Poi rimase in silenzio per parecchi isolati, e io gliene fui grata. Dove stavamo andando? Le avevo detto di avere un piano. Mica potevamo girare a vuoto per tutta la notte. Si stava facendo tardi, ma c’erano ancora una trentina di gradi. L’aria che mi sbatteva in faccia era calda e sapeva di citronella. Passai la mano sulla gamba dei pantaloni, che mi ero sporcata nel cambiare la gomma, e mi chiesi se dovessi raccontare a Lupe di Cathy Vega. Le strade di Hollywood traboccavano di relitti del terzo mondo, ragazzine che si erano conciate come troiette di Mtv e chissà quali altri allegri sognatori. Decisi alla fine che forse era il caso di andare da Rudy Sancerre e vedere che razza di posto fosse.
Stavo giusto per parlarne con Lupe, metterla al corrente di ciò che avevo saputo su Cathy Vega, quando d’un tratto lei si lanciò in una tirata su Gesú Cristo.
Preoccupata, le gettai un’occhiata storta.
– È dalla Tunica. Lo stesso libro che Lauren Bacall leggeva a voce alta per migliorare la dizione. Se ne andava in cima a Mulholland Drive e si metteva a leggere a squarciagola. Ecco da dove l’ha tirata fuori, quella fantastica voce.
Mi voltai dall’altra parte. Ma in che razza di storia mi ero cacciata?
Lo studio di Rudy Sancerre si chiamava Flamingo Photo ed era sulla Third nei pressi della Western, un piccolo e grigio edificio con sbarre rosa alle finestre; sopra l’ingresso era appesa una grossa insegna al neon col numero civico. All’interno era tutto buio, e le finestre sulla strada erano state oscurate con spesso cartoncino colorato. Sul lato ovest, un vicolo separava l’edificio da un barbecue mongolo, mentre su quello est c’era un altro studio fotografico che esponeva in vetrina foto di matrimoni e per documenti di immigrazione. Il Flamingo Photo era bordato in travertino, una decorazione poco diffusa da queste parti ma di una certa popolarità nel quartiere in cui sono cresciuta io. Per due volte dissi a Lupe di fare il giro dell’isolato, mentre io scrutavo ben bene lo studio e tentavo di rappezzare un piano di attacco.
Alla fine le dissi di svoltare nel vicolo. Sul lato posteriore dello studio si apriva un piccolo parcheggio che Sancerre divideva con le attività commerciali sulla Western. C’erano un salone di massaggi orientali con una forte luce sopra la porta e una sala da biliardo messicana, dal cui ingresso spalancato si riversava nella notte musica tex-mex con le chitarre troppo alte. Lupe s’infilò in un posto vuoto accanto alla porta dello studio. Il parcheggio era immerso nell’oscurità, fatta eccezione per la luce sopra il salone di massaggi. Anche il volto di Lupe era invisibile. Nel tirare il freno di stazionamento, la sua mano sfiorò la mia. I suoi capelli sapevano di lanolina. Una nota piú intensa di profumo a base di rosa mi fece girare la testa per un istante.
Scesi per guardarmi attorno. Uno stretto marciapiede correva lungo il retro degli edifici che affacciavano sulla Third, ed era separato dal parcheggio da un’alta rete metallica. Vidi un cancello di ferro, avvallato e chiuso da una catena arrugginita e da un lucchetto. Una serie di mensole ai lati della porta posteriore di Rudy Sancerre ospitava una gran quantità di piantine grasse con le foglie spaccate in due e di felci ormai morte di sete. Un fico del caucciú, in vaso e tutto contorto, si inarcava su per lo stipite. Girai attorno all’edificio, raggiungendo la parte anteriore, e bussai alla porta. Nell’attesa, mi misi a osservare le foto nella vetrina dello studio adiacente, sulla quale spiccava anche la decalcomania di due bandiere incrociate: quella degli Stati Uniti e quella di Cuba. Nessuna risposta. Tornai al parcheggio.
Lupe era scesa dalla macchina e stava ballando un cha cha cha bello funky al ritmo di quella musica da cowboy. Speriamo che da dentro il bar non la veda nessuno, mi dissi. Non era proprio il caso che il parcheggio si riempisse di tamarri locali.
– Qué buena la vida! Los Bukis, la mia band preferita. Che bello essere vivi, – la sentii cantare mentre mi veniva incontro a passo di danza.
– Già. E sono favorevole a restarlo –. Ma cosa mi ero aspettata di trovare, in quel posto, nel cuore della notte?
Alla fine del brano ne iniziò subito un altro. – Ay! Los Caminantes me matan, – disse Lupe, ondeggiando assieme alla musica. – Davvero fantastico. Ma perché siamo venute fin qui?
Le sussurrai che il nome di Rudy Sancerre era saltato fuori quando avevo trovato una delle foto di Cathy Vega.
– Allora dovremmo dare un’occhiata in giro, – disse lei.
Schioccai le dita....