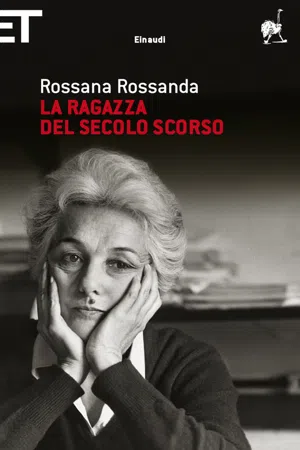![]()
Capitolo diciassettesimo
Nel comitato centrale dove tutto doveva venire sul tappeto, sul tappeto non venne niente. Come aveva previsto Ingrao. Le tensioni al vertice non furono visibili. Non ricordo se presi la parola, se lo feci non rischiai la sparatoria – ormai ero preda dell’ansia se parlavo, della vergogna se tacevo. La tenaglia della famiglia di appartenenza mi stringeva fra due errori, e io che credevo di esserne immune.
La sessione del comitato centrale si tenne in un momento di apparente tregua. La pressione studentesca si era allentata per via dell’estate, sciami di giovani svolazzarono fra una città e l’altra, in Italia e in Europa, cercandosi per il mondo, fu una curiosa Internazionale. Si passavano indirizzi e contatti, bussavano agli alloggi reciproci – i genitori dandosi alla fuga in villeggiatura. Erano sicuri di volere la cosa giusta, non c’era in essi ancora nulla di vendicativo, salvo gli Uccelli a Roma, che credo saltassero fuori allora, peraltro miti. Quei ragazzi erano distratti e allegri, avevano spesso una chitarra e se ne andavano senza rifarsi il letto. Non cercavano il Pci e questo era sollevato di non averli fra i piedi. Pensava che era stato un temporale ed era finito. Era contento che fosse finito. In Francia era finito.
Parve sospesa anche la minaccia sovietica. Due locomotive surrealiste che tiravano ciascuna soltanto un vagone di dirigenti, una ceca e una sovietica, si annusarono alla frontiera fra i due paesi, si parlarono senza spostarsi ognuno dal proprio territorio e si rassicurarono: io non esco dal campo socialista, io non ti invado. Lo prendemmo come un segnale positivo, tanta era la voglia di allontanare e rimandare. Ma era una tregua, anche se i documenti si volevano ottimisti. Ci interrogavamo non soltanto su quel che avrebbe fatto l’Urss ma su quel che stavamo diventando a forza di eludere le scadenze. Avevamo lavorato tanto perché il paese non si rassegnasse e sperato che l’est si scongelasse. Ma appena quegli obiettivi prendevano qualche corpo, eccoci paralizzati. Il Pci era capace di reazione solo quando si sentiva minacciato da destra, se veniva interpellato dalla sua propria parte metteva le mani in avanti, cercava di frenare, allontanare. Che cosa poteva essere piú grave che quel sottrarsi? Conoscevo il riflesso comunista di autoconservazione, ma fino ad allora mi ero voluta persuadere che se ripiegavamo era in vista d’una azione piú efficace, reculer pour mieux sauter. Adesso, a forza di rinculare non eravamo piú in grado di saltare.
I giovani erano già perduti. Era troppo facile vedere quanto fosse fragile quel sollevarsi di una generazione che non si opponeva, come noi, alla «reazione» ma all’intera architettura del sistema capitalistico – noi dicevamo diritto allo studio, loro davano l’assalto alla scuola come formatrice del consenso, noi dicevamo diritto al lavoro, loro volevano la fine del salariato, noi volevamo piú giustizia distributiva e loro se ne fregavano dei consumi. Il mondo gli era parso di colpo come era, come chi aveva appena annusato Marx sapeva che fosse. Era la prima ondata che contestava il progressismo.
Avremmo dovuto esserne felici. Certo poco sapevano delle passate lotte di classe, e fin dove sarebbero potuti andare prima che si rovesciassero contro di loro i rapporti di forza. Ma se non glielo dicevamo noi che avevamo fin troppa esperienza della lunga durata, chi glielo avrebbe detto? Ci avrebbero ascoltato se stavamo con loro, accanto a loro, dalla loro parte. La nostra presenza o assenza modificava la scena. Questo lo sapevo per certo, non occorreva cercar lontano, bastava leggere quel Gramsci evocato soltanto quando faceva comodo.
La verità contro la quale ancora colluttavo era che non intendevamo piú le domande che erano state anche le nostre, avevamo introiettato un paralizzante riflesso d’ordine dopo gli anni cinquanta e in quello stare né dentro né fuori il centrosinistra. Si scendeva in lotta per un obiettivo chiaro e limitato (ne eravamo capaci ancora) o niente, si stava alle regole non solo per non spaventare il prossimo, ma perché i comunisti erano i cittadini piú specchiati, studio, lavoro e famiglia. Altro che gli slogan del 1968 che dell’ordine dato denunciavano il ruolo di regolatore. Fin qui e non oltre. Lo aveva detto nel 1960 Amendola, ma perché addossarne la responsabilità a lui solo? Lui era stato il piú sincero. Se i comunisti avessero guardato alla parabola dell’Urss nella sua crudezza avrebbero colto lo stesso ripiegamento, ma o lo consideravano inevitabile o avevano imparato a distogliere lo sguardo. Erano diventati i piú onesti fra i socialisti, i meno audaci fra i riformatori. Erano perbene. Qualcosa deve esserne restato, se nell’età della corruzione sono stati fra i rari a non essere corrotti e corruttori. Da un Gramsci light avevamo assunto l’idea d’una società regolata, senza badare troppo a quale, via via scivolando nel timore del disordine. E tutto quel che non stava nelle nostre previsioni era disordine. D’altra parte far cagnara solo per sentirsi insieme non era cosa da noi, avvezzi a metterci insieme per conseguire uno scopo preciso. Chi avrebbe parlato allora d’un primato della relazione per la relazione, scendere assieme in strada soltanto per non essere piú soli? Nessuno. Certo non io, né allora né adesso. Ma a forza di essere ragionevoli avevamo perduto perfino la curiosità per quella insorgenza giovanile senza precedenti, figlia nostra e ribelle. Non soltanto quei bacucchi del Pcf se ne erano ritratti ma anche noi, i comunisti piú intelligenti d’Europa.
Pochi giorni dopo quello smorto comitato centrale le nuvole su Praga si addensarono. Luigi Longo fece un gesto insolito: mandò al Pcus una lettera nella quale avvertiva che se l’Urss avesse fatto un gesto di forza sulla Cecoslovacchia, lui, Longo, lo avrebbe condannato, a prescindere dalla posizione che avrebbe preso la direzione. Non l’avrebbe messo nero su bianco se non fosse stato estremamente preoccupato e non avesse saputo incerta la direzione. Non so di chi si aspettasse un dubbio, certo Secchia, Sereni, forse Pajetta, forse Amendola. In ogni caso lui, Longo, si esponeva e lo faceva sapere: sono uno dell’Internazionale, vi conosco, mi conoscete. Vi condannerò senza mezzi termini. Pensateci.
Se ci pensarono, al Pcus dovettero concludere che un dissenso del Pci, già sospetto, non avrebbe prodotto gran danno. Forse qualche nostro esponente suggerí, e qualcuno di loro particolarmente ottuso credette, che i comunisti italiani si sarebbero divisi tra fedeli e infedeli all’Urss, e gli infedeli avrebbero avuto la peggio. Tentativi del genere furono fatti in Spagna ma fallirono tutti. Come che sia, Longo dovette ricevere delle assicurazioni, non sarebbe successo niente; se no non sarebbe partito per Mosca, invitato a una di quelle vacanze medicalizzate che erano un residuo di fraternità fra partiti. Là, che io sappia, non ebbe contatti con Brežnev. Da Botteghe oscure tutti erano partiti lasciando qualcuno di guardia a ogni livello. Per la segreteria era rimasto Reichlin. Karol e io eravamo a Roma, che lasciammo soltanto qualche giorno per incontrare Ralph Miliband all’Elba, un amico incantevole, un compagno socialista del Labour. Mi rimproverò troppa indulgenza con gli studenti: «Vous tissez du mauvais coton», ripeteva a Karol e a me, interessati alla rivoluzione culturale in Cina non perché ignorassimo quanto grezzo fosse quel cotone ma perché quello buono dei comunismi e delle socialdemocrazie non aveva portato molto in là.
Verso la mezzanotte del 21 agosto Alfredo Reichlin mi telefonò: i tank sovietici stanno entrando a Praga. La segreteria era richiamata d’urgenza. Karol e io corremmo all’ambasciata cubana, Castro aveva tempestato contro l’incapacità dell’Urss di capire fratelli e alleati. L’ambasciatore aspettava da un momento all’altro la condanna dell’Avana. Il momento si prolungò tutta la notte. La mattina dopo Reichlin mi ritelefonò: il tuo amico Castro non condanna l’invasione.
Seguirono giorni febbrili. A Praga i carri sovietici erano stati accolti con stupefazione, diversamente da Budapest non c’era resistenza, la gente apostrofava i soldati russi che mettevano la testa fuori dalle torrette: «Ma perché siete qui? Che cosa venite a fare?» e quelli non sapevano che rispondere. Dubček era stato arrestato e portato a Mosca. Una parte del Pcc, guidata da tale Bilak – del quale non sapevo prima né ho saputo dopo – avrebbe chiamato l’Urss a difendere il socialismo dal nuovo corso che portava il paese dritto in grembo alla Germania. Non ci credette nessuno. I compagni che piú stimavamo, gli Smrkonský e gli Hájek, avevano convocato un congresso straordinario in una fabbrica di Vysocany alla periferia di Praga. Non scorreva il sangue ma la tensione era al massimo. Il presidente Svoboda era volato a Mosca a riprendersi Dubček, glielo avevano portato davanti in manette, e aveva rifiutato di parlare finché non gliele avessero tolte.
Il comitato centrale fu convocato qualche giorno dopo. Svoboda aveva appena riportato Dubček a casa, ma il governo era passato a Gustav Husák; chi poteva dubitare d’una figura della Resistenza cosí eminente e appartata? Pajetta ci aspettava al varco del salone dove campeggiavano i ritratti di Gramsci e Marx – appesi dopo il 1956 in modo da tenersi sul sicuro. A Praga era finita bene, no? ci chiedeva con aria confidenziale, la situazione era normalizzata. Sentii per la prima volta quella parola. Come bene? Siamo matti? Ma molti sembravano sollevati. Alcuni perché tutto si ingoia purché non scorra sangue e altri perché il nuovo corso aveva degli accenti socialdemocratici, gli Ota Sik e i Richta, che l’Urss aveva giustamente represso. In quei giorni mi chiamò Gigi Nono – mi chiamava sempre la notte, spaventando una zia che considerava messaggere di sciagura tutte le telefonate oltre una certa ora – per protestare che non attaccavamo abbastanza (Ma che fa Pietro, che aspetta Pietro?) – e restò di stucco quando gli dissi che l’invasione era inammissibile. Lo era stata anche quella del 1956. Che idea aveva del socialismo? Ma come, mi replicò smarrito, Fidel, il Vietnam. Gigi era una persona seria ma semplificante, detestava ædanov e il realismo, ma sperava ancora che fosse un’incrostazione passeggera. Come avevamo sperato noi, tutti, in passato. Non era il solo.
Non ho mai saputo chi fosse l’autore d’un telegramma firmato «movimento studentesco romano», suonava qualcosa come «davanti ai carri armati sovietici, non dietro». Poi tutti lo smentirono ma lo ricordo bene. È vero che chiunque poteva mandare messaggi incontrollati. Fuori c’era una campagna contro l’Urss ma nulla a che vedere con il 1956 – come se le cancellerie dessero per scontato che ognuno facesse quel che voleva nel campo suo. Qualche giorno prima Luigi Longo, che non era uno con cui si andasse a prendere un caffè, mi aveva fermata in corridoio, il volto teso e gli occhi grigi pieni di collera: «Sapete, non mi hanno neanche informato». Aveva trovato sul vassoio della colazione, la mattina seguente, assieme agli inviti a questo o quel concerto, due righe del Pcus per informarlo che erano entrati a Praga. Era furibondamente composto, se lo si può dire d’un uomo cosí trattenuto.
Ma quella collera dovette essere reingoiata in qualche modo se anche la relazione al comitato centrale fu trattenuta. Biasimò il «tragico errore». Che diavolo voleva dire errore, ancorché tragico? Un equivoco? Una colpa preterintenzionale? Una svista in un corretto percorso? Ad alcuni di noi parve insopportabilmente ipocrita, o forse non ne potevamo piú di un understatement che confinava con il silenzio. E per la prima volta partimmo davvero in piú d’uno. Ma quale errore, stava nella logica di quel che ormai era il campo socialista – blocco di stati che non si scioglieva soltanto perché a sovranità limitata. Avrebbero potuto risponderci: ma è stato cosí sempre. Avremmo potuto ribattere che non era stato cosí fino al 1949, e non avremmo dovuto tollerarlo già da allora. Se c’era errore era stato il non discuterne. E non si tirasse in ballo la Guerra fredda, che le accuse di tradimento e le impiccagioni avevano soltanto aggravato. E nel 1956 avevamo digerito l’Ungheria. Tacere era stato e continuava a essere una colpa.
Non ricordo se riuscissimo a dire tutto questo dalla tribuna, so che fu la prima uscita clamorosa di Pintor, di Natoli, non ricordo se anche mia – ci eravamo sentiti febbrilmente in quei giorni. Qualcuno cautamente ci seguí. Non la direzione. Non posso escludere che si fossero scannati all’interno della segreteria, ma poi avevano raggiunto un compromesso sul «tragico errore». Forse per il solito «ne pas désespérer Billancourt». Ci replicarono accusandoci di antisovietismo – eravamo andati imperdonabilmente oltre quello che era già uno strappo. Là cominciò la nostra fine, o il pretesto di quella che sarebbe stata la nostra fine. Ripensandoci, la responsabilità piú grande del Pci non fu di avere messo fuori noi, ma di essere stato alla «normalizzazione» al di là di quel che ormai era obbligatorio. C’era stato il memorandum di Togliatti. C’era stato a Praga un congresso di comunisti, non dei poco amati dissidenti, ma di quel Partito comunista cecoslovacco che alle elezioni del dopoguerra era risultato il piú grande d’Europa con il suo trentotto per cento di suffragi, che il 21 agosto non era sparito, che non aveva preso le armi contro Mosca – e il Pci lo rinnegava. Quando continuò a vivere nella repressione, al confino, nei ritagli della società, nell’esilio, e i suoi uomini cercarono qualche contatto, Botteghe oscure non ne ricevette uno solo. Soltanto Bruno Trentin ebbe l’ardire di accogliere con amicizia alla Cgil un uomo dell’est, non ceco, il polacco Adam Michnik, che del resto comunista non era. I cechi, Reimann, Smrkonský, Hájek, Friš – i nomi affiorano con i volti – furono calati nel silenzio. Neppure gli uomini di studio e di lettere, i Goldstücker e i Liehm che a un certo punto Husák lasciò partire, entrarono mai in Botteghe oscure – li lasciava partire perché era sicuro che nessun partito comunista avrebbe dato loro una mano. Trovarono qualche accoglienza fra i socialisti, che poco potevano. E quando quei paesi caddero l’uno dopo l’altro fuori dal «socialismo reale» tutto era stato devastato, anche una tiepida socialdemocrazia. L’esilio degli uomini dell’est – non solo cecoslovacchi ma molti polacchi e qualche ungherese – fu disperante.
Il movimento del 1968 non ne fu coinvolto. Aveva già lasciato alle spalle l’universo comunista, stati e partiti. Non gli interessava, non ne sapeva niente, gli bastava la condotta del Pcf nel maggio a Parigi e la difesa dell’estremismo contro Lenin che oggi Daniel Cohn-Bendit non scriverebbe piú. Le notizie di sciagura che ogni tanto arrivavano dall’est classificavano quelle società come caserme. I sessantottini erano libertari, antiborghesi, antisistema, anticapitalisti e antimperialisti. Ogni tanto acclamavano Lenin, Rosa Luxemburg (pochi), Ho Chi Mihn e Mao (di piú), ma non erano che simpatici simboli. Si trattava di battere il potere, anzi i poteri esistenti da noi, e gli parve a portata di mano, sarebbe seguito alla presa di coscienza, stava già nella presa di coscienza – che cosa era stato, o sarebbe stato, il tentare una società diversa non si domandavano. Le loro passioni e le loro condanne erano ardenti e approssimative, e salvo una simpatia per gli anarchici, le forze politiche non entrarono mai nelle loro riflessioni.
Nell’autunno del 1968 gli studenti si ritrovarono nelle loro sedi, decisi a logorare le università piú che a riempire le strade. Non avevano torto. Misero in causa i modi e tempi dell’insegnamento e i docenti non seppero come farvi fronte. Non tutti si sarebbero vantati come Claude Lévi-Strauss di essersi limitato, all’esplodere del maggio, a far rimuovere i tappeti dal suo studio. I piú erano colpiti, offesi, stravolti e si difesero malamente. Né li incoraggiava ad andare almeno a vedere da vicino l’essere stigmatizzati come odiosa e comunque defunta autorità accademica. I corsi erano tenuti a fatica dai pochi assolti dall’accusa di connivenza, ma anch’essi regolarmente interrotti da apostrofi.
Le autogestioni erano diffuse e confuse. Il saggio di Guido Viale Contro l’università sui «Quaderni Piacentini», che aveva dato fuoco alle polveri, è convincente tuttora, ma la domanda in che potrebbe consistere una diversa trasmissione dei saperi, quali saperi, e perché e come, restò senza risposta per incapacità delle parti. Piú tardi il 30 per tutti entusiasmò i ragazzi, terrorizzò i professori e non cambiò nulla. Nell’inverno del 1969 cominciarono a organizzarsi i gruppi che si definirono extraparlamentari. Erano nati dal sensato bisogno di darsi un’analisi, una tesi e una linea di azione non limitate alle manifestazioni. Ma la scuola essendo un tassello del sistema, subito la sua riforma o il suo rivoluzionamento – era questione di linguaggio – passarono in secondo piano. I gruppi furono politici a tutto campo, Avanguardia operaia era il piú riflessivo, Potere operaio il piú colto, Lotta continua il piú diffuso portatore del rifiuto, del «tutto e subito», i marxisti-leninisti filocinesi si divisero rapidamente in due, linea rossa e linea nera. In quel ribollire di proposte moltissimi transitarono da un gruppo all’altro e molti, che non si sentivano espressi o consideravano fatale ogni sorta di organizzazione, si dibatterono nell’autogestione dei controcorsi. Contro era il denominatore comune, e aveva le sue ragioni.
I gruppi extraparlamentari non riuscivano a darsi una pratica molto diversa dai partiti, salvo rieleggersi un capo carismatico su una base fluttuante. I controcorsi sbatterono sullo scoglio di quel che andava preso e quel che andava rifiutato della cultura passata: mai il problema fu piú appassionatamente posto e se ne disegnò cosí poco una traccia di soluzione. Le relazioni fra un gruppo e l’altro, e tutti i gruppi e le assemblee, in breve tempo divennero acerbamente concorrenziali. Nulla sarebbe stato piú come prima per quella generazione finché non si trovò fuori dalle aule: e fuori nutrí piú il rancore della sconfitta che il tentativo di raddrizzare una rotta perduta. La riflessione su quel totale cambiare di segno del mondo restò sospesa salvo in pochi, e in altri restò come una qualità umana diversa nella professione o nel volontariato, piú attenta all’altro, e del tutto separata dalla politica. Ma la continuità con il Novecento rimase spezzata per sempre, nel suo raffreddarsi la lava bollente diventò pietra, ed è ancora oggi piú maledetta che esplorata.
Finche durò l’eruzione studentesca il Pci non aprí bocca. Si cacciò in un angolo inarcando il dorso come un gatto sotto il temporale. Quando qualche anno dopo ne avrebbe veduto le derive minoritarie violente non si chiese niente, non si rimproverò un’omissione, si felicitò con se stesso e passò dalla parte dell’accusa. L’assenza fu teorizzata come severamente critica, ma fu assenza e basta. Un tentativo di far muovere nell’autunno gli studenti medi durò poco tempo – erano piú giovani, piú irreggimentati nella loro classe, non avevano la libertà degli universitari. Ma nell’autunno del 1968 non li seguii da vicino. L’invasione della Cecoslovacchia pesava tanto dentro il Pci quanto poco fra gli studenti, li oscurava, ricreava la sindrome «tutti ci attaccano», schiacciava quel grosso corpo politico sulla vicenda dell’Urss.
Andavamo in tumulto verso il XII congresso del partito, le cui tesi prodotte dalla direzione erano reticenti su tutto, studenti, situazione interna, invasione di Praga. Al comitato centrale che le doveva varare, Natoli, Pintor, Caprara, Milani, altri di noi le respinsero, e non piú a mezza voce. Dovette essere un fuoco di fila che interpretava molti perché, se non mi tradisce la memoria, il testo non fu messo ai voti ma passato come una bozza ai congressi provinciali. E su di esso le federazioni si divisero, chi piú chi meno.
Se al congresso precedente la direzione aveva potuto confondere le acque insinuando che il diritto al dissenso chiesto da Ingrao era «oggettivamente di destra», nella preparazione del XII congresso non ci fu equivoco – la leadership denunciava un estremismo di sinistra. Da sinistra le votavamo contro e gettavamo sale su due piaghe, l’essersi il partito per la prima volta separato da un movimento imponente, perdendo molti giovani, e l’avere subito un atto militare dell’Urss che non aveva neppure a giustificazione la drammaticità delle giornate ungheresi. Il nostro no alle tesi fu piú critico che propositivo, diversamente da quello che aveva cercato di essere all’XI congresso la linea di Ingrao. Noi non proponevamo che cesure di continuità, ma oramai maturate, e nei congressi delle federazioni avemmo dalla nostra parte delle minoranze consistenti e una o due maggioranze.
Tanto che al momento di eleggere i delegati al congresso nazionale si mise in moto la macchina organizzativa, la quale sa bene che basta far passare una commissione elettorale sicura a inizio dei lavori – quando i piú sono distratti – per arrivare a una lista sicura di delegati. Natoli e Pintor erano popolarissimi a Roma e a Cagliari, Caprara a Napoli, Lucio Magri, Eliseo Milani e Giuseppe Chiarante a Bergamo, Luciana Castellina fra i giovani e le donne, ma nessuno di loro venne eletto delegato al congresso nazionale. A dimostrazione che se nei socialismi reali si fosse votato, la selezione avrebbe funzionato lo stesso. All’est i partiti comunisti non erano arrivati neanche alle soglie della tolleranza repressiva. Io sola venni delegata, dalla federazione di Milano, non perché vi fossi particolarmente popolare – anzi, il mio intervento fu duramente respinto da Cossutta – ma perché in alto loco s’era deciso che una voce dissenziente arrivasse con tutti i crismi al congresso. Non solo alle sedute plenarie – dove ogni membro del comitato centrale uscente aveva diritto alla parola, e avrebbero quindi potuto prenderla anche Natoli e Pintor – ma nelle sedute riservate alla Commissione politica e a quella elettorale (non essendo ubiqua, piú che a una non sarei potuta andare).
Assicuratosi il meccanismo, il Pci puntò su una gestione meno scandalosa del dissenso – dopo l’espulsione di Cucchi e Magnani era la prima volta che se lo trovava nel comitato centrale – e vi riuscí. Prima dell’assise nazionale fui addirittura mandata, per rispetto delle forme, a reggere un congresso provinciale in modo «imparziale», con imbarazzo mio e degli astanti.
Fra minoranze cercammo di collegarci ma interdicendoci perpetuamente di essere una frazione, simbolo maledetto – e non solo perché ci si poteva ritorcere contro. Cosí arrivammo, nell’inverno del 1969, alla sala bolognese dove il congresso si sarebbe tenuto, senza avere discusso se non gli interventi sicuri, quello di Natoli, quello di Pintor e il mio. Eravamo in una sorta di stadio, fuori cadeva una gran neve e faceva un freddo tremendo. Nella stanza d’albergo alla stazione rividi fino all’ultimo i foglietti che mi ero preparata per un intervento che non doveva durare piú di venti minuti, nei quali dovevo afferrare delegati e invitati, e non scordare che frotte di giornalisti erano venute ad assistere alla nostra esecuzione. Con loro stavamo sulle nostre, per l’introiettata abitudine di non parlare con gli avversari e la speranza che un contegno perfetto ci accattivasse i congressisti.
I quali ci applaudirono con fervore. Niente appassionava di piú una assemblea comunista che ascoltare una opposizione che ne esprimeva i sentimenti senza coinvolgerla ed era destinata a perdere, di modo che l’unità del gruppo dirigente era salva. A Natoli, a Pintor e a me fu data la parola uno al giorno, al mattino, dopo il primo o secondo intervento che fungevano da riscaldamento della platea. Era uno spazio corretto e assicurava una sala piena, obbligando alla presenza anche la stampa avvezza a scendere verso mezzogiorno, ora canonica dei leader.
La sinistra muore all’alba fu il titolo piú spiritoso dei quotidiani. Quei giorni non mi sono rimasti nella mente come particolarmente emozionanti – avevo patito di piú negli ultimi anni intervenendo nel comitato centrale, nell’incertezza se facevo bene o male. A Bologna tutto era compiuto, non che fossi certissima di non sbagliare, ma la segreteria sbagliava di sicuro. Il dado era stato tratto, quella era soltanto la messa in scena pubblica. ...