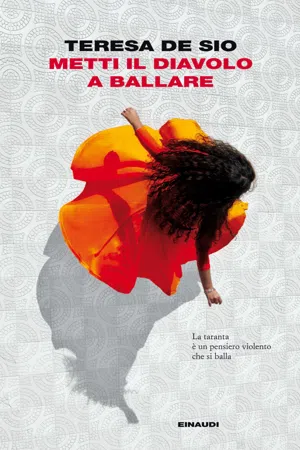![]() Mangiamuso
Mangiamuso![]()
Sabato Grasso
Nell’ultimo giorno di carnevale le passioni si acuiscono, battono, premono e riaffiorano a rivelare di quale impasto l’essere umano è fatto veramente. Qui a Mangiamuso, come del resto un po’ dovunque nel mondo, la gente si mette addosso panni non suoi, esotiche parannanze, notturni di pizzo nero soleggiati da brillóccheri e bigiotteria, velature e parrucche, oppure calzonacci, stracci e pezze al culo. I maschi si prendono per donne, i cristiani per bestie. I veri poveri si travestono da finti ricchi e tuttilcontrario. Forse per dire con il travestimento qualcosa di definitivo sulla propria natura, o forse per farne perdere del tutto le tracce.
Siamo nel 1956 e tutti credono ancora in ogni cosa.
In cima al corso principale del paese – quel tratto di strada frequentatissimo anche in giorni piú regolari di questo, e che unisce la piazza della prefettura con piazzetta della Signuría in fondo all’abitato –, compaiono, nel tardo pomeriggio di quest’ultimo giorno di carnevale, i figli del sindaco Siani. Il Corso è già illuminato a festa nel tramonto, intorno impazzano le mascherine, e il coriandolame diffuso pende su tutte le bancarelle di torroni e zuccheri filati che scorrono come un serpentone caramellato lungo tutta la strada giú giú fino alla piazzetta della Signiuría, dove finisce il paese e comincia il resto del Salento. I figli del sindaco sono due ragazzini secchi e allampanati, hanno 6 e 8 anni ma sembrano alti uguali, come se fossero stati schiacciati ai lati dalla stessa pressa, sono bruttarelli, ma adesso non si vede perché stanno mascherati da cagnolini. Passeggiano senza entusiasmo sul corso principale tenuti per mano dalla madre, signora Siani, un mezzo puttanone risaputa, pettoruta e impettita, che strattona i piccoli cani ogni volta che quelli si fermano per tirare coriandoli a qualche bambina, come la figlia del notaio Marra che passa trascinandosi dentro un ingombrante vestito da damina del Settecento, di quelli confezionati con eccesso di cura e di sfarzo tanto perché in paese si capisca a colpo d’occhio e una volta per tutte «chi può» e «chi non può», e dunque si porti rispetto. La signora Siani passa, senza fermarsi, davanti alla ricevitoria del lotto che è aperta anche se è un giorno di festa perché, si sa, la speranza non va mai in ferie. Seduta su una seggiolina che male regge il suo peso, proprio fuori della ricevitoria, c’è la Sapúta. È sola, come sempre, è ubriaca, tiene in mano un bicchiere di amaro averna o qualche altra roba alcolica di quel genere, i suoi 114 chili la fanno traboccare sulla seggiolina e ondeggiare in un continuo tentativo di assestamento. È vestita da odalisca, un abito azzurro e dorato, una serie incongruente di veli e setucce e frange da cui strasborda soprattutto la pancia. Poiché ha piovuto, si è tirata sulla testa un grande telo impermeabile prestatole da un bancarelliere lí di fianco e ci si è mezzo addormentata sotto. Adesso tutto quell’accroccone di telo e odaliscona la fa sembrare, piú che altro, un personaggio da circo equestre, o una vecchia abbandonata là da una carovana di zingari. La signora Siani fa finta di non vederla per non essere costretta al saluto e si chiede sinceramente come possa esistere un essere siffatto. Una che non è stata capace di fare niente di buono nella vita, solo ingozzarsi e bere fin quasi a scoppiare, e poi tutte le altre cose che si dicono sul suo conto... Aneddoti sui tanti maschi che sarebbero passati nel suo letto quando era ancora in grado di far girare la testa pure a gesúcristo da quanto era stata bella e di facili costumi, figli segreti frutto di storie clandestine con qualche tipo potente, misteri di paese... Certo, pensa la signora Siani, guardala adesso! Quella non si è saputa fare bene i conti e non ha messo a frutto la sua carne prosperosa come era invece riuscita a fare lei con il suo sindaco marito. Dunque nessuna confidenza! Non si ferma, tira dritto, la moglie del sindaco, che nessuno, nemmeno per un istante, la accomuni a quella perfetta sintesi di cattiva gestione della vita e totale infelicità che la Sapúta rappresenta! Ci tiene inoltre a far vedere che lei, signora Siani, non rientra, per rango sociale, nemmeno in quella manica di fessi e perdigiorno che passano il tempo in ricevitoria a parlicchiare di numeri e parenti, prima passati a miglior vita e poi ricomparsi in sogno a loro, figli e nipoti, per dare numeri «buoni» come se piovesse. No, lei no. Con quel meraviglioso culacchione che la natura le ha conferito come un premio aprioristico, lei non si occupa di numeri del lotto, ma li fa dare, i numeri, a tutti quegli uomini ingrifatissimi che si scappellano, salutano con aria da marpioni e le sbavano appresso, alla faccia del sindaco Siani.
Intanto il carnevale intorno cresce e suona forte. I suoi rumori sono scordati, dissonanti. Botti e fischi dappertutto. La strada è ancora un poco lucida per la pioggerella recente, bisogna fare attenzione a non scivolare. Molti bambini corrono in gruppi, da soli o accompagnati dai genitori. Zorro, damigelle, fatine, toreri, l’uomo mascherato, giapponesine, menestrelli e altre maschere meno riconoscibili, frutto di piú modeste sartorialità domestiche. La luce è quella violenta, poco realistica di un ultimo raggio di sole compresso tra la terra e un cielo ancora carico e nero. Nei colori copiativi che questa luce conferisce alle maschere, già si presagisce il buio.
Tra la folla compare e si intravede per qualche attimo un abito bianchissimo, da prima comunione, con il velo i guantini e tutto. È Archina Solimene che lo indossa. Cammina a testa bassa tirata per un braccio da suo padre Nunzio Solimene. Il vestito è decisamente troppo piccolo per lei, le va strettissimo e corto. A guardar bene, si capisce che è stato riallargato piú volte. Una macchia bianca visibile per qualche momento, un’intermittenza di colore tra le bancarelle. Compare e scompare come un cerbiatto tra gli alberi di un bosco. Padre e figlia camminano dritti, sembra che nei loro occhi non ci sia alcun tipo di sguardo. Dopo un attimo scompaiono, inghiottiti da folla e stelle filanti.
I giovani maschi provenienti dalle famiglie meno abbienti vanno in giro con gli stessi calzoncini di tutti i santi giorni e quelle giacchettelle sdrucinate e pataccose che portano tutto l’anno in classe. Questi ragazzini, che hanno un’età compresa tra gli 11 e i 14 anni, fanno branco, portano maschere solo sugli occhi e qualche berretto strampalato, solo per depistare. Sono armati. Impugnano clave di plastica gialle, rosse, verdi e marrone, ultima invenzione del mercato carnevalesco. Le clave sarebbero di per sé ultraleggere, ma i giovani castigatori, per renderle meno innocue, le hanno riempite di acqua o addirittura di sabbia, e adesso le usano per colpire le bambine bene vestite da damigelle. Le bambine urlano e se la fanno sotto al solo apparire di questi squadroni dal fondo di un vicolo. Sanno che niente e nessuno le potrà salvare dalla gragnuola di botte in arrivo. Nemmeno papà e mamma. Niente! Giú botte e fuga, botte e fuga, e farina e borotalco che, impastati all’acqua fuoriuscita dalle clave, fanno sui vestitini grandi mappazze e macchie.
Tutto intorno, stelle filanti, coriandoli, lingue di menelikke, mascherine che coprono per metà le facce, strilli, botti, fischi e mazzate. Gli adulti pure vanno in giro travestiti. Due passano mascherati da Pulcinella. Non si vedono le facce.
Sulla strada principale del paese, malgrado si siano già fatte le otto e mezzo, qualche bottegaio tiene ancora aperto, sperando in un poco di guadagno aggiunto in virtú della festa, e sta lí seduto sulla seggiola davanti all’ingresso del negozio a godersi il rutilante passeggio. Ogni tanto, toccandosi il cappello, saluta qualcuno che conosce o che gli sembra di riconoscere dietro alla mascherata.
Ora è quasi del tutto calata la sera, i colori sono meno psicotici e ogni cosa sembra, per qualche attimo, acquietata, una sera come le altre. Dalle finestre aperte sulla strada, dai piani bassi, arrivano i rumori di quelli che sono già tornati a casa e stanno mettendo a tavola. Ci sono due bancarelle di torroni che hanno il giradischi e, da dietro i loro banconi, arrivano le voci di Modugno, Nilla Pizzi, Franca Raimondi e altri cantanti di grido.
Passano tre figuri, con una fisarmonica, un tamburo e un tamburello tenuti in posizione di riposo. Indossano abiti incomprensibili, mezzo pastori e mezzo impiegati del Comune. Quello con la fisarmonica porta, infilata a coprire per intero faccia e testa, una maschera da leone, i due con i tamburi indossano l’uno una testa da capra e l’altro un testa da morto. Vanno giú per il Corso tra le bancarelle veloci e zitti. Si capisce che sono attesi altrove.
Un gruppo di tizi vestiti da donna, mezzi ubriachi e cantilenanti, esce da un portoncino e si getta nella mischia. Sbattono i tacchi a spillo sul marciapiede stretto, sghignazzano e si gridano frasi in dialetto, perlopiú insulti e qualche bestemmiuccia di carattere etilico. Dal modo in cui camminano e si atteggiano, si capisce che non hanno nemmeno la piú pallida idea di cosa sia una donna, di come si muova, cammini, parli. Quando il gruppetto passa davanti all’incrocio con vicolo Del Lazzaro, dalla stradina esce proprio in quel momento un altro tizio, pure lui vestito da donna. Trucco pesante, parrucca bionda, bracciali, gonna corta su gambe pelose, tacchetti mezzo e mezzo. A guardare attentamente, si capisce che si tratta di Narduccio Greco. Sulle prime sembra accodarsi agli altri travestiti. Cammina affiancato a loro, con un’andatura finto simbiotica, per alcuni metri. Proprio in quel momento, rasenti il muro del marciapiede di fronte, ricompaiono il vestito bianco di Archina Solimene e il giaccone scuro di suo padre Nunzio, che continua a tirarla per un braccio e la costringe a camminare veloce verso il fondo del Corso. Allora Narduccio si stacca dal gruppo di ubriachi con i tacchi e accelera il passo.
In tutto questo bailamme è possibile anche scorgere qualche passante assolutamente scollegato dal resto della festa. Come le due vecchie gemelle Santo, Fatima e Candelora, dette «le Sante». Risalgono dritte la corrente delle maschere, mute e senza dare confidenza a nessuno. Nemmeno vedono Solimene e la figlia che, dall’altro lato della strada, scendono in direzione contraria. Né Narduccio che, a distanza, li sta seguendo. Le gemelle vanno verso il duomo. Fatima porta un piatto largo coperto da un panno con dentro delle zeppole di carnevale. Stanno chiuse nei cappotti e in se stesse, attraversano la strada come imbambolate, con il viso cupo, immobile, assenti da un milione di anni da qualsiasi forma di carnevale, lontane da ogni festa come un palombaro lo è dalla luna o un minatore dalla cima della montagna.
Tutto intorno è baldoria.
Se potessimo seguire i tre suonatori, il Leone, la Capra e la Testa di Morto, li vedremmo arrivare nella piazzetta della Signuría, dove finiscono il corso principale e il paese. Qui c’è una piccola folla che li accoglie con grida di soddisfazione quasi stesse lí ad aspettarli da ore. Al centro della piazzetta, di fianco alla fontana, c’è un palo alto ornato da nastri gialli e rossi tenuto dritto da un uomo con la pancia cosí gonfia che gli crepa i bottoni della camicia, rubizzo di ubriacatura, senza nemmeno un dente in bocca. Ride e canta come se il carnevale fosse un affare tutto suo, come se il paese intero l’avesse indetto apposta per lui. Ha occhi languidi, irridenti, levantini, una notevole massa di capelli ondulati e bianchissimi un po’ appiccicati alla faccia per via del sudore. Si capisce che da giovane deve essere stato bellissimo. Alcuni dei presenti sono vestiti da vigile urbano, militare, prete, altri non sono travestiti affatto e sembrano fare da spettatori. Ci sono anche il prete vero, don Filino, due militari veri e un vigile vero. Il Leone, la Capra e la Testa di Morto cominciano a suonare, un terzinato in battere che subito suscita consensi nel piccolo gruppo, che però si sta lentamente arricchendo di nuovi spettatori fermi a guardare. In ultimo arrivano anche quelli vestiti da donna che, con i tacchi alti, hanno impiegato piú tempo a percorrere il Corso, e poi non ci dimentichiamo che sono completamente ubriachi.
La Capra comincia a cantare intonandosi con la fisarmonica del Leone. Appena partita la musica, le finte femmine iniziano a esibirsi in una specie di passerella, un po’ indossatrici e un po’ spogliarelliste, il pubblico applaude ma li deride e insulta anche, in dialetto strettissimo. Tutto sembra far parte di un gioco rituale prestabilito, oscuro al forestiero, ma pieno di senso per il gruppetto lí radunato. Il volume della musica sale. La Testa di Morto e la Capra battono sempre piú violentemente sui tamburi. Cresce la tensione. Il Leone, la Capra e la Testa di Morto sono concentratissimi, non fanno nemmeno il piú piccolo gesto che possa essere superfluo, muovono i corpi quel tanto che serve a favorire l’uscita del suono dalle pelli e dal mantice. A tratti sembra che ingaggino una breve lotta con lo strumento, però nessuno si fa male, nessuno dei suonatori vuole uccidere il suo strumento né viceversa, anzi, la lotta sembra fatta apposta affinché ognuno dei duellanti riesca a trarre fuori il meglio dall’altro.
La notte è calata del tutto.
Ora la folla è piena, ondeggiante, ognuno partecipa alla musica, guarda incuriosito, di quella curiosità che si rinnova ogni anno e per lo stesso rituale. Tutto viene accettato come si accettano la grandine e la siccità, come qualcosa di inevitabile, senza farsi domande.
La signora Siani se ne sta un po’ appartata con i figlicagnolini attaccati alla gonna, spaventati e attratti dalla festa, mentre lei, signora Siani, è attratta solo da uno dei suonatori. La moglie del sindaco pensa che nemmeno la maschera da animale può far sembrare quel giovanotto meno avvenente. Intanto nessuno riesce a starsene fermo. La musica attraversa violenta i corpi come un vento tra gli alberi e li fa ondeggiare. Una festa cupa.
In piazzetta della Signuría la luce dei lampioni è scarsa, appena rinforzata dalle lampadine di colore rossastro che pendono, in filari sguallariati, sulle teste del piccolo popolo radunato attorno ai suonatori. Niente luna, niente stelle, cielo coperto, basso, afoso. Passa una prima folata di vento. Le lampadine tremano. Due si spengono. Sul lato piú buio della piazzetta si intravede nuovamente il vestito bianco di Archina tirato per una manica da Nunzio. I due non si fermano a guardare la folla ondeggiante, non sentono la musica, vanno dritti verso l’uscita dal paese, come se stessero nuotando in un tempo scollato. Un destino differente.
Nello stesso cono di buio, Narduccio li segue a debita distanza, trascinandosi sui tacchi a spillo. Passa una seconda folata di vento. Il vestito di Archina si gonfia, si solleva intorno alle sue gambe secche, sembra un fuoco fatuo di ghiaccio ai bordi di un camposanto.
Intanto, il vento acchiappa il fazzoletto a fiori bianchi e rossi che tiene ferma la parrucca di una delle indossatrici finto femmina e glielo strappa. Quello bestemmia, prova a trattenerlo, ma niente. Lo rincorre per un po’, poi lo perde di vista. A malincuore si rassegna e torna indietro a continuare lo spettacolino. Il fazzoletto bianco e rosso svolazza per un centinaio di metri in direzione della campagna, si ferma per qualche attimo sul parabrezza dell’ultima automobile parcheggiata davanti all’ultima casa del paese. Poi il vento riprende a trascinarlo. Il fazzoletto schiva un gatto che attraversa la strada, risale verso un cespuglio, verso il ramo di un alberello dove resta incagliato per pochi secondi, e torna a liberarsi, vola sopra gli ulivi che circondano la masseria di Terranera, la casa dei Santo, che è la prima fuori dal paese, sfiora la faccia di Narduccio Greco che si è nascosto ansimante dietro a un palo della cancellata di cinta, slitta nell’aria ancora per qualche metro e alla fine si ferma, impigliato nei rovi intorno alle sbarre del cancello d’ingresso della masseria. Davanti al cancello sono appena arrivati Archina e suo padre Nunzio. Dentro la casa si intravede una luce fioca proveniente dalla cucina al pianoterra. Come di candele.
page_no="31" ![]()
Il testamento
Le nuvole gonfie di pioggia e nere passano veloci, spinte da quello stesso vento che ha trascinato il fazzoletto bianco e rosso attraverso gli alberi fino al cancello di Terranera. Si allontanano verso l’orizzonte e già, dall’altra parte del cielo, nuovi eserciti di portatori d’acqua cominciano ad addensarsi, in attesa che quello stesso vento torni indietro a prendersi anche loro. Narduccio alza gli occhi, guarda le nuvole, e non gli passa nemmeno per l’anticamera del cervello che quelle saranno le ultime nuvole della sua vita. Poi comincia a camminare avanti e indietro lungo la cancellata della masseria. Siccome non è abituato a muoversi sui tacchi, i piedi cominciano a fargli male. Allora si appoggia con il fondoschiena al muretto di cinta che sostiene la cancellata, si toglie una scarpa e si massaggia il piede massacrato. Cerca di prendere tempo. Sa bene perché è venuto fino a lí, sa che cosa deve fare. Però non si muove. È come se ci fossero due Narducci seduti su quel muretto. Perfettamente uguali, ognuno dei due con una scarpa in una mano e il piede nell’altra. La differenza però sta nel fatto che uno vuole sapere e l’altro no. Uno vuole entrare e scoprire se le cose stanno come lui se le è immaginate, oppure no, perché troppi ne ha letti di libri, quel Narduccio lí, e nei libri, si sa, le cose non vanno come nella vita vera. Anche sua moglie Mariannina glielo dice: troppa fantasia! Cosí, lui adesso vorrebbe entrare invisibile nella masseria e vedere se le cose stanno come lui se le è immaginate.
page_no="32" Poi c’è l’altro Narduccio, che invece vorrebbe togliersi tutte e due le scarpe e darsela a gambe, via da quel buio che tra pochissimo sarà totale, da quel cancello e dai pensieri che, quando si installano nella capoccia della gente, fanno solo danni, scavano e bucano come trivelle in una cava di pietra, e anzi proprio pietre diventano, e non te li togli piú dalla testa nemmeno con le cannonate.
Il Narduccio che vuole entrare si rimette la scarpa, abbassa gli occhi a guardarsi le gambe muscolose e piene di peli che spuntano da sotto alla gonna corta. Un uomo non sa mai veramente come sono fatte le proprie gambe, fino a che non si veste da femmina. Allora le vede per la prima volta, perché è come se guardasse il corpo di un’altra persona. E capisce qualcosa sul proprio conto che fino a quel momento non conosceva. A quel punto il Narduccio che vuole entrare si decide, spinge il cancello d’ingresso, che è rimasto accostato, e cercando di fare meno rumore possibile si avvicina alla porta-finestra che dà nella cucina al pianoterra.
Adesso Narduccio si dimentica del dolore ai piedi, delle nuvole che minacciano pioggia, del carnevale e di tutti i libri che ha letto e i film che ha visto. Rimane fermo, imbambolato, come gli spaventapasseri dei campi.
Le sue gambe da donna pelosa gli diventano pesantissime, non riesce nemmeno a muovere un passo, a dire una sola parola, perché la lingua in bocca gli è diventata cosí grossa che quasi non lo fa respirare. Non gli era mai comparsa la vita cosí, tutta intera, in un solo colpo. Sente la faccia deformarsi in un’espressione grottesca, una maschera pure quella.
Poi, come se qualcuno gli avesse di botto riaperto l’interruttore delle vene, sente il sangue tornare a scorrere. Fa come per scappare. Poi si ferma, torna indietro, spinge l’anta della porta-finestra ed entra nella cucina di Terranera.
page_no="33" Entrando Narduccio sente un odore forte di pecora morta e di stoffa sintetica bruciata. Angelo Santo gli dà le spalle, sta chino su se stesso, accasciato nella sedia a rotelle. Cerca di riattaccarsi il tubicino del catetere che pende fuori, da un lato della sedia. Poi si pulisce le mani con una pezza per i piatti che ha bagnato sotto alla fontana del lavandino.
Adesso Narduccio sta in piedi in mezzo alla stanza. Fissa il vecchio, muto.
ANGELO SANTO Allora, compare Narduccio, vi sembra questa l’ora di presentarvi a casa della gente?
Narduccio rimane muto.
ANGELO SANTO Vi siete messo una bella maschera, complimenti. Non si capisce bene, però, se volete fare ridere, volete fare spavento o volete fare solo schifo. A me personalmente mi fate un po’ schifo e un po’ mi fate ridere... Ma voi lo sapete, compare Narduccio, che mi avete sempre fatto un poco ridere e un poco schifo...
Narduccio rimane sempre muto.
ANGELO SANTO E...come sta vostra moglie? Che bella femmina! Che grandissimo piccione! Senza offesa, compare Narduccio, ma qua in paese non ci sta un maschio che non ci ha fatto un pensiero... e che pensiero! Eh eh eh. E invece voi che fate? Vi perdete appresso a una bambina di tredici anni! Adesso pure la notte vi mettete a seguirla?
NARDUCCIO Che dite? Pezzo di merda, state zitto!
ANGELO SANTO Ma vi prego, accomodatevi, mi ...