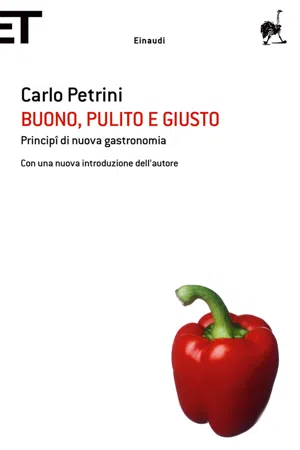![]()
I.
Un affresco poco rassicurante
All’interno di ogni capitolo inserirò una piccola serie di quelli che per comodità definisco Diari. Si tratta di esperienze vissute dal sottoscritto, raccontate in prima persona. Lo faccio perché sono episodi esemplificativi di tutte le varie teorizzazioni che provo a fare nel libro, e perché trovo che una materia complessa come la gastronomia si debba anche servire della conoscenza diretta, del viaggio, del contatto con altre culture o con le proprie radici piú profonde. Non si può diventare gastronomi soltanto leggendo libri: bisogna praticare, incuriosirsi, cercare di leggere la realtà con i sensi e venendo a contatto con il maggior numero di diversità possibile, parlando con le persone, gustando. Non si può diventare gastronomi nemmeno soltanto frequentando i ristoranti: bisogna conoscere i contadini, chi produce e trasforma il cibo, chi si arrovella per rendere il sistema di produzioneconsumo piú giusto, sostenibile e piacevole.
Visto il mio lavoro, ho avuto la fortuna di farne molte, di queste esperienze: e ognuna di esse ha influito moltissimo sulla mia formazione e sull’elaborazione delle idee che leggerete. Mi piace raccontarle, lo trovo utile ai fini del libro e sono sicuro che il lettore ne capirà le motivazioni.
Del resto, in effetti questi momenti hanno segnato un percorso, sia di vita sia di pensiero: a queste storie e all’umanità che hanno coinvolto devo gran parte del contenuto di questo libro.
Diario 1. Peperoni e tulipani.
Nel 1996 mi trovavo, come spesso mi accade, a viaggiare lungo la ss 231 che collega Cuneo ad Asti, e che passa per Bra, la cittadina di provincia in cui abito e dove ha sede il movimento internazionale Slow Food. Ancora oggi, nonostante sia in costruzione un’autostrada che collegherà i due capoluoghi, questa trafficata striscia d’asfalto che attraversa il basso Piemonte è un po’ il nostro unico collegamento con il resto d’Italia. Porta a est, e a ogni viaggio verso Milano o verso il Centro-Sud la si percorre.
Il basso Piemonte è storicamente votato all’agricoltura, una storia fatta anche di fame e stenti in passato, ma presto arricchita dall’arrivo della piccola industria e dall’instaurazione di un circolo quasi virtuoso tra produzioni agricole tradizionali di elevata qualità – tra cui spiccano alcuni tra i migliori vini italiani –, l’esportazione di tali prodotti e un turismo internazionale in espansione, attratto dall’estrema bellezza di alcuni paesaggi collinari e da quelle che obiettivamente sono vere e proprie meraviglie enogastronomiche.
La ss 231 attraversa questi territori e, oltre a essere famosa per la sua scomodità, è diventata in qualche modo il simbolo del benessere che ha ‘colpito’ i miei territori natali. È tutto un susseguirsi di capannoni industriali, centri commerciali e grandi supermercati che rappresentano alcuni tra i massimi orrori architettonici che l’uomo possa concepire. Soltanto in certi tratti resistono alcune serre dove si coltiva ancora qualcosa. Deprime attraversare tanto squallore, anche perché la lentezza dell’arteria consente di meditare ogni volta a lungo sui risvolti dello ‘sviluppo’.
Lungo la ss 231 – basta fare piccole deviazioni – la frequenza di ottimi ristoranti e osterie tradizionali che servono una rigorosa cucina di territorio è nettamente sopra la media rispetto al resto d’Italia: è qui che posso dire di aver incominciato a studiare gastronomia da autodidatta, e debbo ai migliori cuochi, cuoche e contadini di questo territorio una parte fondamentale della mia formazione di gastronomo.
Ma ritorniamo a quel giorno del 1996: di ritorno a casa mi fermai da un amico ristoratore che non vedevo da alcuni anni, e che sapeva cucinare una leggendaria peperonata1 . Volevo riassaggiarla per rinfrancarmi dal viaggio estenuante che stavo terminando; invece, con sommo disappunto, consumai una peperonata tremenda, del tutto insapore. L’abilità dello chef era fuori discussione, ma chiesi lo stesso spiegazioni di un simile impoverimento di gusto. L’amico mi spiegò che non utilizzava piú la stessa materia prima con cui faceva quella peperonata che riecheggiava nella mia memoria gusto-olfattiva: i peperoni quadrati d’Asti, una varietà carnosa, profumata e gustosa, non erano quasi piú prodotti nella zona, e al loro posto lui impiegava peperoni importati dall’Olanda. Importati perché meno costosi, coltivati in maniera intensiva, da varietà ibride per ottenere un risultato ottimo alla vista, con i loro colori sgargianti, perfetti per l’esportazione («in una cassetta ce ne stanno trentadue, non uno di piú non uno di meno, e sono tutti belli, sempre uguali» mi disse), ma drammaticamente insapori.
Presi atto che la favolosa peperonata era sparita e mi riavviai verso Bra. Passando per uno di quei tratti di statale dove ci sono ancora serre, mi volli fermare: lí una volta crescevano i peperoni quadrati d’Asti! Cosa diavolo c’era, adesso, sotto quei teli di nylon? Incontrai un contadino, che mi confermò che appunto là, fino a pochi anni prima, si coltivavano quei magnifici ortaggi. Ma ora non piú; e mi disse in dialetto: «Non conviene, gli olandesi costano meno cari e nessuno ce li compra piú i nostri! Dànno lavoro ed è tutta fatica buttata al vento!» «Ma allora – replicai, – cosa coltivate ora?», sorrise: «Facciamo crescere bulbi di tulipano! Poi li spediamo in Olanda per farli fiorire!»
Sobbalzai. Toccavo con mano i paradossi dell’agro-industria combinata con la cosiddetta globalizzazione: peperoni che valicano confini e attraversano monti in cambio di tulipani; prodotti simbolo di due territori coltivati a piú di mille chilometri di distanza l’uno dall’altro, a stravolgere due consuetudini agricole che li hanno resi tipici e, evidentemente, ben inseriti negli ecosistemi originali; una varietà di peperoni meravigliosa in via di estinzione; una ricetta tradizionale completamente snaturata; chissà quanto inquinamento da fertilizzanti e pesticidi, e soprattutto da emissioni di gas di scarico nell’atmosfera da parte di Tir e altri mezzi di trasporto circolanti per l’Europa.
Per me quel giorno fu la data ufficiale di inizio dell’ecogastronomia: la materia prima dev’essere coltivata e prodotta in maniera sostenibile, la biodiversità e le tradizioni alimentari e produttive locali vanno salvaguardate a tutti i costi.
Diario 2. Tehuacán.
Nell’estate del 2001 un viaggio mi portò prima a San Francisco, dove si tenne il I congresso nazionale di Slow Food Usa, e poi in Messico, una terra e una cultura cui sono molto legato, dove non mi recavo da tempo. Laggiú risiedetti per un po’ nel Distretto Federale, l’immensa Città del Messico, dove potei constatare lo stato di estrema miseria in cui vivono milioni di persone, fuggite dalle campagne dopo aver venduto la poca terra che possedevano e finite a intasare i sobborghi della capitale in cerca di chissà quale fortuna. La piccola agricoltura familiare di sussistenza non rende piú: i vicini Stati Uniti d’America creano illusioni con il luccichio dei loro prodotti e fanno nascere nuovi bisogni, ma si registra soprattutto l’invasività dei metodi dell’agricoltura industriale, che riduce la manodopera, rende difficile restare fuori da un circolo vizioso (fatto di commercializzazione di sementi, fertilizzanti e pesticidi: tutti prodotti ‘combinati’ tra loro) imposto dalle multinazionali e impoverisce di saperi tradizionali una cultura agricola formatasi in millenni di storia.
In Messico, dove le civiltà precolombiane hanno domesticato il mais e tanti altri prodotti oggi alla base della dieta di milioni di persone nel mondo, la biodiversità è ancora da record. Per restare al solo mais, delle piú di mille varietà autoctone formatesi nei secoli in perfetta armonia con i diversi ecosistemi messicani mi è stato raccontato che quasi l’80 per cento è stato brevettato negli anni da multinazionali americane alla ricerca di nuovi ibridi.
Oggi queste varietà autoctone sono state sostituite gradualmente proprio dagli ibridi americani, che necessitano di un maggiore quantitativo d’acqua (il problema delle risorse idriche in molte aree del Messico è drammatico) e sono anche molto meno validi dal punto di vista nutrizionale, nonché del gusto. Le tortillas a base di mais ammollato in acqua con un po’ di calce (la presenza di tanto calcio in un alimento cosí diffuso, ha fatto sí che i problemi odontoiatrici in Messico rimanessero pressoché sconosciuti fino a cinquant’anni fa) erano – e in parte restano – un prodotto casalingo, cucinato con abilità dalle donne e ricco di gusti diversi a seconda delle varietà di mais impiegate. Una ricchezza gastronomica da non sottovalutare, che insieme all’infinita diversità delle varie cucine tradizionali degli indios, sempre basate sui prodotti autoctoni, configura la gastronomia messicana come una delle piú complesse al mondo2.
La diffusione delle colture intensive di mais ha minacciato anche altre specie vegetali, ad esempio l’amaranto. Una varietà storica, alla base della dieta degli Aztechi insieme a fagioli e mais, che venne bandita già dai primi colonizzatori perché associata in qualche modo ai sacrifici umani che queste civiltà svolgevano in modo rituale. L’amaranto è diventato rarissimo, progressivamente dimenticato dalle colture agricole locali: peccato che non soltanto sia una pianta che ha bisogno di pochissima acqua per compiere il suo ciclo produttivo, ma che sia anche in grado di integrare in modo ideale la dieta povera dei contadini3.
Quell’estate mi recai dunque a Tehuacán, nello Stato di Puebla, per conoscere un progetto eccellente – tanto da meritarsi il premio Slow Food in difesa della biodiversità del 2003 – che mira alla reintroduzione dell’amaranto in una zona tra le piú povere del Messico, dove avanza inesorabile la desertificazione. Il progetto Quali, ideato e condotto da Raúl Hernández Garciadiego, è tra l’altro combinato con un disegno di rigenerazione delle risorse idriche, che trovo geniale e che riprende pochi, saggi accorgimenti degli antichi abitanti di queste terre.
Visitai una minuscola fattoria a conduzione familiare, per vedere in concreto un piccolo appezzamento di amaranto e per sentire dalla viva voce dei contadini che cosa pensassero del progetto. Ero accompagnato dai responsabili di Quali, da alcuni miei collaboratori e da Alicia De Angeli, nota chef di Città del Messico e grande studiosa di cucine indie messicane, che poi sa riproporre con maestria nel suo ristorante.
La povertà della famiglia che visitammo era evidente, ma molto dignitosa, ed i suoi membri esprimevano soddisfazione per aver trovato una pianta, l’amaranto, che cresceva meglio e consentiva di guadagnare qualcosa in piú rispetto al mais. La casa era essenziale, alcuni bambini scorrazzavano nella piccola aia punteggiata da oggetti fuori uso, da resti di bottiglie di Coca-Cola o da involucri vuoti di Pan Bimbo4.
Il campicello di amaranto era molto vicino all’abitazione e mentre tornavamo verso casa dopo aver visto quelle piante variopinte, colsi un’interessante conversazione tra Alicia De Angeli e la moglie del contadino che faceva gli onori di casa. Entrambe si soffermarono lungo il ciglio del brevissimo sentiero che stavamo percorrendo. C’erano sterpaglie lungo tutta la sua lunghezza: a dire il vero la casa era completamente circondata di sterpaglie. L’interesse delle due donne (entrambe cuoche, ma molto diverse tra di loro, un bel contrasto visivo vederle cosí insieme, l’una bianca, di radici europee, appartenente all’élite benestante del Distretto Federale; l’altra indigena, semplice, dalla postura segnata da evidenti e continue fatiche) era concentrato su una di queste piante spontanee. Alicia De Angeli: «Quest’erba è magnifica! La conosce, vero?» «No, perché?» – rispose la padrona di casa. «È un’ottima base per caldos5, molto nutriente e saporita. Le ricette che ho ritrovato nelle mie ricerche provengono proprio da questa zona, sono tipiche della vostra etnia». La perplessità della contadina, una donna sulla quarantina, rimase timidamente stampata sulla sua faccia, e chiese delucidazioni alla chef bianca su come preparare zuppe a partire dalla pianta in questione. Meticolosamente, Alicia De Angeli le spiegò la ricetta.
Visitammo la cucina di casa: l’essenzialità dell’attrezzatura e delle poche cose che avevano in dispensa raccontavano da sole la difficoltà di mettere ogni giorno qualcosa nel piatto per queste persone. Intorno alla casa crescevano erbe spontanee che per secoli i loro avi avevano imparato a utilizzare per nutrirsi e curarsi, mentre loro oggi ignoravano del tutto come impiegarle e la stessa possibilità di consumarle. La tabula rasa dell’industrializzazione agricola, della modernizzazione, ha compiuto anche qui il suo corso: poche varietà coltivabili dei prodotti piú diffusi, poco redditizie in questo ambiente sempre piú arido ed ecco che la popolazione locale in un paio di generazioni ha perduto tutti i saperi tradizionali che consentivano la sussistenza grazie ai frutti spontanei della natura. Una conoscenza gastronomica semplice, un sapere antico, una ricetta, era sparita dalla cultura locale e contribuiva a rendere ancor piú difficile la vita da quelle parti, dove la tentazione di vendere il proprio campicello e trasferirsi a Città del Messico o di chiedere un posto nelle vicine maquilladoras, dove confezionare jeans per le marche americane, è piú forte che in ogni altra zona del paese.
A Tehuacán ormai si stava facendo sera: proprio in quel momento, quando raggiungemmo l’aia, il camion che distribuisce casa per casa Pan Bimbo, il pane industriale in cassetta che sta sostituendo le tortillas nella dieta dei messicani piú poveri, si fermò all’inizio della via, sotto un enorme cartello che faceva pubblicità alla Coca-Cola, la compagnia americana che, ironia della sorte, possiede la maggiore fonte di acqua minerale in bottiglia del Messico, la Tehuacán, per l’appunto. Ancora oggi Tehuacán è sinonimo di acqua imbottigliata in tutto il Messico, in molte zone del paese con quel nome la si ordina al bar. Lo stabilimento che la confeziona si stagliava nitido a pochi chilometri dalla casa dei nostri amici, in questo lembo di terra tra i piú assetati e aridi del Centroamerica.
Diario 3. Laguiole.
Nella tarda primavera del 2001 un viaggio di lavoro mi condusse in Francia: Lione e Laguiole. Un paio di meeting con i responsabili locali di Slow Food France nel capoluogo, e una puntata fino in Aubrac, zona a sud del Massiccio Centrale, confinante con la piú nota Alvernia. Laggiú, nella cittadina principale del territorio, Laguiole, dovevo incontrare André Valadier, presidente della cooperativa Jeune Montagne, produttrice del formaggio Laguiole, una delle tante denominazioni di origine protetta francesi6 . Va detto che Laguiole non indica soltanto una cittadina e un formaggio, ma è forse piú noto per dare il nome a un tipo di coltello tradizionale, una piccola forma d’arte, ritenuto ‘il coltello’ per eccellenza da tutti i gourmet francesi.
Valadier è un tipo molto carismatico, capofila dell’associazione che riunisce i produttori di formaggi Dop francesi, e volli incontrarlo per contrattare la loro partecipazione a Cheese, la manifestazione internazionale sulle «forme del latte», che Slow Food organizza ogni due anni a Bra, in settembre.
C’era anche la scusa di cenare e soggiornare in uno dei relais piú suggestivi e rilassanti di Francia, da Michel Bras, chef a tre stelle che fa base proprio a Laguiole. È buon amico di Valadier e grandissimo interprete della cucina di territorio con la biodiversità locale: utilizza oltre trecento varietà vegetali per le sue ricette, dalle piú comuni alle piú rare, da quelle coltivate a quelle che crescono spontaneamente tra gli immensi pascoli e i boschi dell’affascinante altipiano dell’Aubrac.
Tra un veloce incontro al pomeriggio, nella sede della Jeune Montagne, e una fantastica cena chez Michel Bras, Valadier mi raccontò la storia del Laguiole (il formaggio) e di queste lande che per motivi geomorfologici sono piuttosto isolate dal resto della Francia.
«Fino alla Seconda guerra mondiale – mi disse Valadier, – qui producevamo essenzialmente per nutrirci. In seguito abbiamo incominciato a lavorare per produrre il piú possibile, finché oggi ci ritroviamo a dover produrre per distruggere».
A partire dagli anni ’60, esattamente come in quasi tutte le regioni montane d’Europa, l’Aubrac visse una profonda crisi sociale e produttiva. Anzitutto l’emigrazione: i giovani rifiutavano le severe condizioni che imponeva la vita contadina e se ne andavano in città, interrompendo la cura dei pascoli, l’allevamento della razza bovina autoctona, la Fleur d’Aubrac (o Rouge d’Aubrac), e la produzione di formaggio. I pochi che rimasero, tra cui Valadier, furono convinti da esperti zootecnici a passare dalle vacche autoctone alle Holstein, le famose mucche bianche e nere pezzate, che proprio sul finire degli anni ’70 invasero il mercato mondiale dell’allevamento da latte. Sono le piú produttive: se ne stanno buone buone, sempre chiuse in stalla, ‘pompate’ con un’alimentazione studiata apposta per spremerle fino all’ultima goccia. Quando giungono a ‘fine carriera’ vengono ingrassate il piú velocemente possibile – in America utilizzano ormoni, in Europa fino a poco tempo fa le farine animali che hanno causato la ‘mucca pazza’ – e mandate al macello. Visto che non dànno carni eccelse a causa della vita che hanno fatto, è preferibile utilizzarle per produrre hamburger o altri prodotti industriali7. Ma, effettivamente, a prima vista un vantaggio ce l’hanno: producono quasi il doppio di litri di latte al giorno rispetto alle vacche ‘normali’.
Ai contadini dell’Aubrac non sembrava vero quando mostrarono loro tali cifre produttive: in pochi anni le Holstein soppian...