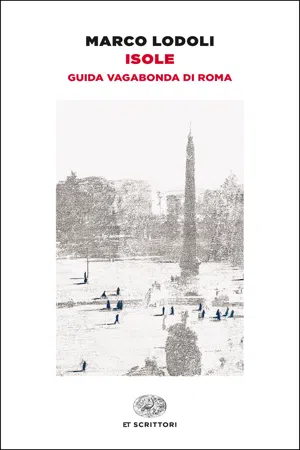![]()
Scantonare, ecco cosa ci piace fare: fuggire via dalla pazza folla e imboccare un vicolo a caso, gettare l’occhio in un cortile, frugare tra le pietre della città alla ricerca di un’isola nascosta.
Oggi è domenica e tanta gente si travasa avanti e indietro tra Campo de’ Fiori e piazza Farnese, spazi adiacenti che raccontano bene l’anima doppia della nostra città, popolare e patrizia, sprezzante e formale, chiassosa e reticente. I tavolini dei caffè traboccano di persone che sfogliano quotidiani e assorbono con indifferenza le ultime notizie e il calduccio del sole di novembre. Ma forse qualcuno ha ancora voglia di scantonare nell’ombra per dieci minuti. E allora potrebbe facilmente raggiungere San Girolamo della Carità, una chiesa all’inizio di via Monserrato, e scoprire quella che è l’opera meno nota di Francesco Borromini. Di sicuro tutti i romani conoscono le linee ardite di San Carlino e Santa Agnese, almeno una volta hanno alzato uno sguardo stupito verso il campanile di Sant’Andrea delle Fratte e verso il tortiglione di Sant’Ivo alla Sapienza: ma la prima cappella a destra di San Girolamo non è meno emozionante. Per i defunti della famiglia Spada, Borromini ha immaginato uno straordinario negozietto di stoffe eterne: un campionario infinito di marmi policromi che fanno pensare a un aldilà gestito da un tappezziere allegro, a un oltremondo di sete e tappeti primaverili sui quali rigirarsi e far capriole senza pesi addosso. La morte vista da qui non è piú una porta angosciosa da superare pregando e tremando, ma una tenda leggera e colorata oltre la quale sbirciare la nuova vita che verrà. E davanti alla cappella c’è la piú bizzarra balaustra che si sia mai vista: niente austere colonnine, nessun gelido pianale su cui poggiare i gomiti implorando il perdono per i mille peccati, ma due angeli simpatici – evidentemente i bravi commessi del negozio – che distendono fra loro lo scampolo di una delicata stoffa marmorea a righe rosse, un drappo che sembra il sontuoso nastro d’arrivo di un’esistenza fortunata. Se Dio ci misurerà con questo metro, in cielo o all’inferno saremo comunque molto eleganti.
Ogni tanto cerco di riconoscere un’isola nel grande mare della città: e possono essere quadri o alberi, libri o angoli in penombra, statue o fontanelle, luoghi che quasi si nascondono per non essere cancellati, come quei gatti bellissimi che scopriamo accoccolati sotto il parafango di un’auto in sosta e che ci studiano con i muscoli tesi e gli occhi pieni di apprensione, perché hanno visto tanti compagni travolti dalla furia delle macchine. Se per carezzarli ci avviciniamo in modo brusco, loro si ritraggono e non si fanno piú vedere. Ma in fondo il valore delle cose risiede soprattutto nel nostro modo di osservarle: ogni gatto può essere raro e prezioso come una tigre del Bengala, e anche il luogo apparentemente piú banale può meritare una fotografia e una cornice, proprio come un tempio azteco o una spiaggia lontana.
Pensavo a tutto questo mentre stavo seduto in macchina sulla collinetta di via Olina, a Torre Maura. Avevo un’ora di pausa e niente da fare, se non cercare di capire ciò che avevo davanti agli occhi: uno spiazzo desolato e case venute su senza pretese, mattoni a vista e parabole in bilico sui tetti. Al primo piano una donna cinese puliva con cura i vetri delle sue finestre, mentre sul terrazzino la lavatrice ruotava panni colorati. In un cortiletto di cemento giocavano bambini piccolissimi, bianchi, neri, gialli, anche loro si rincorrevano e giravano allegri come i panni nella lavatrice. Poi sono passate tre giovani nigeriane con i volti bassi: nelle buste di plastica tenevano i vestiti striminziti che avrebbero indossato piú tardi, negli stradoni dove andavano a prostituirsi. Su un muro laterale c’era scritto: «Insieme a te è stato un hanno d’amore indimenticabile», scritto proprio cosí, con l’acca. E poi mi è scivolata davanti una Ritmo celeste, mezza scassata, guidata a passo d’uomo da uno zingaro che rideva a crepapelle: in equilibrio sul cofano c’era un gattone spelacchiato, sembrava il marchio di quella macchina, di quella vita. E intanto la cinesina seguitava a lavare i vetri, a renderli sempre piú limpidi, e pareva volesse dirmi: fai anche tu lo stesso, pulisci il tuo sguardo.
A Roma le chiese barocche ci rovesciano nelle pupille cieli grondanti di cherubini e santi, firmamenti sovraffollati di creature aggrappate alle nuvole, stormi d’immagini pensate per sbalordire e raccontare che la vita è un teatro mirabolante dove tutto si tiene in equilibrio per imperscrutabile volontà divina. Non c’è da capire, solo da rimanere a bocca aperta davanti al fasto enigmatico della creazione. Però noi, figli della modernità e del disincanto, difficilmente ci lasciamo sorprendere, guardiamo quei cieli con l’occhio cisposo di chi crede di conoscere tutto e di poter svelare ogni gioco di prestigio.
C’è un’isola romana che contiene una meraviglia perenne: si tratta di arrivare a quella che in città è da sempre chiamata la Chiesa Nuova, lungo corso Vittorio Emanuele, ma il cui vero nome è Santa Maria in Vallicella. La piazza antistante è stata da poco risistemata, tra il codazzo delle solite polemiche, ma stavolta noi non ci badiamo: tiriamo dritti ed entriamo nella penombra secentesca della navata centrale. Sul fondo, dietro l’altare maggiore, appare una grande tela di Pieter Paul Rubens. Probabilmente non è il capolavoro del pittore fiammingo, che anche a Roma ha dipinto opere piú importanti, almeno dal punto di vista della storia dell’arte. Ma per noi che andiamo in cerca di uno stupore perduto, questo dipinto è una vertigine. Il grande quadro contiene un quadro piú piccolo: una madonna con bambino incorniciata d’oro e sorretta in volo da una frotta di angioletti. Altri angeli ammirano da sotto l’ascensione di quella miracolosa icona. Ma non è finita qui: ogni mattina alla stessa ora quell’icona viene rialzata, come una finestrina sulle cartelle della tombola, e dietro appare una piú antica madonna con bambino, un’immagine sacra attorno alla quale tutta la chiesa è stata edificata. Dunque un quadro che contiene un quadro che contiene un quadro. È come l’accenno a una numerazione che tende all’infinito, un sasso miracoloso che rimbalzando sull’acqua dei secoli porta il mistero della maternità fino a noi, minuscole pozzanghere, batte nei nostri occhi attoniti e va oltre.
Quanta fatica costa agli uomini costruire un muro, una casa, e opere ancora piú imponenti, immense. Da mesi, quasi da anni, osservo le cinque poderose gru che aiutano gli operai a innalzare il complesso del nuovo Auditorium, nello spazio dove un tempo i transessuali vendevano le loro grazie. Sembra un lavoro che non finirà mai, un cantiere perenne di polvere e carriole, un viavai di camion e materiali, ed è difficile immaginare che un giorno quel disordine diventerà un armonioso insieme di cupole e di sale dove i violini intoneranno la musica piú sublime. Visti dalle rampe del viadotto di corso Francia gli operai paiono formiche alle prese con un compito tremendamente piú grande di loro: eppure ce la faranno, perché è nell’essenza della volontà umana affrontare sfide spropositate e vincerle.
Ma l’isola di oggi non è l’Auditorium, su cui tanto già è stato detto: è un’altra nobile e immane fatica, un’altra meraviglia. Chi imbocca il viadotto arrivando da viale Tiziano e da lassú ammira il fervore del cantiere, forse non si è mai accorto di cosa cresce su quel braccio di strada, appena oltre il guardrail. A volte ci stupiamo di un ciuffo d’erba spuntato in una crepa dell’asfalto, e ci domandiamo dove abbia preso la forza per affacciarsi a quell’esistenza impossibile, quanta sconsiderata voglia di vivere l’abbia spinto a pretendere un po’ di cielo e qualche goccia di pioggia. Ma su quella curva del viadotto, giorno dopo giorno ho visto alzarsi un albero, un signor albero. Sotto di sé ha solo uno zoccolo di cemento durissimo, attorno ai suoi rami gagliardi il fumo delle macchine e il frastuono del traffico: nessuna delle implacabili leggi della natura gli permetterebbe di farcela, eppure è sempre piú grande e piú bello, e gli uccelli si posano tra le sue foglie. Ogni volta che si passa di lí bisognerebbe inchinarsi di fronte a quel mistero gaudioso, portargli rispetto. Non so neanche che specie di albero sia, è puro coraggio vegetale, il segno di una necessità che dimentica la fatica. Dall’alto della sua naturale maestà, quell’albero protegge il cantiere degli uomini.
Com’è diventato complicato incontrare gli amici! La città pare un campo di battaglia impossibile da traversare, un blocco di lamiere frementi e di malumore che invita a rimanere fermi là dove si sta, nel proprio quartiere, nel proprio isolato, nel proprio buco.
Se si parte per un appuntamento, subito ci si ritrova fuori tempo massimo, fusi nella colata di macchine che si solidifica attorno, persino pentiti di quell’idea balzana di ritrovarsi in un bar con un amico perso di vista da tempo. E altro tempo passerà, e forse la colpa non è solo di quel nodo di metallo e smog che soffoca, è la vita stessa che c’impedisce di fare quattro chiacchiere in santa pace con una persona cara: ognuno di noi ha mille cose da fare e l’appuntamento slitta, rimandato alla settimana successiva, o al mese dopo, o all’anno che verrà – sarà per quando avremo un po’ di tempo da dedicare a noi stessi. Si finisce per perdersi definitivamente o per incontrarsi a caso, in una via del centro o a una festa, con l’imbarazzo di non essere stati capaci di volerlo davvero. Sono incontri che preludono alla separazione definitiva.
Cosí l’isola di questa mattina è destinata all’Appuntamento Infallibile, alla curva dove da millenni – inevitabilmente, amorosamente – si accoppiano l’Aniene e il Tevere. È un luogo bello e nascosto, perfetto per un incontro clandestino. Bisogna lasciarsi alle spalle ponte Milvio, percorrere viale di Tor di Quinto fin oltre il cavalcavia dell’Olimpica e subito dopo imboccare una stradina sulla destra. C’è da passare accanto a un campo di nomadi e a dieci campi sportivi, per raggiungere un circolo di tennis che si chiama Le Mirage. Entriamo discretamente e puntiamo il ristorantino che s’affaccia sul fiume: la ricerca non è finita, si deve superare la vetrata, un praticello curato e sporgersi dal parapetto di legno. Da lí si vedono i due corsi mescolare le loro acque in un’intesa, oggi come sempre, secondo dopo secondo, gonfi o mezzi asciutti, forse intorbiditi e schiumosi come noi, ma piú di noi fedeli nel rispettare un impegno. E davanti a quell’incontro beviamoci un caffè, magari con un vecchio amico, cercando le parole.
Gli abitanti di molte zone di Roma di certo hanno buonissime ragioni per detestare gli stormi insediati sugli alberi delle loro strade. Capita di vedere macchine parcheggiate completamente istoriate dagli escrementi degli uccelli, e immagino che certe tintorie si siano arricchite a forza di ripulire giacche e cappotti bersagliati. Punteggiato dal guano, l’asfalto presto diventa una pista da circo dove tanti involontari clown capitombolano rischiando fratture e zuccate. Dunque non si può biasimare l’impegno con cui cittadini e autorità tentano di opporsi all’invasione dei pennuti, che in città trovano briciole a milioni e il conforto di caldi termosifoni e non vogliono tornare a patire in campagna.
Però è bello, certe mattine, dimenticare doveri e problemi e fermarsi ad ammirare quelle isole volanti in mezzo all’azzurro e alle nuvole del nostro cielo. Sembrano uno scherzo dell’aria, opere lievi e perfette con cui per un poco i volatili ci ripagano di ogni pesantezza terrena. È come guardare le onde o il fuoco, un teatro che non stanca mai: le linee si aprono a ventaglio, si richiudono, da un lato quell’ombra celeste s’avvalla, dall’altro s’impenna, e sono gorghi e velature, capriole e riccioli, e neanche per un attimo quell’immagine resta ferma e uguale. Sembra di poggiare l’occhio sul caleidoscopio che c’incantava da bambini: è una metamorfosi continua, qualcosa che eternamente si smembra e si ricompone seguendo un ordine armonioso.
Quello che forse sanno in pochi, e che mi è stato garantito da un esperto del fenomeno, è che tali incantevoli evoluzioni non nascono dal capriccio o dalla giocosità degli uccelli. Se riuscissimo a osservare piú da vicino, vedremmo nei pressi di quella giostra aerea il punto feroce di un falco pellegrino. Anche lui è sceso in città dalle colline, e non cerca un tocco di pane ma carne viva. Da solo si getta a caccia di qualche uccelletto, e allora gli stormi si difendono girando e rigirando nel cielo, ammassandosi e spandendosi secondo gli attacchi del rapace. Ogni bellezza, dunque, ha il dolore accanto, ogni opera d’arte è sempre una lotta contro la morte.
Dopo il fragore del capodanno, dopo le infinite rullate su un’altra pagina del calendario da girare, dopo i botti sfondatimpani, i concertoni in piazza e i messaggi alla nazione e al mondo intero, andiamo a cercare l’isola del silenzio, un’isola di pietra e di ovatta che da secoli resiste alla marea delle chiacchiere. È la chiesa dei Ss. Quattro Coronati, nella via omonima, per non sprecare altre parole. Nel sudicio prato davanti al complesso monastico gira una povera pazza che vive in un tugurio di cartoni: a volte si mostra nuda, anche d’inverno, ed è come se dichiarasse nel suo corpo tutta la pena del mondo. Oltre quella pena, oltre quella porta tremenda, si aprono due taciti cortili. Nel primo fino a pochi anni fa c’era un istituto per sordomute; nel secondo c’è la portineria delle suore agostiniane, suore di clausura. Un tempo pensavo che la clausura fosse un’ingiustificabile ritirata dalla vita, che solo la violenza e l’ignoranza potessero costringere delle giovani donne a rinunciare a tutto per niente. Ora capisco che il compito di queste monache è prezioso: è un’energia che cresce e non si sciupa, una cisterna d’acqua pura dove riflettere la propria agitata immagine e placarla. Quando mi sento particolarmente confuso, e cento mani mi tirano e mi spingono senza motivo e – come dice sant’Agostino – «l’anima si moltiplica in fantasmi senza numero», lascio ogni cosa e vado ad ascoltare le suore che nell’abside della chiesa cantano a volte solo per me e, sicuramente, molto spesso per nessuno. Quell’ascolto è piú efficace di qualsiasi intruglio farmaceutico, è una pace attenta e distaccata, un’immersione nel fosco dei propri pensieri, che a poco a poco si sciolgono e diventano cosí chiari da sembrare trasparenti, leggeri, spesso inutili. Ogni giorno le suore cantano l’ora terza, la sesta, la nona e i vespri, non è difficile ascoltarle per chi passa di là. Dalla navata di sinistra si accede, poi, a un bellissimo chiostro del xiii secolo che aspetta il restauro o lo sgretolamento: tutto il giro del porticato sono poche decine di metri, un equatore minimo e silenzioso che avvolge e ricompone il chiasso del pianeta.
La notte dovrebbe essere il regno dell’indistinto, il tempo in cui si allentano le forme e i ruoli nei quali ci costringe la luce del giorno. Le tenebre dovrebbero permetterci di uscire per un poco da noi stessi e d’incontrare gli altri al di fuori da quella recita diurna dove ognuno ha la sua parte già scritta. Purtroppo anche quelle ore di confusa libertà sono state conquistate dalle corporazioni, e cosí accade di trovarsi malinconicamente stranieri in locali affollati solo da compiaciuti professionisti, o da sdruciti alternativi, o da festosi gay, o da aspiranti ballerini di tango, o da disoccupati cinematografari. Ogni gruppo ha i suoi ambienti da presidiare gelosamente, come i pinguini presidiano i ghiacci e le api l’alveare. Ma per fortuna esistono ancora porti franchi dove il pinguino e l’ape possono bere gomito a gomito. Per esempio il bar Castellino di piazza Venezia, eternamente aperto, ma che soprattutto di notte, verso le quattro, le cinque, diventa vera terra di nessuno, isola del giorno dopo e del giorno prima, meridiano traversato dalle tante esistenze parallele che solcano la nostra città. Qui convergono i nottambuli e i solitari, quelli che ancora non vogliono andare a letto, quelli che già si sono alzati e quelli che a dormire non ci vanno mai: tabagisti alla ricerca disperata di sigarette, studenti a caccia dell’ultimo numero di «Zagor», transessuali e netturbini in pausa, vecchi con il cane incontinente, donne luccicanti e uomini in smoking reduci da qualche festa, vagabondi, polacchi ancora assetati, ragazze smaniose, giapponesi fuggiti dall’albergo, cuori spezzati e coppie d’amanti, anime perse. Il Castellino offre un effimero riparo a tutti, come strappato mantello di Vergine: e ciò che ognuno è, tanto o poco che sia, viene scambiato nelle piú incredibili conversazioni. Si comincia dicendo che fa un po’ freddo e si finisce sui massimi sistemi, si osano vertiginosi riassunti della propria vita e del destino del mondo, si ascoltano vicende inaudite, si fanno progetti comuni e ci si saluta per sempre. Nel cuore della notte, in quel bar, le mille paure del giorno diventano una pura confidenza.
Il piú celebre quadro di Arnold Böcklin, vissuto molti anni a Roma nella seconda metà dell’Ottocento, s’intitola L’isola dei morti ed è un’immagine perfettamente lugubre, una visione notturna e spettrale che mette i brividi addosso. Anche l’isola di questa giornata potrebbe portare lo stesso titolo: si tratta infatti di un cimitero, ma è il cimitero piú rasserenante che si possa desiderare, un giardino morbidamente sospeso in cima alla città, dove è bello passeggiare e pensare.
Se scendete per via della Camilluccia, inoltratevi per una straducola da niente che si chiama via dei Casali di Santo Spirito. Andate fino in fondo trascurando un parco giochi e uno spiazzo dove i cani vengono condotti a svagarsi: troverete un cancello imponente e una doppia iscrizione sulle colonne: «Cimetière militaire français – Campagne d’Italie 1943-1944». Oltre quel cancello si solleva un colle verdissimo di ulivi e cipressi, e nell’erba sempre fitta e rasata si allineano le tombe dei soldati francesi morti in Italia durante la Seconda guerra mondiale. Erano tutti ragazzi, cosí ci raccontano le date incise nelle pietre, finiti a vent’anni o poco piú sul Garigliano, sulla Chiusa di San Michele, sul monte Majo, ed è una sorpresa vedere quanti di loro siano sepolti sotto la mezzaluna islamica, a quanti Omar, Ahmed, Mohamèd sia toccato di venire a morire per la nostra libertà. Di loro ci ricordiamo solo per quel brutale episodio narrato nella Ciociara, quando madre e figlia vengono violentate da soldatacci marocchini. Ma queste tombe raccontano la dolorosa storia di centinaia di poveri fanti magrebini che hanno sofferto e sono rimasti qui per sempre. Le croci dei francesi di Francia e degli ufficiali stanno piú su, piú al sole, secondo una gerarchia tutta terrena e poco comprensibile.
Si cammina nel silenzio tra quei nomi stranieri, fino a giungere a un affaccio bellissimo sulla città. Dietro le spalle c’è la pena lontana della Storia, davanti agli occhi, laggiú, il movimento vivo di Roma, e anch’esso sembra lontano come i monti innevati all’orizzonte. In mezzo ci siamo noi, adesso, a raccogliere tutto questo.
Da secoli una barca di pietra sta ormeggiata davanti all’isola di questa domenica: è la celebre Navicella al Celio che, come per contagio, denomina anche la chiesa prospiciente. In realtà quella chiesa si chiama Santa Maria in Domnica e fu ricostruita nel 1513 dal cardinale Giovanni de’ Medici, poi divenuto papa con il nome di Leone X.
Appena dentro, alzando gli occhi, non troverete un cielo d’angeli equilibristi, nuvole barocche, arditi squarci d’azzurro e d’oro, quello spettacolo stupefacente che in tante chiese romane fu preparato per convincere i dubbiosi ad aver fede nel miracolo della Creazione, nel Dio che misericordiosamente tutto tiene in bilico. Vi apparirà un soffitto di legno chiaro che piú che ai grandi artisti rinascimentali vi farà pensare al falegname sotto casa, o alle tavole e ai trucioli di un antico Borzelli. Ma poi noterete quali straordinarie immagini sono scolpite nel legno, tanto semplici quanto enigmatiche, ognuna isolata in una cornice, come un grandioso mazzo di tarocchi incollato al soffitto. Sono per lo piú visualizzazioni degli appellativi latini della Vergine recitati nelle litanie che chiudono il rosario: Turris Eburnea, Refugium Peccatorum, Stella Matutina e altri, tutti scritti lungo le pareti, da leggere ad alta voce per quanto sono belli.
Ma la famiglia de’ Medici era impastata di cultura neoplatonica e pitagorica, e cosí sembra che tanti di quegli asciutti simboli – alberetti, fontane, templi e torri – rimandino anche alla sovranità immanente degli archetipi, a quelle visioni primarie e inquietanti che talvolta produciamo nei sogni. Domina su tutte l’immagine di una barca che porta una grande casa e procede in un mare agitato, dal quale affiorano mostri minacciosi. Probabilmente allude al prodigioso trasporto a Loreto della casa della Vergine, ma guardandola dal basso non si può non pensare al nostro umano viaggio, al nostro incerto modo di abitare la vita. Crediamo di essere a terra, difesi da solide mura, da rassicuranti abitudini, e siamo in mezzo alle onde, sempre assediati dal male e lontani da ogni porto. Eppure sopra la casa di legno vola una colomba, bianca di speranza.
Potremmo fiabescamente battezzare quella di oggi l’isola della seconda opportunità oppure l’isola dello scambio felice. Quante volte abbiamo vagheggiato un luogo magico dove restituire tre giorni grigi e bigi del nostro autunno in cambio di una giornata primaverile. Purtroppo la vita non concede permute, ognuno si tiene il presente che ha e il domani resta un pacco sigillato. Ma nell’universo parallelo dei libri, nel gassoso pianeta della lettura, questo baratto a volte è possibile.
In viale Mazzini, vicino alle Poste, da piú di cinquant’anni resiste la libreria del signor Offidani: dieci metri quadrati in cui transitano tutti i volumi del mondo, un mulino speciale al quale portare le parole che non ci piacciono per provare a ricavarne parole da amare. Offidani sa tutto dei libri, non c’è volume che non abbia sfogliato, di cui non conosca l’origine e il destino: che siano incunaboli pregiatissimi o gialli Mondadori, rari trattati giuridici o romanzetti estivi, atlanti o tomi filosofici, lui li valuta e li inzeppa nei traboccanti scaffali, secondo un ordine che noi chiameremmo confusione. Ci vorrebbe un computer, e qui non c’è – ma nel loro molle hard disk alcune menti umane hanno piú memoria di qualsiasi elefante cibernetico: sono biblioteche di Babele con scale interminabili per recuperare ogni parola. Offidani e il suo socio Gianni appartengono a questa razza, non dimenticano la posizione di un testo, di un foglio, di un nome. E cosí ogni tanto ci ritroviamo clienti di quell’antro cartaceo, in mano abbiamo tre romanzi grigi e bigi ricevuti in dono per Natale o per il compleanno: magari sono ancora avvolti nel cellophane, ma sentiamo ugualmente...