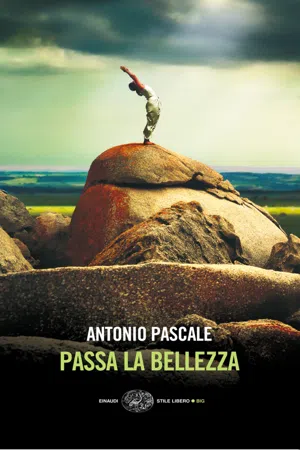![]()
Ora solare
![]()
Se passa una bellezza che va in fretta
Tra il 25 e il 26 ottobre, nelle dodici ore di ricovero all’idi avevo sentito la seguente frase: «E quello è lo stress!» almeno una decina di volte.
La prima era stata una ragazzina, otto anni, occhiali tondi con montatura argentata, molto fine, non c’è che dire, e capelli raccolti in una lunga treccia, tenuta, giusto a metà, da un fermaglio a forma di farfalla, di colore bianco sporco e con due occhi neri sulle ali. Onestamente, mi sembrava una farfalla abbastanza comune: una cavolaia. Non ispirava né l’idea del volo né spensieratezze tropicali. Il mesto colore del fermaglio, credo fosse stato scelto per attenuare quello delle sue braccia. Che non erano solo rosse, ma qualcosa di piú, una tonalità alta e fissa, un rosso infernale e perciò imperturbabile. Lei mi guardava mentre passeggiavo avanti e indietro per il padiglione, con il cellulare in mano. Avvisavo Piera di non partire, e poi pure Roberto Verniani di annullare la prossima missione, perché stavo cosí combinato: un attacco allergico, stavo dicendo, e questa ragazzina prima m’aveva strattonato un po’ la manica della camicia (bianca) poi, appunto, m’aveva detto: è tutta colpa dello stress!
Io non guardo mai fisso le persone ammalate, non faccio nemmeno battute sui difetti fisici, sia perché a sei anni mi sfottevano per la balbuzie, sia perché una volta, a dodici anni (non balbettavo piú), con un mio amichetto, Gilberto, stavamo a prendere in giro Romoletto, uno con la bocca tutta storta, quando mio padre si materializzò alle mie spalle e mi tirò un orecchio. Cosí forte che la bocca si fece tutta storta, piú storta di quello che sfottevamo, e per di piú, mentre mi storceva il lobo, mi disse:
– E se fossi tu cosí? Ehh? Che dici?
Cioè, la tipica domanda alla quale non c’è risposta, e infatti, che vuoi rispondere, pure perché mio padre cosí come era apparso cosí scomparve, e fatto sta che per lo spavento ripresi a balbettare per una ventina di minuti.
E però questa bambina l’avevo guardata, e come se l’avevo guardata. Stava piú rovinata di me. Solo per un attimo, i miei pensieri s’erano scissi. Da una parte ho pensato: povera bambina! E dall’altra, una frase tipo: morte tua vita mia. Nemmeno l’ho finita di pensare che mi sono voltato indietro, cosí, d’istinto, come a controllare se per caso, nei paraggi del padiglione, ci fosse mio padre pronto a tirarmi l’orecchio. Una cosa stupida da pensare, indubbiamente, e però mica tanto, perché ha vibrato il cellulare. Lo stringevo in mano e sono saltato. Era mio padre, appunto:
– Papà!
– Vincè, e perché gridi? Che è successo?
Le prime spiegazioni, la dermatite estesa al cinquantacinque per cento del corpo, gli eczemi ispessiti, le avevo fornite balbettando un po’, tanto che mio padre s’era preoccupato:
– Vincè ma che faccio, devo venire?
Ora, ventidue anni fa, il 19 dicembre dell’80, un mese dopo il terremoto, stavo facendo le gare di karate, la selezione andava a meraviglia, tanto che c’eravamo qualificati per le semifinali in due, io e Giampiero Gigliofiorito, che all’epoca era molto secco, poi sarebbe diventato una bomba. Siccome stavamo nella stessa palestra il maestro non poteva parteggiare per nessuno dei due, doveva essere neutrale, ovviamente. Quindi all’angolo, durante la pausa, eravamo soli, senza i consigli del maestro, il pubblico zitto, i compagni della palestra pure, anzi avevano proprio voltato la faccia, be’, insomma, quella era una sensazione nuova. Un senso di solitudine cosí non l’avevo mai provato. Solitudine è un eufemismo, di piú, ero solo dentro, per vincere dovevo contare solo su me stesso. Ma messo in un angolo, senza alcun sostegno, davvero si poteva vincere? Pensai pure che se avessi vinto, se fossi uscito dall’angolo, sarei diventato piú cattivo. In verità, l’aggettivo cattivo lo pensai allora, ma adesso, con il senno di poi, invece di cattivo avrei detto cinico.
– Vincè, ma che faccio, devo venire?
Insomma, avevo provato un déjà-vu, come se stessi ancora in quell’angolo. Potevo mai vincere da solo? E no, perché ventidue anni fa le semifinali le avevo perse. Per un colpo di Giampiero Gigliofiorito, a tradimento.
– Papà, niente, qualcosa mi ha fatto male, mo’ mi devo prendere un po’ di cortisone. E qua la bambina m’aveva ancora strattonato:
– Il dottore ha detto che è colpa dello stress!
E poi subito dopo mio padre, con una voce preoccupata:
– Vincè, tu ti devi stare un po’ calmo, quello sicuro è lo stress.
Dichiarazione che non potevo accettare. Voglio dire, un uomo che non ho mai visto calmo, nemmeno al funerale di mia madre. In piena attività dalla notte. Che è andato in pensione tardi e fino all’ultimo è voluto stare sulla strada, a intossicarsi con il mondo. Dico, un uomo che arrivava a casa, si toglieva il soprabito, posava la pistola, non parlava per nessuna ragione, tranne qualche rimprovero, si sedeva sulla poltrona, si faceva due cruciverba, senza essere calmo, nemmeno tentava di apparire rilassato, no, stava zitto e nervoso allo stesso tempo, emanava tensione, e noi a girare come satelliti elettrici, tutti appresso a lui. Dico, un uomo che non sopportava nessuno dei miei amici perché erano troppo lenti. Lenti, non era il termine che usava: debosciati! Adesso mio padre mi veniva a dire, con la voce preoccupata, che di sicuro nella malattia c’entrava lo stress. Proprio a me, che tutti dicono: ma come sei calmo.
Comunque, a mio padre avevo detto che mi dovevano fare questa dose pesante, endovena, di cortisone e poi l’indomani sarei tornato a casa e dunque non si doveva preoccupare: tutto sommato, era cosa di niente.
Intanto però ci pensavo allo stress, ma che stress, che significa? Cercavo una risposta quando vedo un ragazzo che esce da una stanza e va incontro al padre che gli chiede:
– Allora?
– Allora ha detto che è lo stress.
La bambina a quel punto m’aveva sorriso, come a dire: hai visto? Io però no, era il mio turno. Sono entrato in infermeria con la testa calata, mi sono steso sul lettino. L’infermiera, nel frattempo, stava parlando con una psicologa, Dorotea, si chiamava, oltre al camice bianco aperto aveva un cartellino di identificazione piú grande del suo viso: Dorotea, e sotto: psicologa. Ci teneva a distinguersi. Comunque l’infermiera le stava dicendo che questa settimana avevano avuto un carico di lavoro mai visto, soprattutto di bambini, tre, quattro, cinque anni, pazienti difficili, metti il cortisone, spennellali con il Rublosin, fai il bendaggio altrimenti si grattano e si riducono veramente male, prendili in braccio perché quando meno te l’aspetti si mettono a piangere.
Insomma, si sentiva sotto stress come non mai. Per questo mi sono detto, mo’ tocca a me, fammi stare calmo, almeno le rendo la vita piú facile. In fondo la democrazia è anche questo, fare un piccolo sforzo per semplificare la vita agli altri. E ho sorriso. Credo di aver fatto il sorriso dell’uomo forte, di quello che sa come controllare la situazione.
Lei prima ha detto:
– Vediamo cosa abbiamo qui.
E dopo:
– Ah! E che hai fatto?
Non ho ancora capito se il tu, in alcune situazioni, sia un gesto di comprensione o di potere. Comunque, s’era mossa di un passo per preparare la siringa. E mentre inciarmava con l’attrezzatura l’ho guardata: le braccia, il collo, le gambe, la pelle del viso, erano bianchissimi. Qui c’era qualcosa che non andava: io ero calmo e stavo cosí combinato, lei aveva avuto una settimana di lavoro stressante e aveva la pelle immacolata.
Le ho risposto ma con un leggero ritardo:
– Dicono che è lo stress.
Però la sua voce non l’ho piú sentita. Nel frattempo è arrivato un dermatologo. Il nome sul cartellino non si leggeva. A differenza della psicologa, il medico aveva un cartellino d’identificazione molto piccolo. Portava il camice chiuso, tutto abbottonato, non si vedeva nemmeno il collo della camicia, piú che un dottore sembrava un addetto alla sicurezza nucleare. Ma se la mia non era una malattia infettiva, allora perché questo stava cosí protetto?
– Cosa abbiamo qui?
E io ho risposto qualcosa, di nuovo sorridendo:
– Ah!
E ha dato indicazioni all’infermiera per la dose. Il suo sguardo era strano, non posso dire fosse disgustato, diciamo che andava verso il disgusto, come quando ti accorgi che qualcosa che hai in bocca ti sta per fare male. Era uno sguardo riservato solo a me, avevo proprio quest’impressione. Per esempio, il mio vicino di barella si stava lamentando perché la pelle gli bruciava, e con lui il dottore e pure l’infermiera erano stati piú comprensivi. Il fatto è che la pelle bruciava pure a me, ma stavo calmo. Almeno cercavo. Steso sul lettino, mentre l’infermiera mi spingeva il cortisone in vena (erano anni che non facevo una siringa, da quando ero piccolo, allora me le faceva Angelina) e il dermatologo mi spiegava la posologia futura (trenta giorni di cortisone in compresse da 25 mg, due al giorno per i primi dieci giorni, poi via via a scalare, antibiotico Bassado, a largo spettro, per sette giorni, e Ranidil compresse 150 mg, una volta al giorno per proteggere lo stomaco, crema Idilen a volontà, per lavarsi: niente acqua ma olio), avevo cominciato a intuire qualcosa: erano cattolici. Mi sono ricordato di Spizzuoco. Di quel suo particolare sguardo, pure lui leggermente disgustato, di come firmava la ricetta, come se fosse non una cura ma una sentenza, di quel modo di fare gli auguri quando uscivi dalla sua stanza, prima calcava l’accento sulla «i» finale, poi la trascinava, cosí il suono si perdeva in un sibilo inquietante. Non mi considerava ancora un peccatore, ma uno che pecca e non lo sa: la mia colpa era quella di non sapere qual era la mia colpa. In fondo, con un particolare tipo di cattolico è cosí: mostra sofferenza e lui ti aiuterà, resta lucido e dignitoso e sarai schernito.
Poi si è aperta la porta dell’infermeria e sono entrati cinque studenti. Ho capito subito che ero la cavia. Hanno fatto cerchio attorno al dermatologo. Ora, il problema è questo, quando mi comincio a fissare, tutte le cose che vedo o che faccio volente o nolente si intonano alla suddetta fissazione. Pensavo ai cattolici e questi studenti diventavano dei pretini, in processione dietro al vescovo. Due di loro mi guardavano con le mani giunte. E cosí il vescovo ha allungato la lampada sopra il mio corpo, ha spostato l’enorme lente di ingrandimento cosí che tutti potessero vedere in che condizione stavo, e quindi ha cominciato a descrivere la patologia, molto chiaramente: il probabile punto di partenza della lesione, la superficie cutanea interessata, l’ispessimento di alcuni punti, l’infezione subentrata in un secondo tempo. La patologia era chiara, la fisiologia per niente: cause sconosciute, stress, intolleranze alimentari, fattori genetici. Del resto i cattolici amano molto la patologia. Ecco, pensavo, in questa particolare dimensione della malattia, tra l’esterno (la pelle) e l’interno non c’è comunicazione, piú chiara è la manifestazione cutanea, piú difficile è risalire alla causa. Ma io sono una persona ragionevole, mi stavo fissando, dovevo capire. Cosí ho chiesto:
– Ma è possibile identificare la causa specifica?
– Lei deve fare i test allergici, siamo nel mare magnum delle possibilità.
Quando mi comincio a fissare, non solo faccio associazioni strane, ma le recupero lontano nella memoria. Sotto osservazione, ingrandito dalla lente e spiato da questi speciali voyeur che sono i praticanti di medicina, sdraiato sulla barella, mentre guardavo il soffitto, per forza di cose un soffitto bianco, con pezzi di intonaco qua e là crepati, leggermente staccati dalla base, come scaglie, mi sono ricordato di quando ho conosciuto Piera. 22 luglio 1997, sala da pranzo dell’albergo Il Sorriso, struttura moderna, duecentocinquanta stanze con tutti i comfort. Solo che il paese contava centoventi abitanti. Stavamo a Pietracupa, Molise, in missione con Verniani. Il quale era appena tornato dal giro e m’aveva detto:
– Capito niente? Centoventi abitanti, non ci sono nemmeno le scuole, però c’è la posta. Lo sai perché?
– Perché?
– Arrivano ogni giorno le rimesse degli emigrati, sai quante persone sono partite dal Molise in questo secolo?
– Piú di un milione.
– Bravo.
– Mi informo anche io, bello.
Infatti, avevo appena parlato con un signore fuori del bar, appunto, un emigrato da poco tornato. Uno convinto che l’aria di Pietracupa fosse la migliore di tutto il Molise. Migliore anche di quella di Salcito, un paese che, però, in linea d’aria stava a due chilometri da Pietracupa.
– Ma veramente dite?
Per questo non aveva voluto fare come tutti i suoi amici, che s’erano costruiti la casa a valle, lui aveva preso quella di famiglia e se la stava ristrutturando, appunto perché l’aria di Pietracupa era la migliore di tutto il Molise.
Ero rientrato in albergo respirando profondamente. Roberto, intanto, era salito in stanza, nemmeno voleva mangiare, si sentiva tutto intossicato, va bene, ci vediamo domani, e siccome io, invece, avevo fame, m’ero avviato nella sala da pranzo, dove ci si serviva a buffet. Tutto questo, sempre respirando profondamente, perché quando mi fisso faccio cosí. Pure peggio, a volte.
Ora, nel ristorante c’erano tre preti, in borghese, e una ragazza, che mi dava quasi le spalle, e al contrario di me, respirava lentamente, il seno si alzava e si abbassava con un ritmo lento e molto piacevole, mi ricordava un cavallo a dondolo. Il discorso girava attorno a madre Teresa di Calcutta, che tra l’altro era morta da poco. Quando ecco che lei aveva guardato nella mia direzione – io adesso stavo al suo fianco, al banco, a servirmi – e cosí avevo notato il suo bel viso, spigoloso al punto giusto, e questi capelli neri e lunghi, un ciuffo che finiva in mezzo al seno. Aveva guardato nella mia direzione e io nella sua, convinto che ce l’avesse con me, in realtà fissava la finestra, quella in fondo alla sala. Ho buttato lo sguardo, ma c’era solo un pioppo che adesso si stava muovendo al vento. È stato un attimo, dopo che lei era tornata in mezzo ai preti. Aveva detto:
– Francamente non sono d’accordo…
Approfittando della pausa di silenzio che l’affermazione aveva creato, m’ero seduto al tavolo di fianco al loro. Tutto contento della situazione imprevista.
– … una volta era il corpo del santo a essere martoriato, adesso per carità, è un aspetto del Cristianesimo poco convincente – Gesú era una persona allegra, se ne andava di festa in festa – però, allora, era il corpo del santo a essere esposto, lui in prima persona a soffrire. Nel caso di madre Teresa è il corpo dell’altro a essere esposto. Insomma, questa immagine non me la posso dimenticare: c’è questo povero che si lamenta, perché ha un tumore allo stomaco in fase terminale, e lei dice: è Gesú che ti sta baciando. E il povero risponde, giustamente: digli di smettere di baciarmi.
Il concetto che poi aveva argomentato (e che mi sarei sentito ripetere per gli anni a venire) riguardava il valore della sofferenza: avvicina o non avvicinava a Dio? (ma non solo a Dio, migliora o non migliora la nostra conoscenza delle cose?) Perché, diceva, in queste case della carità, le medicine scarseggiano, c’è molta sciatteria per le cure e molta voglia di mostrare la sofferenza.
– Ma questa sofferenza, ha davvero valore? Forse lo potrebbe avere se si facesse tutto ciò che è giusto per superarla, o no?
Ero rimasto ad ascoltarla con la forchetta in mano, lei aveva pure un’aria familiare. Un prete, quello che dei tre si stava piú innervosendo, aveva cosí risposto:
– Intanto c’è da dire che, scusami la franchezza, per pulire il sedere ai lebbrosi ci vuole un corpo particolare, devi superare molti vincoli fisici, tuoi, personali, e lo puoi fare se ti sei privato di tutte le barriere, se hai sperimentato tanta di quella sofferenza che immediatamente percepisci quella degli altri. Cioè, siamo sempre lí, la croce, no? Capisco che adesso è un’immagine quasi pop, però se mostri Gesú sulla croce in Africa, magari a una tribú che non sa nulla di te - ti parlo per esperienza personale – loro percepiscono immediatamente quell’immagine, Gesú soffre perché ha molto amato. Allo stesso modo madre Teresa è stata percepita in tutto il mondo, questo è un merito eccezionale, bisogna valutarlo per bene.
Ma la ragazz...