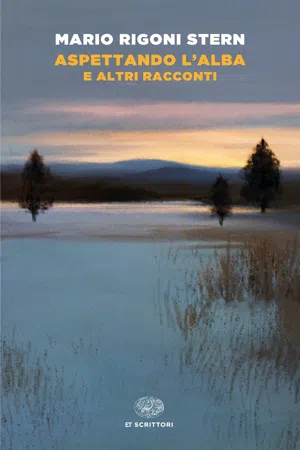![]() page 3 Parte prima
page 3 Parte prima![]()
Sulle nevi di gennaio
Si era appoggiato alla slitta con il braccio destro, quello sinistro lo teneva infilato davanti, dentro il cappotto. Quando una pallottola della raffica l’aveva colpito, aveva sentito solamente un colpo secco, come una sassata.
Dopo aveva avvertito un po’ di caldo lungo il fianco, ed era il sangue che colava. Infine piú niente, perché il freddo aveva saldato la ferita.
Erano le ginocchia, ora, che facevano fatica a sostenerlo, e poi i piedi erano attanagliati nella neve. Si lasciò andare e tenendosi con il braccio si fece trascinare. La slitta si fermò. L’alpino che conduceva il mulo per la briglia si girò e lo vide: – Via! Staccati! – gli gridò. – Il mio mulo non ce la fa piú.
Non rispose, non aveva forza per parlare, nemmeno per staccare il braccio dal bordo. Il conducente si avvicinò adirato e minaccioso. Vide che era un ufficiale, sulla manica aveva ancora i gradi: – Staccati dalla mia slitta, – gli ordinò. Ciglia e sopracciglia del tenente erano incrostate di neve ghiacciata, il passamontagna da sotto l’elmetto gli scendeva sul volto: – Sono stato ferito, – disse con fatica aprendo gli occhi.
Il conducente bestemmiò e si guardò attorno: una moltitudine di soldati sbandati, di muli, di slitte era ferma su un grande spazio bianco. Erano tutti in attesa che lí, dove si sentiva sparare, si riprendesse a camminare.
Guardò ancora quell’uomo appeso alla sua slitta e, maledicendo, slegò le funicelle che tenevano fermo il telo che copriva il carico. Sempre imprecando scaricò nella neve due casse piene di carte che un maresciallo di maggiorità gli aveva fatto caricare e nello spazio lasciato dalle casse sistemò il ferito e lo coprí. Ora, il tenente disteso su un po’ di paglia e sotto le coperte non sentiva piú freddo, nessun dolore. C’era una profonda quiete.
... saliti sull’Altipiano per le esercitazioni invernali, un giorno di gennaio, dopo una marcia lunga e faticosa, si erano acquartierati nella vecchia caserma. Finite le escursioni tra Vezzena e Marcesina per Portule, Cima XII, Ortigara e Fiara, ora gli allievi godevano di un periodo di relativo riposo e si addestravano sul Kaberlaba. Fu qui che la conobbe. Durante una discesa l’aveva vista cadere fuori dalla pista sollevando una nuvola di neve farinosa. Si era precipitato giú come un falchetto per aiutarla. Era proprio buffa: tutta cosí bianca, il viso imbronciato...
Fu lui a scusarsi per averle dato una mano a risollevarsi sugli sci: lei, come fu in piedi, senza dire grazie riprese la discesa indispettita e crucciata.
La rivide alla Casetta Rossa, dove con il plotone e un sergente erano entrati per bere un vin brulé. Lei si era avvicinata per dirgli: – Mi scusi, ero proprio arrabbiata per quella stupida caduta.
– Cosí tutta piena di neve mi sembrava un pupazzo, – aveva risposto lui. – Questa sera viene al ballo della Croce Bianca? Domani noi partiamo per Bassano.
Non credeva di rincontrarla, ma quando la festa era già avviata la vide comparire. Senza la tenuta da sci, ora, in quel vestito, appariva leggera, luminosa e sorridente.
Ballarono. C’erano ragazzi e ragazze arrivati per le gare studentesche, ufficiali e allievi ufficiali degli alpini, maestri di sci.
– Qui dentro c’è tanta confusione e fa anche troppo caldo. Davanti all’albergo ho visto delle slitte in sosta ed è una notte molto bella e serena. Perché non andiamo a fare una corsa con la slitta?
– Con questo freddo?
– Vada a mettersi qualcosa di lana. L’aspetto. O l’accompagno? Dove abita?
– Qui, in questo albergo. Mi aspetti nella hall.
Attese con la mantellina sul braccio e il cappello in mano. Lei giunse subito, vestita da neve; sorrideva imbarazzata e un poco anche confusa.
Le slitte erano sulla strada in attesa dei clienti, i contadini stavano insieme a parlottare e battevano i piedi. Si avvicinarono alla prima della fila, era dipinta di bianco con fiori alpestri azzurri e rossi sulle fiancate. Il cavallo, con una coperta sul dorso, stava mangiando la biada nella musetta.
– Volete fare un giro? – chiese il contadino.
Salirono sul sedile posteriore, con la schiena rivolta al guidatore. Si avvolsero insieme in una coperta, con un’altra si coprirono le gambe fino ai piedi. Il contadino sfilò la musetta dalla testa del cavallo dicendo: – Basta Baldo, finirai dopo quando ritorneremo –. Levò la coperta dalla groppa e salí al sedile di guida; si avvolse nel mantello, con la coperta del cavallo si coprí le ginocchia e infilò i piedi dentro il sacco del fieno: – Vai Baldo, – disse facendo leggermente schioccare la frusta. – Dove vogliono andare?
– Dove vuole, non abbiamo preferenze. Per i prati, dentro il bosco, – disse lui.
... andava la slitta nella notte che rifletteva le stelle nei cristalli di neve, lieve scivolava come su una nuvola nel cielo, e il campanello di bronzo sul collare del cavallo tintinnava a ogni passo.
– Vai Baldo! – disse il contadino toccandolo leggermente con la frusta. E il cavallo prese il trotto, dapprima leggero e poi via via piú veloce e disteso. Infilò una strada che s’inoltrava nel bosco.
La luna che stava sorgendo illuminava gli alberi sul dosso della montagna e la luce si diffondeva tra i rami carichi di neve...
Si alzò la tormenta. Un vento radente sollevava come sabbia del deserto la neve della steppa, e come degli spettri gli uomini silenziosi camminavano curvi contro quel vortice. Andarono cosí tutta la notte, molti cadevano e non si rialzavano, alcune slitte restavano ferme nella neve.
Venne un’alba livida, senza luce, e lontano, confuso nel bianco, apparve un villaggio. A lato della pista un ufficiale incitava chi aveva ancora forza ad andare avanti, perché non tutti potevano trovare posto in quelle isbe. Solo qualche chilometro, diceva, e troverete altri villaggi dove riposare al caldo.
... la slitta scivolava su grandi cristalli luminosi, e il cavallo Baldo ora galoppava sfiorando la neve. Ogni tanto scuoteva la testa come volesse far sentire piú squillante il campanello di bronzo.
Il corpo di lei si era abbandonato contro il suo, la testa nell’incavo della spalla, le braccia in un reciproco abbraccio. Il respiro era leggero e sembrava quasi il respiro di una piccola bambina.
– Dormi? – le chiese.
– No, – rispose sottovoce, – guardo le stelle e il bosco.
– Hai freddo?
– Oh no, qui sotto c’è un bel tepore.
Il conducente fece fermare il mulo nel centro del villaggio, vicino a una casa con il portico. Guidò la slitta dentro il cortile. Slegò il mulo e lo condusse sotto quel portico, dove c’era del fieno sparso; ne raccolse una bracciata e gliela depose davanti al muso. Domani mattina, pensò, ne caricherò un bel po’. Con le mani pulí dalla neve il telo che copriva la slitta e slegò le funicelle che lo tenevano fermo alla forza del vento della steppa. Scostò il telo e la coperta. Il volto aveva un’espressione di serena felicità: sorrideva e gli occhi socchiusi avevano una luce sconosciuta. Guardando bene quel viso gli parve di riconoscere l’allievo ufficiale che in una notte di gennaio, con una bella ragazza, aveva portato con la slitta in una corsa per i prati e dentro il bosco. Lo prese sotto le braccia, lo trascinò dietro la casa, scavò nella neve, adagiò il corpo e con le mani ricoperse quel viso sorridente e quegli occhi felici.
![]()
Un natale del 1945
Piú che la neve che doveva calpestare durante il giorno, era il freddo della notte che gli rendeva duro quel tempo.
Partiva quando il chiarore dell’alba compariva sulle rocce dell’alta montagna dal bel nome che gli stava di fronte: l’ondata del sole toccava poi via via tutte le montagne intorno. Restavano però sempre in ombra alcuni versanti, il fondovalle, e i boschi in basso dove il sole sarebbe arrivato solo a marzo. Lí la neve rimaneva sempre appesa alle rocce e agli alberi, dando una sensazione di freddo fossile.
Camminava su per l’erta fin dove il grande bosco confinava con i pascoli delle malghe piú alte, dove il debole sole di dicembre dolcemente lo riscaldava. Era questo il posto dove l’anno prima i tedeschi della «Todt» avevano fatto tagliare gli alberi piú alti e piú belli per rifare i ponti sul Po, che ogni volta venivano distrutti dai bombardamenti degli Alleati o dai partigiani. Ora erano rimasti i grossi ceppi ultracentenari, pesanti e compatti, abbarbicati alla montagna e cementati dal gelo.
Vi saliva portando sulle spalle la slitta leggera e solida, il cibo per un pasto, una borraccia d’acqua. Il badile, il piccone, le scuri e gli altri attrezzi li lasciava lassú ai piedi di un abete che aveva rami tanto fitti e larghi da formare una capanna sotto il livello della neve.
Un’ora e mezza di salita al mattino, mezz’ora di discesa nel pomeriggio con tre quintali di ceppi sulla slitta. Gli scarponi e le gambe sino alle ginocchia erano protetti con teli di sacco.
Quando arrivava in quell’ultimo bosco, con un ramo di citiso lungo e appuntito forava lo strato di neve per saggiare se sotto il rialzo c’era un ceppo oppure un sasso; con il badile spalava la neve per denudare il terreno e con il piccone scavava per liberare le radici; con le scuri le tagliava e, infine, con la leva di ferro rovesciava il ceppo. I ceppi troppo grandi, prima di sradicarli, li spaccava in quarti o in ottavi con i cunei e la mazza.
A volte faticava molto con poco risultato, altre volte con poca fatica riusciva anche a fare due carichi con la slitta sino in fondo alla valle, dove in primavera avrebbe potuto vendere mille quintali di legna, o forse piú, per le fornaci e le vetrerie. E con il ricavo pagare il debito e il viaggio per l’Australia.
Era ritornato in ottobre dopo aver fatto un lungo giro per l’Europa orientale. L’avevano preso i fascisti durante un rastrellamento nel settembre del ’44. Processato, l’avevano condannato a morte per «banditismo» , e la condanna era poi stata commutata nella deportazione a vita in Germania.
In qualche modo se l’era cavata, ma ritornato al suo paese troppe cose trovò cambiate nel giro di un anno; sua madre non c’era piú, e non se la sentiva di vivere in quella casa. Ma intanto vivere doveva. Decise allora di andare dal santolo Toni, che aveva bottega di alimentari.
– Santolo, – disse, – voi sapete come mi è andata; non ho che poche lire che mi hanno dato al distretto militare, ma ho tanta voglia di lavorare. Se mi fate credito in primavera pagherò tutto.
Ebbe lardo, farina da polenta, fagioli, formaggio tarato, orzo, pasta e conserva di pomodoro. Un po’ di patate le ottenne in carità da una famiglia della contrada; barattando due lepri prese con i lacci riuscí ad avere tre chili di sale.
Prima delle nevicate caricò tutto il suo avere sul carro di un amico che andava a sboscare, per conto del Comune, l’ultimo legname abbandonato dai tedeschi.
Nella vecchia osteria semidistrutta, sotto un tetto riparato alla meno peggio con delle travi bruciacchiate, in quell’autunno del 1945 trovavano ricovero boscaioli, bracconieri, cavallari, reduci allo sbando. Ma dopo le prime nevicate se ne andarono tutti per non restare bloccati un lungo inverno. Lui si ritrovò solo. Non gli dispiaceva: poteva parlare con le cose che gli stavano intorno, e lavorare come gli pareva, e pensare e meditare su quanto gli era capitato in quegli anni, da soldato in Albania, da partigiano sulle montagne, da condannato a morte, da deportato, da vagabondo quando il Lager era stato liberato dai soldati russi.
I giorni di sole con il freddo intenso, i giorni di neve uniformi e come sommersi fuori dal tempo, il suo fuoco, il silenzio. E la sua fatica e il sonno profondo sullo strame di paglia accanto al fuoco che si spegneva sulle pietre del focolare, dove, per secoli, avevano trovato compagnia i viandanti e i contrabbandieri. Non sapeva il trascorrere dei giorni; aveva sí, con il coltello, inciso una tacca sul ramo di un abete ogni mattina che risaliva il sentiero pestato nella neve come una trincea, ma non ricordava piú il giorno che era rimasto solo, e forse non sempre aveva inciso la tacca. Avrebbe potuto essere la fine di dicembre, o anche il principio dell’anno nuovo. Ma che importanza aveva? I viveri, a dosarli bene, sarebbero bastati ancora un paio di mesi; se poi riusciva a prendere con i lacci qualche lepre o un capriolo poteva arricchire la razione. – Magari un giorno, – disse al fuoco, – dopo una nevicata, invece di cavar ceppi vado a seguire le tracce.
Anche quella sera aveva ravvivato il fuoco scoprendo dalla cenere la bracia del mattino. E ora, dopo aver appeso alla catena il paiolo con l’acqua per fare la polenta, si era arrotolato la sigaretta di trinciato, l’unica che poteva permettersi e sempre in quel momento della giornata. Guardava le fiamme salire sul fondo nero della fuliggine depositata sulle pareti del camino, le faville che si rincorrevano, e si sentiva appagato dalla giornata trascorsa. Fuori il cielo si era abbassato, e lentamente aveva ricominciato a nevicare. Unico rumore, quello del fuoco e del suo respiro.
Sentí avvicinarsi un frusciare di sci, un respiro affaticato, poi lo sbattere dei legni per staccare la neve, chiamare il suo nome.
Riconobbe subito la voce ma non si scostò dal fuoco. Sentí battere con forza sulla porta e ancora ripetere il suo nome. Si alzò dalla panca, levò il paletto che teneva chiusa la porta, l’aperse e chiese: – Cosa vuoi?
– Oggi è Natale, – gli rispose l’uomo. – Ho saputo che sei qui. Posso entrare?
– Meglio di no.
– Ascoltami, almeno.
– Vieni avanti.
L’uomo si pulí dalla neve, si avvicinò al fuoco e disse: – Quando ti abbiamo preso e condannato non ho fatto che eseguire gli ordini. Era quello il mio dovere verso la patria. Non è stata colpa mia.
Non rispose, non fece nessun gesto. Guardava il fuoco ed era come rivivere tutto. Le donne e i ragazzi uccisi dai soldati tedeschi, i compagni morti di freddo sulle montagne dell’Albania, gli ebrei di Leopoli. Il Lager. Il Lager dov’era morto quel ragazzo di città che era stato preso e condannato assieme a lui: lo avevano spogliato e buttato nudo nella grande fossa oltre i reticolati, dove c’erano jugoslavi, greci, polacchi, russi, italiani. Era stato proprio l’anno prima, di questo tempo, perché assieme alla fame c’era anche tanto freddo. Forse era Natale, quel giorno di dicembre in cui morí il ragazzo.
Non ascoltava quello che gli diceva il suo maestro della scuola elementare, che aveva poi ritrovato in divisa della Brigata Nera. L’acqua nel paiolo stava per alzare il bollore; andò a prendere il sale e la farina.
– Oggi è la Natività del Signore, – riprese il maestro, – ho saputo che eri qui da solo e sono venuto a trovarti. Ti chiedo scusa per quello che ti ho fatto. Ho qui nello zaino un panettone e una bottiglia di spumante.
Non poteva perdonarlo, no. Non per quanto lo riguardava direttamente, ma per gli altri che non avevano nemmeno piú un fuoco da guardare. Si avvicinò alla porta e la spalancò. Là fuori era buio e la neve che mulinava dal cielo veniva a posarsi fin sulla soglia di pietra della vecchia osteria di confine. – Va’ via, – gli disse sottovoce.
![]()
Aspettando l’alba
Questa notte nevicava, poi la luna calante verso le cinque del mattino è comparsa tra le nubi. La mente vagava e vagava nei ricordi: nel 1926, in una notte come questa, ero... E ricordavo la vecchia casa di via Monte Ortigara, dove il focolare era sempre acceso. I ricordi venivano avanti di dieci anni in dieci anni, ma è su quell’inverno del 1944 che piú a lungo mi sono soffermato. Finché alla finestra non ho visto la luce dell’alba dentro un cielo lattiginoso sopra la montagna.
Come quelle albe nel Lager 1|B, nella Masuria, dove la malinconia e la privazione della libertà gravavano sul cuore. Solo un anno prima camminavo per l’Ucraina e la Bielorussia, ed era lontana l’Italia. Eravamo rimasti pochi compagni; certi giorni mi seguivano da villaggio a villaggio, altri giorni, ultimo della fila, li incitavo a camminare. Ora ero qui tra i reticolati a rodere la mia rabbia accumulata in quell’8 settembre 1943, e a consumare il cuore nella nostalgia. Attraverso le fessure della Aufnahmebaracke vedevo filtrare la luce, e sotto il pastrano cercavo di raccogliere un po’ di caldo dal saccone di trucioli.
Ero capitato qui chissà per quale caso: un sergente molto anziano che era stato richiamato dopo il 25 luglio, caduta del fascismo, si era rifiutato di prestare servizio alla «baracca dell’accoglienza» , aveva preferito uscire dal Lager e andare al lavoro con i gruppi di prigionieri. Il giorno dopo, quando eravamo tutti in fila per cinque nello spiazzo della conta, il Lagerfeldwebel Braum con un cenno mi fece uscire dalla fila, poi disse un numero e un alpino uscí anche lui. Ci ordinò di seguirlo e non capivo cosa volesse da noi.
Attraversammo tutto l’immenso Lager: i gruppi di baracche dov’eravamo stati rinchiusi noi della Tridentina con i moltissimi prigionieri russi, e quelle baracche, Lager dentro il Lager, dov’erano rigorosamente custoditi ufficiali superiori dell’Armata Rossa e da cui due di loro, cosí si diceva, erano riusciti a fuggire. Recinti alti di reticolati, dentro altri recinti, sentinelle nei passaggi dei settori, torrette con mitragliatrici e fari. Passammo le baracche del Kommandantur, le cucine, le baracche degli archivi dove ci avevano preso le impronte digitali, schedati e fotografati con il numero sul petto, le baracche del Lazarett e ancora baracche con prigionieri russi.
In fondo, in un angolo estremo, c’erano le baracche per la disinfestazione dai pidocchi, l’Aufnahmebaracke e la discarica dei rifiuti e delle latrine. Nel Lager 1|B eravamo decine di migliaia e su tutti tiranneggiava il Lagerfeldwebel Braum, sempre con la rivoltella in pugno e le sue brevi urla raspose.
Con un cenno alla sentinella fece aprire ancora un varco e c’impose di entrare nell’ultima baracca. Disse qualche parola e capimmo che il nostro compito, d’ora in avanti, sarebbe stato di accogliere nella Aufnahme i gruppi che dovevano andare allo spidocchiamento quando non erano in funzione le caldaie, prelevare le razioni per costoro finché non venivano avviati al loro destino e pulire le latrine e tutto il resto dopo il loro passaggio. – Verstanden?
– Sí, capito.
La baracca era divisa in quattro parti da pareti di tavole; in una di pochi metri quadrati eravamo noi due italiani, in un’altra uguale due prigionieri russi, tra noi e loro una latrina per accedere alla quale bisognava uscire all’aperto; infine il posto dove dovevano sostare gli spidocchiandi: era grande e squallido, in terra battuta il pavimento, nessun pancone, niente per riscaldare. Dovevano aspettare sdraiati per terra. Nient’altro. Fuori, una sentinella camminava avanti e indietro sulla neve e nell’angolo, oltre i reticolati, la torretta con la mitragliatrice, il nastro infilato e il tiratore dietro.
Nella piatta e uniforme e triste campagna innevata si alzava l’ottagonale mausoleo in mattoni rossi dov’era stato sepolto Paul von Beneckendorff und von Hindenburg, l’eroe di Tannenberg e dei laghi Masuri dove nel 1914 l’esercito dello zar Nicola subí la grande sconfitta. Nuvole nere di corvi veleggiavano attorno alla tetra torre di mattoni, e quando i prigionieri russi venivano a scaricare le carrette e le botti con le immondizie e le latrine del Lager, tutti i corvi, gracchiando, andavano a razzolarci dentro.
Dai sottocampi o dai distaccamenti dei prigionieri che lavoravano nei boschi o lungo le ferrovie, ogni tanto giungevano nella nostra baracca i gruppi che avevano aderito alla repubblica di Mussolini e di Graziani. Dicevano che molto presto sarebbero ritornati in Italia, che avrebbero avuto una licenza. I piú avevano ceduto per fame e per il durissimo lavoro, ma c’erano quelli che ancora credevano nella vittoria finale dell’Asse e nelle armi ...