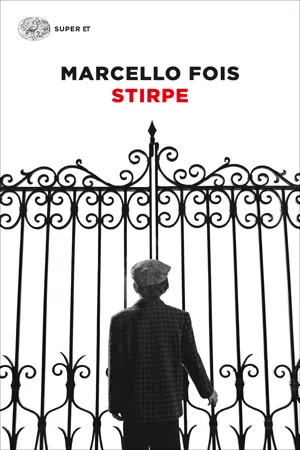![]()
Cantica seconda - Inferno
(1901-1942)
Scire nefas.
page_no="41" ![]()
Prima di uscire per vedere la statua del Redentore, Michele Angelo e Mercede hanno affidato ai vicini i piccoli, Gavino di cinque anni e Luigi Ippolito di tre. Pietro e Paolo, i gemelli, hanno avuto il loro primo incarico di uomini: portare cibo e denari per la zorronada ai lavoranti nella vigna.
Alla vigna non ci arriveranno mai Pietro e Paolo. Non sono piú bambini e portano cibo e soldi nella taschedda. Non ci arriveranno mai. Perché i lavoranti diranno di non averli visti… E nessuno dirà di averli visti nemmeno in quella fetta di paese prima che tutto si annulli nella campagna. Non un cristiano, non una cristiana. Perciò alla controra si raduna una piccola folla davanti alla casa del fabbro, tutta gente che sa cosa fare, dove cercare, sa dove ci sono rupi o caverne.
Mercede vede tutta quella gente che si agita, ascolta senza ascoltare. Sente il mare in tempesta.
Lei non sapeva cos’era il mare e nemmeno la tempesta. Non sapeva quasi nulla di quello che in genere si pensa che sia importante sapere. Perché aveva sette anni quando l’affidarono a una madre padrona. E aveva sette anni quando le spiegarono che non aveva un padre, né una madre vera. E le dissero che si chiamava Mercede come la suora ostetrica che l’aveva lavata per la prima volta e si era segnata accordandosi con Dio in modo che disponesse Lui a proposito della sopravvivenza o meno di quella bambina sfortunata. Lei, suor Mercede, la sua preferenza l’aveva già espressa: «Meglio morta», pispisiava. Ma non fu cosí. Dio dispose diversamente.
Perciò si arriva ai sette anni, quando la bambina viene portata da Redenta Lai che le dà un cognome e una casa, e un marito, e due figli, da accudire. Dalla padrona c’erano i mobili e, sopra i mobili, centrini e ninnoli, tutta roba come nelle case dei signori che hanno bisogno anche di cose inutili. Anzi, essere signori significa avere cose che non servono… All’ingresso, posata su un tavolino, sopra un centrino, c’era la conchiglia, che era una cosa misteriosa. Mercede la vide appena entrata in quella casa, ma scoprí come si chiamava qualche tempo dopo. Conchiglia. Conchiglia. Era grassa, grande, sembrava morbida e invece era durissima, sembrava di carne e invece era di pietra.
Il piccolo dei Lai, che aveva solo un anno piú di Mercede, un giorno le rivela l’arcano di quella forma intocca-bile: – Dentro alla conchiglia c’è il mare in tempesta.
Lei fa segno di sí, come se capisse tutto quello che le viene rivelato. È come Maria di fronte all’angelo: lui sussurra, e lei capisce e non capisce, ma è chiaro che quanto le si chiede non merita comprensione. Cosí accade a Mercede quando il piccolo dei Lai le racconta di mari e di tempeste.
– Che ignorante che sei, – sta dicendo mentre afferra la conchiglia. – Prendi, – continua porgendogliela. Ma lei indietreggia. – Ascolta, – insiste lui appoggiandosela all’orecchio. Ma lei fa segno di no con la testa. – Asina ignorante! – incalza l’altro e costringendola per la treccia le pressa la conchiglia contro l’orecchio.
Sembrava una cosa molle e calda e invece è durissima e fredda. Quel contatto le arriva fino allo stomaco, poi sente quello che il piccolo Lai chiama mare. Visto che lei si è calmata lui non preme piú.
page_no="44" – Il mare in tempesta, senti! – le ordina. E lei sente. Un nulla turbolento che si aggira dentro la caverna gelida della conchiglia, che forse è veramente un ricordo del mare da cui proviene, forse è solo il riverbero del suo cuore. Forse.
Proprio come ora, che i suoi figli non sono a casa, ora che i vicini sussurrano la sventura imminente, e prevedono l’ineluttabile. Mandare due creature con tanto denaro in giro non è cosa prudente con i tempi che corrono, con la miseria netta che ci ha assalito…
– Sono tempi troppo metzani, – sta commentando il prete Salis. Ma è un commento che si smorza quando lo sguardo si indirizza a Mercede.
Proprio come ora quel mare che non conosce ricorda a Mercede che ci sono sentimenti talmente vigliacchi che può passare una vita prima che si palesino. Come quello che sta sentendo ora, che a descriverlo è un misto di furore e impotenza, la percezione di qualcosa che non si conosce: il mare in tempesta appunto, ma cos’è mare? Cos’è tempesta?
– Povera, povera madre… – bisbigliano le donne.
Povera madre, perché Michele Angelo non sembra nemmeno preoccupato. – Appena si fanno vedere li arrangio io! – sta sibilando, come a chiarire che lui a tutti questi annunciatori di tragedia non vuole dare ascolto. Lui è convinto che la cosa giusta da fare sia aspettare i figli alla vigna. Cosí si avvia.
Dopo qualche ora si è fatto buio. È una notte nera, i ragazzi si cercano con grida e torce senza risultato. All’alba, dopo aver setacciato i dintorni palmo a palmo, un gruppetto di uomini è arrivato a S’Arbore, in fondo a Marreri, perché per forza i due Chironi devono aver fatto quella strada. Ancora si sentono richiami, altri gruppi stanno procedendo. Il tempo di sedersi e riposarsi un po’ e Murazzanu, che è il cane di Basilio Boneddu, si mette a forrocare verso una tuppa… Uggiola come una bambinetta viziata e si attacca col muso alle frasche. Basilio si avvicina, si china. E quello che vede lo tramortisce. Gli altri lo raggiungono.
Michele Angelo ha aspettato alla vigna tutta la notte. Dai e dai quel fazzoletto di terra è diventato un frammento del paradiso terrestre, quando Adamo capí che da soli non si può stare. Terra buona, lavoro serio, innesti giusti ed ecco i grappoli che scoppiano di salute sui tralci. Seduto tra due filari Michele Angelo sta facendo una preghiera e una richiesta. Perché, sta dicendo senza dire, sta chiedendo: perché? A chi lo chieda non lo sa esattamente. La sua rabbia è che è stato invisibile e modesto come si dev’essere quando la sorte è troppo favorevole. Invisi-bile e modesto, ripete, non abbiamo sbattuto in faccia a nessuno il benessere, a nessuno. Modesti sempre, sempre. E allora perché? Rognoso come Giobbe, Michele Angelo prende a rinfacciare la sua pena: Quale destino ho io? Di non vedere i miei figli crescere, due, due, me li hai già tolti…
Non è che si aspetti qualcosa, ma quando vede, in fondo alla vigna, spuntare la sagoma piú scura dell’oscurità di Basilio Boneddu, davvero spera che qualcuno gli sia stato mandato per rispondere alle sue domande.
Quel funerale con due bare bianche fu straziante. Tutto il quartiere San Pietro si precipitò sul sagrato del Rosa-rio. E come fare diversamente? Lí gli spettacoli erano i dibattimenti in tribunale e i funerali. Quel funerale, poi, di due creature morte uccise in quel modo atroce, attirò persino gente da Séuna…
Mercede partecipa con uno stato di euforia in corpo che quasi le scappa da ridere ogni volta che qualcuno si avvicina per farle le condoglianze. Tutta quella gente sta dicendo qualcosa di indicibile, dimostrando qualcosa di indimostrabile. Magari il mare è questa inconcretezza di sguardi, questa pena magmatica, e la tempesta è questa alterità atroce: essere lí e non esserci. È questa la tempesta?
Il corteo procede come se non volesse arrivare mai; c’è chi dice che una volta entrato in chiesa il morto è morto davvero, per altri la morte definitiva è solo quando cominciano a spalare terra sulla bara. Eppure per Mercede quella morte, quell’assenza, non è nemmeno avvenuta. In balia della sua tempesta continua a chiedersi perché mai tutta quella gente si sia radunata davanti a casa sua. Lei i suoi figli li conosce bene e lo sa che Pietro è un po’ musone e Paolo un po’ barroseddu, ma bravo, sono due bambini e ai bambini con l’aiuto di Dio e di Nostra Signora non gli può succedere niente, perché chi è la bestia che se la può prendere con due ragazzini? Chi? Eh?
Comunque la gente c’è, e tanta.
Michele Angelo non c’è.
Basilio Boneddu, in fondo al corteo, circondato da qualche curioso, non trova nemmeno le parole per dire che cosa ha visto veramente.
Sono seduti per riposarsi, lui e Michelino Congia, e anche Prededdu Murrighile, e altri. Hanno camminato per quattro ore seguendo la strada di Lollove. Non è che ce ne siano tante di strade possibili… Ecco che arrivano a S’Arbore, lui dice che manca sí e no un’oretta al sorgere del sole. Per cui gli uomini si guardano tra loro e si fanno cenno di sedersi cinque minuti a bersi qualcosa per scaldarsi, che sta cominciando a fare freddo.
«Murazzanu abbaia, corre, è contento come una pasqua: a lui basta portarlo in campagna e non vede strada di casa, fattu andande. Insomma, – sta raccontando Basilio Boneddu, – noi siamo seduti lí, che a un certo punto sentiamo il cane che fa versi, e questi non sono versi, io prego che per tanti anni che Nostro Signore mi lascia su questa terra di non sentire mai piú una cosa del genere. Oh, il cane comincia una specie di lamento come un bambinetto, e poi col muso tenta di entrare in una tuppa. Noi arpilati ci guardiamo e basta guardarsi per capire che tutti stiamo pensando la stessa cosa. Cosí mi alzo in piedi e vado a staccare la bestia dal cespuglio, il cane fa forza, io lo strattono dal collare e lo spedisco qualche passo indietro, intanto è arrivato Prededdu. Quando sposto la tuppa non è che si veda niente: Non vedo niente, dico, cosí Prededdu accende una frasca e l’avvicina. Io non lo so, grande e grosso quanto sono, da quello che è apparso, mi sono sentito le ginocchia molli molli… Gesúsu. Dentro alla tuppa ci sono pezzi di carne in mezzo a vestiti rossi di sangue. Alla luce della fiamma quel rosso sembra ancora piú rosso. Io dico: Che Dio non voglia! Prededdu Murrighile fa un salto all’indietro come se gli fosse arrivata una fucilata al petto. E cosí accorrono anche gli altri. Michelino, Bustianeddu… Per carità, per carità…» E scuote la testa.
Chi lo sta a sentire, anche qualche donna, abbassa lo sguardo: «Allora è vero che li hanno trovati fatti a pezzi?» Basilio fa cenno di sí, macellati e buttati lí per farli mangiare dai cinghiali. «Ma chi è la bestia che può fare una cosa del genere?» Basilio fa di spalle, secondo me questa non è una cosa di uno solo, qui erano magari un gruppo, chissà venuti da dove, con la fame che c’è in giro, ci sono uomini che anche solo dire uomini è troppo. Le donne si stringono nelle spalle e si segnano. «Non voglia Dio», bisbigliano. E intendono che non voglia Dio che possa mai capitare loro quello che è successo ai Chironi. Nessuno è piú al sicuro, sta continuando Basilio, bisogna stare attenti, perché la campagna è piena di questi disgraziati che non hanno piú niente da perdere…
Intanto il corteo, piano piano, avanza…
Michele Angelo in piedi guarda la sua vigna. Ha mandato a casa i lavoranti. Lui al funerale non c’è andato, perché ha qualcosa di preciso da fare. E sarebbe che c’ha da chiarire un paio di cose con chi ha precisamente stabilito un percorso tanto terribile per la sua vita.
Va bene, va bene tutto, si sta dicendo, guarda che io non ti ho chiesto di avere di piú di quello che mi spettava, ma solo quello che mi spettava, solo quello. E tu? Bravo, bravo davvero. Qual è il dolore, questa vigna? Eh? Qual è? La casa? L’officina? Eh?
Sta gridando, a chi non si sa, o forse sí a pensarci bene. Pover’uomo, è straziante solo a vederlo. Come un bue infastidito dalle mosche si sta agitando per togliersi di dosso il dolore che lo assale.
È una giornata atroce per fare un funerale. È atroce di smalto puro, come se fosse necessario frugare con lo sguardo fino ai particolari piú minuti. Infatti si vede tutto: gli acini gonfi, vetrosi, le foglie di un verde ramarro, i tronchi asciutti e scuri come carne secca. Non è che si può parlare con Dio e contemporaneamente essere costretti a tanta chiarezza, a tanta minuzia. Tutto è sensazionale in quel momento, Michele Angelo Chironi sta facendo i conti, sta tirando le somme. E proprio quando pretende ascolto ecco che guarda e sente le cose come non le aveva mai viste e intese, un nastrino rosso che sventola impigliato a un filare, un pezzo di carta che scivola sospinto dalla corrente d’aria, il ruscello poco distante che dice la sua, il battito d’ali di una gazza. Tutto serenamente perfetto. Che quasi viene da pensare che quella perfezione sia già di per sé una risposta definitiva.
Lui, Michele Angelo Chironi, lo sa bene cosa deve fare.
Quando Giuseppe Mundula arriva a cavallo di un asino e lo vede in piedi al centro di quello che è rimasto della sua vigna, sussurra appena: – Figlio, – gli dice. È la prima volta che lo chiama in quel modo.
Sono passati tanti anni da quando Michele Angelo davanti alla minestra di latte gli ha chiesto: «Ma tu adesso babbo mio sei?»
page_no="49" Ed è passato lo stesso ostinatissimo numero di anni da quando lui senza nemmeno guardarlo gli ha risposto: «Non sono babbo tuo».
Eppure adesso lo chiama figlio. Lo vede di spalle. Lo guarda, e il corpo di suo figlio sembra asciugato da un tremore continuo, come una povera creatura masticata dall’interno.
Michele Angelo, che l’ha sentito arrivare, nemmeno si volta. Quando Giuseppe lo chiama figlio, pensa a quanto dolore possa generare quella parola. E serra le mascelle fino a farsi male perché non vuole assolutamente piangere. Giuseppe, come può, scende dall’asino, ormai è in età e le ossa cominciano a far male, comunque scende e lo raggiunge alle spalle: – Che cosa hai fatto? – gli chiede. – Tutti ti cercano, – dice poi.
Ma Michele Angelo non risponde. Il fuoco si è divorato la vigna in un batter d’occhio, gli acini sono esplosi per il calore. In pochissimo tempo quella quiete di filari si è trasformata in una superficie di raso nero che si fa argento vivo quando l’aria la smuove. Ora al posto della vigna c’è la febbre crepitante sotto al carbonchio, e qualche ferita, ancora fresca, di brace ardente. E gloria a tutti i venti e a tutte le correnti, persino poco fumo: è come se il fuoco si fosse mangiato le viti in un boccone soltanto, senza troppe incertezze. La fiamma ha attecchito senza indugi, una fiamma quasi fredda come quella che pensava di incenerire il cespuglio di Mosè. Tanto che Giuseppe, dalla valle, mentre arrivava, ha appena fatto in tempo a vederla. È stata una vampata, un’unica immensa fiammata. Ora quel pezzo di paradiso è diventato il canale oscuro di un vulcano attivo.
Giuseppe raggiunge Michele Angelo alle spalle: – Che hai fatto, figlio? – ripete.
Ma Michele Angelo si è fissato a guardare un insetto volteggiare intorno a un fiore di cardo che si è salvato dalle fiamme, leggerissimo, e pensa che ci deve essere del buono se dalla pace assoluta di quella leggerezza perfetta in tutto può scaturire un istante di distacco… La voce di Giuseppe lo richiama alla terra: – Che hai fatto, figlio? Che hai fatto?
Cosí Michele Angelo scuote il capo, ma è un equilibrio talmente precario che le lacrime cominciano a scendere da sole.
Quando Michele Angelo si volta, Giuseppe è costretto a indietreggiare. Quel pianto gli fa paura, come se fosse un momento che ha sempre temuto e ora è arrivato. Cosí d’istinto indietreggia mentre Michele Angelo gli si fa incontro. Poi si fa raggiungere dal figlio, che ha deciso di lasciarsi andare e sta piangendo. Il primo abbraccio è puro come può essere puro quanto di immacolato esista al mondo, il sorriso di un neonato forse. Ecco, Michele Angelo abbraccia Giuseppe come se fosse diventato finalmente quel bambino che non ha mai potuto essere. Piange piano con la testa affondata fra il collo e la spalla del vecchio. Non si dicono niente. Non c’è niente da dire.
Quattro mesi dopo nasce, mestamente, Marianna. Un parto facile, una notte di travaglio e via, la bambina viene fuori senza nemmeno piangere. Quando l’ostetrica la batte lei fa come un colpetto di tosse e si mette in armonia col respiro dell’Universo.
page_no="51" ![]()
Poi, se Dio vuole, gli anni passano.
E passano come devono passare, senza quasi nulla da dire. Che uno si fa un bilancio, da vecchio, e si rende conto di quanto belle siano state quelle stagioni della vita che scorrevano silenziose. Perché il chiasso della vita piace solo a chi pensa di doverlo raccontare, per tutti gli altri il silenzio è un privilegio. Gli anni passano dunque fino a ridurre a una sterpaia la vigna di Lollove; fino a rendere talmente malfermo sulle gambe Giuseppe Mundula da costringere Michele Angelo e Mercede a portarselo a casa da loro. La sferzata di quella fine d’agosto maledetta ha lasciato segni indelebili. Mercede non ha piú tolto il lutto, il volto di Michele Angelo è marchiato da una malinconia piena di attese. Fa sonni agitati e lavora con una concentrazione ipnotica. Negli anni il ferro sembra essere diventato piú morbido, molto piú malleabile. Perché anche il ferro finisce per assoggettarsi al tempo, e alla perizia di chi lo lavora, e al braccio di chi lo batte, e all’accresciuta esperienza dell’artigiano. Ora, nella sua scurissima concentrazione, a Michele Angelo pare di sentire chiarissimi i segnali del metallo che si arrende e si lascia forgiare esattamente come lui stesso ha deciso di lasciar fare al tempo sulla sua carne.
In nero Mercede sembra una bambina, un dolore costante l’ha fatta strigile strigile. Eppure a sentirla si direbbe la stessa di sempre: a differenza di quel musone di Michele Angelo, la si può persino sentir sorridere. Lei è una zattera che procede nella bonaccia, certo è stata disperatamente sballottata durante le tempeste che hanno sconvolto il suo mare, ma ora c’è pace: le cose vanno bene, il pane non manca, i bambini crescono. Gavino ha compiuto gli otto anni e Luigi Ippolito ne ha fatti sei. Marianna è entrata nei tre.
Solo in un caso si rabbuia Mercede, quando le dicono che deve andare in cimitero a curare l’ultima casa dei suoi morti. Solo in quel caso. Le donne la prendono da parte e, ognuna a modo suo, le dicono sempre la stessa cosa: che non sta bene di lasciare in quelle condizioni le tombe dei suoi figli; che i cipressi le hanno ricoperte di fogliami secchi come piccoli vermi marroni; che il vento le rode smerigliando il mar...