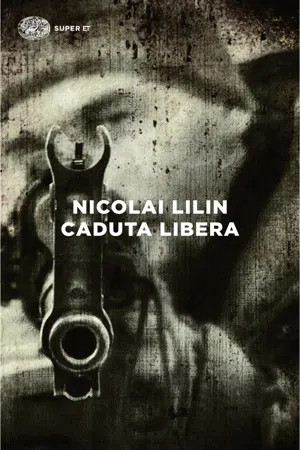Era la fine di ottobre in Cecenia, quando alla nostra squadra è stato indicato un posto di dislocazione temporanea: dovevamo raggiungere la base del 46º reparto della fanteria corazzata. La postazione era in mezzo alle montagne, in un punto strategico da dove la vista si apriva su due valli molto strette.
Secondo le voci che giravano, gli esploratori avevano dato l’allarme perché in quelle montagne il nemico stava concentrando forze militari. Si trattava di due numerosi gruppi armati, dotati di missili a fuoco singolo «Ago», un sistema missilistico terra-aria grazie al quale erano riusciti a buttare giú un nostro elicottero adibito al trasporto.
In quella stessa base, prima di noi, erano già arrivate alcune unità provenienti da due divisioni dei parà: uomini con carri armati e macchine blindate; nell’aria si preannunciava l’inizio di una grande operazione militare, con la partecipazione di diversi reparti dell’esercito russo.
Per tre giorni non è arrivato nessun ordine preciso, ma tra i soldati circolavano tante storie strane a proposito di quell’elicottero bruciato: c’era chi diceva che a bordo in realtà si trovava un ufficiale del comando, ed era quindi morto un pezzo grosso; altri non facevano che ripetere che era uno scandalo che il nemico possedesse una delle nostre armi piú efficaci. Gli ufficiali dei fanti ci avevano infatti spiegato che alcuni «Ago» – circa dieci esemplari – erano stati rubati durante una battaglia, dove una nostra colonna che trasportava armamenti era stata assaltata dagli arabi.
Il capitano Nosov schifava come sempre questo tipo di discorsi, e parlava di traffici illeciti, sostenuti e gestiti dagli uomini del nostro comando. Mandava maledizioni agli ufficiali traditori, che secondo lui vendevano ai ceceni e agli arabi tutte le nostre armi piú moderne e tecnologiche per permettergli di resistere contro di noi il piú a lungo possibile, perché «a loro fa comodo che la nostra guerra non finisca tanto in fretta». Come diceva spesso il capitano: «I generali e gli uomini politici del Cremlino mangiano la nostra carne bruciata e bevono il nostro sangue marcio». A volte le sue sfuriate sembravano persino poetiche.
Già ai tempi della Prima campagna cecena era molto comune il fatto che i nemici fossero dotati degli stessi nostri armamenti, quando non capitava addirittura che i nuovi modelli prodotti in Russia – che nel nostro esercito erano ancora considerati prototipi sperimentali, e quindi circolavano a malapena – finissero direttamente nelle loro mani.
Ai politici russi dell’epoca, guidati da «quello stupido ubriacone di Eltsin, – come lo chiamava sempre Nosov, – che si è venduto agli Stati Uniti d’America», a tutti loro – secondo il nostro capitano – serviva un buco nero: un posto che ingoiava i soldi per restituirli puliti sostenendo il cosiddetto regime «democratico», che veniva portato avanti alla maniera americana, e cioè con guerre, menzogne, traffici illeciti, e una totale assenza di rispetto verso la popolazione della Federazione Russa. Il loro buco nero era la Cecenia.
«Gli americani hanno dato una grossa mano a Eltsin e ai suoi uomini: sono riusciti a controllare tutta l’organizzazione di questa schifosa guerra, – si sfogava per l’ennesima volta Nosov mentre stavamo raggiungendo la base in elicottero. – Chissà quanto si sono divertiti gli specialisti del Pentagono, quando hanno sviluppato questa lurida strategia di guerre locali proprio negli spazi del loro ex nemico Urss… E attraverso la disinformazione, l’agitazione politica ed etnica ci hanno stuzzicato come se fossimo dei cani da combattimento, pronti ad attaccare».
Insomma, la loro tattica era paragonabile allo stupro di un cadavere: non gli era bastato uccidere il «blocco sovietico», volevano ancora saziare in qualche modo la loro malata sete di dominio, e per nostra disgrazia in quel tempo in Russia non c’era ancora nessuno capace di fermarli…
Il primo giorno nella base del 46º reparto di fanteria è trascorso senza che succedesse nulla di particolare, noi sabotatori siamo rimasti nella baracca che ci era stata assegnata in attesa di qualcosa. Sapevamo infatti che prima o poi un ordine dal comando sarebbe arrivato: nessuno avrebbe spostato tutti quei reparti da un posto all’altro senza un motivo preciso.
I paracadutisti, invece – come accadeva sempre nei momenti di tranquillità –, facevano casino, si ubriacavano, molestavano le ragazze dell’infermeria e della cucina, scherzavano con gli altri soldati.
Noi, seguendo i consigli e l’esperienza del nostro capitano, cercavamo di riposare un po’: appena potevamo dormivamo, e per il resto del tempo mangiavamo come dei maiali. Per ognuno di noi Nosov chiedeva personalmente la doppia razione e ogni tanto anche qualche extra, roba che arrivava dal magazzino alimentare e che di solito era riservata agli ufficiali: ad esempio il tè caldo zuccherato, insieme a dei biscotti confezionati a lunga scadenza di cui eravamo molto golosi.
Oltretutto Mosca aveva fatto uno scambio con il pilota d’elicottero che ci aveva portati in quella base: in cambio di una pistola americana – una Colt, e noi ne avevamo un bel po’ – quello ci aveva dato un sacchetto di limoni, una decina di tavolette di cioccolato e cinque scatolette di caviale rosso. Era stato un vero affare: di solito con una pistola ottenevamo al massimo due stecche di sigarette e tre bottiglie di vodka. Tutti gli autisti dei mezzi di trasporto chiedevano sempre a quelli nei reparti attivi di procurargli una pistola americana o europea, e siccome i soldi in guerra circolavano secondo un meccanismo ben preciso – «piú vicino sei alla linea del fuoco, meno valore ha il denaro» –, noi valorizzavamo tutto quanto col cibo.
Quella volta bisogna dire che ci ha aiutato la qualità tecnica della pistola: era molto bella, e spesso tra i militari russi, soprattutto quelli che non combattevano in prima linea, possedere una Colt era come avere un simbolo, un oggetto da mostrare agli amici e ai famigliari quando tornavano a casa e chissà quali storie raccontavano, per darsi le arie di quello che ha combattuto una guerra dura e alla fine l’ha vinta. Da noi esisteva anche un modo di dire:
«Le ragazze si buttano su quello che ha portato una Colt come trofeo».
Cosí, dopo aver «fatto la spesa», potevamo tranquillamente trascorrere qualche giorno in quella base. Del resto nel nostro gruppo funzionava la «regola del cammello»: quando ne hai la possibilità, mangia tanto e di tutto.
Alla sera del secondo giorno, una gentile infermiera che girava nei vari reparti per fare due chiacchiere e cercare un po’ di «affetto maschile», ci ha raccontato che i colleghi della divisione corazzata dei paracadutisti, a differenza nostra, le offrivano spesso della vodka. E con gioia, anche, perché vedevano in lei un emblema della dignità femminile.
– Voi invece non bevete? – ci ha chiesto all’improvviso.
Io non sono mai stato un gran bevitore, però l’idea di buttare giú un po’ di buona vodka non mi spiaceva affatto. E quelli del mio gruppo sembravano d’accordo con me.
Il piú agitato di tutti era Zenit, che aveva un vero debole per l’alcol:
– In effetti un sorso potremmo proprio farcelo…
– So che i carristi ne hanno una bella scorta, – aveva detto l’infermiera.
Abbiamo cominciato a studiare un piano: sperare di ottenere qualcosa dai carristi era impossibile, non restava che rubargli un paio di bottiglie o costringerli in qualche modo a dividere con noi il prezioso carico.
Sapevamo che i carristi, come molti altri reparti, avevano un animale portafortuna. Un’abitudine molto diffusa, in guerra: spesso i soldati si portavano dietro gatti e cani, ma anche animali selvatici che tentavano di addomesticare, come scoiattoli, ricci, qualcuno aveva persino un ermellino. I nostri carristi, però, erano famosi perché i loro animali preferiti erano i topi di fogna. Probabilmente perché nel gergo militare i carristi stessi vengono chiamati «topi», visto che durante le battaglie sono costretti a stare nello stretto spazio di una cabina a guidare il carro, muovendosi comunque con agilità. Sta di fatto che ogni carro aveva il suo topo, tutti gli davano da mangiare e quello diventava grasso come un vecchio gatto viziato.
In guerra i soldati credono in molte superstizioni, e la perdita dell’animale portafortuna è considerata una grande disgrazia…
Forse avevamo trovato il modo di farci una bella bevuta.
Nosov era uscito qualche ora prima, per far visita a un suo vecchio amico, un maggiore che aveva fatto con lui la guerra in Afghanistan e che adesso comandava uno dei reparti d’assalto che stavano nella nostra stessa base. Quando Nosov andava a trovare i suoi amici nessuno doveva disturbarlo, accompagnarlo o permettersi di seguirlo. Tutti quelli che avevano combattuto in Afghanistan rispettavano una specie di tradizione: s’incontravano solo tra di loro, e non accettavano la presenza di noi giovani.
Quella stessa notte siamo usciti dalla nostra baracca e ci siamo diretti verso la zona dei carri armati. Era un largo spiazzo non asfaltato al centro della base; giú dal cielo scendeva una pioggia sottile e leggera che ci batteva addosso con insistenza.
L’autunno da quelle parti è parecchio triste, e siccome eravamo costretti a muoverci nel fango, mi sembrava quasi di stare dentro la famosa poesia popolare di Esenin, quella che parla dell’autunno in maniera molto grezza. Fa cosí:
«Ecco, è arrivato l’autunno profondo,
gli uccelli hanno smesso di mangiare la merda,
qualche mucca ha cagato dentro il secchio del latte,
che tempo, fanculo tua madre…»
I carri stavano uno di fianco all’altro, disposti a mezzo metro di distanza. I cannoni erano abbassati perché non entrasse dentro l’acqua. Se guardavi bene, però, dai buchi dei cannoni ogni tanto potevi veder spuntare il muso di un topo; i nostri carristi spesso tenevano lí le loro bestie portafortuna, e quelle si sentivano a loro agio, non scappavano, ogni tanto uscivano fuori per respirare un po’ d’aria fresca ma poi tornavano giú al caldo.
C’erano alcuni carristi che facevano sorveglianza, ma li abbiamo evitati senza troppe difficoltà e in fretta abbiamo raggiunto il carro piú vicino. Abbiamo aspettato un po’, in silenzio, fino a quando dalla canna è uscito il muso baffuto di un topo.
Mosca ci ha fatto segno di tenere sott’occhio la situazione, e noi abbiamo circondato il carro. Poi s’è infilato un paio di guanti di cuoio spesso, di quelli che solitamente usano i mitraglieri, perché durante una battaglia il mitra si riscalda talmente che se lo ricarichi a mani nude rischi di scottarti. Mosca si è arrampicato sulla blindatura, poi si è agganciato alla canna con una mano mentre con l’altra ha fatto una mossa molto veloce, pinzando il topo sulla testa e tirandolo fuori con un movimento forte e deciso. Appena Mosca è saltato a terra, siamo scappati alla nostra postazione.
Nella nostra baracca abbiamo fatto conoscenza con il topo. Era un animale molto grasso e grande, aveva la coda lunga e il pelo molto pulito, che brillava come se si facesse lo shampoo ogni sera. Aveva un collare ricavato da un pezzo di stoffa verde strappato da una tenda militare, con un filo bianco qualcuno ci aveva cucito sopra il nome del topo e il numero del carro a cui apparteneva. Si chiamava Zeus, era un maschio.
Zeus non ha mai dimostrato di aver paura di noi, anche se sembrava infastidito da quel rapimento. L’abbiamo messo dentro una scatola di zinco dove normalmente tenevamo i proiettili per il Kalašnikov. Mosca è stato molto premuroso con lui: gli ha messo un pezzo di pane nella scatola, e ritagliando un tubetto di conserva vuota ha ottenuto un piattino per l’acqua. Poi ha fatto tre buchi sul coperchio per fare circolare l’aria.
Alla fine Mosca pareva soddisfatto: con il suo coltello ha dato un colpetto sulla temporanea prigione del topo e ha detto:
– Qui dentro, miei cari, si trova non solo la chiave per arrivare alla vodka… ma anche quella per ottenere il rispetto di tutti i carristi!
Noi ci siamo messi a ridere. Sembrava deciso come doveva esserlo stato Napoleone prima della campagna di Russia.
Una nostra delegazione – composta da Mosca, Zenit e Scarpa – ha comunicato all’equipaggio del carro armato i modi, i tempi e le condizioni del pagamento del riscatto. I carristi hanno accettato all’istante la nostra proposta: una cassa di vodka in cam...