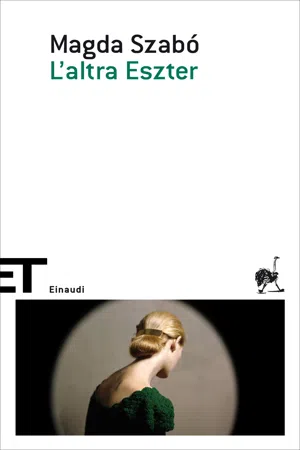![]()
Sarei voluta uscire prima stamattina, ma dovevo aspettare Gyurica, e sai che lui è perennemente in ritardo. Aveva detto che sarebbe arrivato per le nove, ma quando l’ho visto entrare dal portone erano ormai le undici passate. Tutti hanno creduto che Gyurica fosse un educatore del popolo o un rappresentante di riviste, nonostante avesse la borsa da medico in mano. Si è fermato al centro del cortile, strizzando gli occhi in cerca del numero 39, dove era stato chiamato; le donne sul ballatoio, vedendolo arrivare, sono velocemente rientrate in casa chiudendosi le porte alle spalle. Quando ci ha trovate aveva il fiatone, si è terso la fronte e ha chiesto a Gizike un bicchiere d’acqua. Riguardo al mio piede, ha detto che non era nulla di grave, dovevo solo fare degli impacchi ed evitare di camminare troppo. Non si sgonfierà prima di domani, ma tanto mica devo arrampicarmi sugli alberi. «Su e giú, su e giú, li porto su e giú». Gyurica non ha fatto il minimo accenno a te. Non per una questione di tatto, ma semplicemente perché non c’era piú niente da dire. Che cosa avrebbe dovuto aggiungere? Ha guardato con gli occhi sgranati Gizike, che se ne stava seduta con la schiena rigida accanto al tavolo tondo, le mani in grembo, da vera padrona di casa. Quando Gyurica si è alzato, ha versato un po’ d’acqua nella bacinella e spiegato un asciugamano pulito.
Avevamo appena rifatto il letto, ma i miei guanti e la mia borsa erano appoggiati lí sopra, impossibile non accorgersi che avevo trascorso la notte lí. Il bastone di Józsi e la sua mantella di plastica con il cappuccio pendevano da un piolo dell’attaccapanni, sulla mensola sopra il lavabo erano invece rimasti il suo pennello e la ciotola con il sapone da barba, io ero seduta con la vestaglia a fiori di Gizike, lei aveva indosso il vestito nero; nel momento in cui è arrivato Gyurica, si stava stirando la cuffia e il grembiule. Mentre lui mi tastava il piede, il gatto di Gizike, un gattone dal pelo tricolore, è saltato in casa dal ballatoio, si è strusciato contro i pantaloni di Gyurica e l’ha riempito di peli. Poi Gizike ha strofinato ben bene il lavabo dove Gyurica si era lavato le mani, come se avesse paura di un contagio.
In origine avrei voluto dormire sull’Isola. Ieri pomeriggio ero sola in casa, Juli si era recata in chiesa a recitare la litania. Le ho scritto un biglietto per informarla che sarei andata al Grand Hotel, ho preparato le valigie e ho chiamato un taxi. L’ho fatto fermare davanti all’arena estiva e l’ho mandato via. Dall’albergo giungeva musica, stavo per entrare quando hanno incominciato a ritirare il tendone blu che riparava i tavoli: il sole era ormai tramontato. Un inserviente si è messo a girare la manovella, la tenda blu si è lentamente ripiegata con l’armatura metallica che la teneva tesa. Per un istante ho scorto sul tendone il rattoppo che il tappezziere aveva cucito sotto i nostri occhi e all’improvviso ho risentito l’odore del temporale che l’aveva strappato, ho rivisto la vetrata spessa del ristorante attraverso la quale avevamo ammirato la pioggia scrosciante e i lampi che squarciavano il cielo.
Mi sono voltata e sono tornata in città. Quando sono salita a casa mia in collina ho trovato Gizike seduta sulle scale che mi aspettava, stirandosi accuratamente il vestito sulle ginocchia. Era il suo giorno libero, ed era venuta per chiedermi di dormire da lei. Non avevamo bisogno di spiegarci nulla. Abita in uno di quegli orribili casermoni delle grandi città, con tutte le finestre affacciate sul ballatoio, il suo appartamento è il numero 39, ma c’è addirittura un numero 60, vicino alla rampa di scale che conduce in solaio. Quasi tutte le porte dei ballatoi hanno una gabbietta appesa a un gancio, i bambini gridano nel cortile in basso, l’odore di cibo trapela dalle finestre, nella latrina comune la porta non si può piú chiudere con il chiavistello.
È stato quando sono entrata nell’appartamento di Gizike che ho inciampato nel secchio della spazzatura, mezz’ora dopo mi si è gonfiata la caviglia. Ho consumato la mia cena distesa a letto, Gizike aveva cucinato una torta di patate con la panna acida. In camera sua ci sono due letti, Gizike aveva preparato solo il suo, e cosí vi abbiamo dormito insieme. Sopra le nostre teste era appesa la sua fotografia al matrimonio di Juszti, in quell’immagine è una sposa giovanissima con gli occhi abbassati e un minuscolo mazzolino di mirto stretto fra le mani. Non so dove Gizike abbia mandato Józsi, non ho voluto chiederglielo.
Stanotte abbiamo dormito poco, mi doleva il piede. Gizike si alzava in continuazione dal letto e mi cambiava la fasciatura. Stamattina è scesa alla drogheria per telefonare, il resto lo sai. Quando Gyurica se n’è andato, ha chiamato un taxi, l’ho accompagnato fino alla piazza, che dista solo un centinaio di metri dal Cigno, e ho proseguito fin qui. All’ingresso principale erano seduti i venditori ambulanti di fiori, hanno insistito perché comprassi qualcosa, poi mi hanno lasciata in pace. Dal merciaio ho acquistato una dozzina di forcine per capelli, avevo di nuovo lasciato le mie chissà dove. Avrei voluto infilarmi nel cancello, ma in quell’istante ho visto un albero in fiore, con i rami curvi sopra il muro di cinta, e non sono entrata. Ieri non l’avevo notato, o forse non avevo guardato bene, oggi invece ho visto che è una bignonia, completamente ricoperta di fiori color amaranto.
Ma tu sai che cos’è la bignonia?
Papà potrebbe citare il termine botanico, un tempo lo conoscevo anch’io, e prima o poi mi tornerà in mente. Se fossi stato in via Petrosa, anche tu sapresti che è una pianta rampicante con il fusto contorto e tenace, e sapresti che i suoi fiori hanno la forma di minuscole campane. Quando andai per la prima volta a casa di Angéla, lei mi aspettava in piedi accanto al cancello, appoggiata con una mano all’inferriata, guardava con attenzione per vedere quando sarei arrivata e stringeva fra le labbra un fiore rosso di bignonia.
Insomma, non sono entrata e ho proseguito verso la cappella. Zoppicavo un po’: calzavo le scarpe di Gizike, che ha i piedi piú grandi dei miei, ma stringevano lo stesso e mi sentivo pulsare la punta delle dita. Nella cappella me le sono tolte subito e ho infilato i piedi sotto l’inginocchiatoio, il pavimento di pietra era piacevolmente freddo. C’era un vecchio, là dentro, oltre a me, muoveva le labbra inginocchiato davanti a sant’Antonio, e teneva le mani giunte come Pipi quando recita nella Santa Giovanna, pregava anche con il corpo con una certa platealità. Una volta finito, ha infilato del denaro nella cassetta delle offerte, una moneta bruna da venti centesimi. Appena è uscito, sono scoppiata a piangere.
Il mio modo di piangere è bello, melodioso, è la qualità che Ványa piú apprezza del mio talento. Avrebbe dovuto sentirmi prima, come singhiozzavo e gemevo! Non so perché piangessi: non credo fossi tu la causa, forse era piú per la cappella e il buio; non ricordo nemmeno quando sono entrata in una chiesa per l’ultima volta. La lampada perpetua ardeva, sull’altare della Vergine Maria c’erano rose, rose gialle dai petali flaccidi. Era terribilmente bello, indicibilmente bello, essere in una chiesa. Se credessi in un dio, se credessi comunque in qualcosa, non sarebbe stato altrettanto bello. Avrei subito scagliato verso il cielo qualche richiesta, avrei piagnucolato, mi sarei lamentata, avrei supplicato, anzi avrei addirittura promesso qualcosa in cambio. Cosí, invece, potevo sfogare il mio pianto senza contropartite, sapevo che non esiste aiuto, né volevo chiederlo; se anche avessi avuto la capacità di chiedere, avrei chiesto invano, cosí, invece, non dovevo giurare di essere buona, non dovevo mentire per poi uscire alla chetichella con il naso lucido, sollevata dopo aver scaricato sulle divinità celesti i pesi che gravavano sul mio cuore. No, i miei pesi sono rimasti. Ho potuto finalmente sfogarmi, ma in questo modo tutto è diventato piú greve. Non so spiegare perché, eppure era tutto cosí bello.
Quando ho deciso di andarmene, ho faticato a rimettere le calzature di Gizike, non sono piú riuscita ad allacciarle, ma tanto il mio piede era cosí gonfio che riempiva completamente il sandalo, e non c’era pericolo di perderlo camminando. Ho evitato con un giro il cancello principale perché non volevo passare accanto alla bignonia e sono entrata da quello secondario. Spero che da qua non passi nessuno che io conosca. Mi sono di nuovo sfilata le scarpe e sto seduta in terra a piedi nudi. Soffia un po’ di vento, quel poco che basta a scuotere le foglie sui rami. Un insetto mi striscia accanto, ha appena aggirato le dita dei miei piedi, è un bell’insetto lungo, affusolato, con le ali blu. Se mio padre fosse qui, spiegherebbe che è una Calosoma sycophanta, poi gli libererebbe la strada da quel nocciolo di albicocca sputato e lo esorterebbe con aria seria: «Ecco amico mio, prosegui il tuo viaggio in pace!»
Avresti sicuramente amato papà. Non ti ho mai parlato di lui, perché se posso evitare di parlare di qualunque argomento, con te o con altri, lo faccio volentieri. Da bambina sono rimasta troppi anni in silenzio per imparare a parlare crescendo; so soltanto mentire o tacere. Tutto il mio curriculum è una menzogna. Anche ciò che la gente dice sul mio conto è una menzogna. So mentire talmente bene che potrei guadagnarmi da vivere con le bugie. Ho capito di non avere scampo: non riesco piú a dire la verità nemmeno a te.
Ma che cos’è la verità? Il fatto per esempio che papà ora si rivolgerebbe all’insetto dicendogli: «Ecco, amico mio, prosegui il tuo viaggio in pace!» e poi si accoccolerebbe qui vicino. È strano, ma se penso a lui lo rivedo accoccolato in terra mentre osserva un insetto o un fiore da dietro gli occhiali, con i radi capelli biondi che gli cascano disordinati sulla bella fronte ampia, straordinariamente sporgente. Rivedo la sua rorida fronte, perché papà l’aveva sempre lievemente umida, non di sgradevole sudore, ma di una specie di vapore, come se qualcuno avesse alitato un soffio ardente sul vetro lasciandolo appannato per sempre. Anche quando morí aveva quell’umore sulla pelle, dovetti tergerlo con il palmo della mano perché i fazzoletti che avevo lavato la sera prima non s’erano ancora asciugati, era inverno, e il bucato steso in solaio scrocchiava gelato. I fazzoletti piú fini erano di zia Irma, asciugai quelli con il ferro a carbone in modo che mia madre avesse qualcosa in cui piangere. Nemmeno di zia Irma ti ho mai parlato, eppure ho camminato per due anni con le sue scarpe ai piedi.
In spiaggia non hai mai fatto caso che quando esco dall’acqua uso sempre le ciabatte? Appoggio solo il piede sinistro sulla passerella di legno, mentre il destro quasi non l’ho ancora estratto che lo infilo subito nelle ciabatte da piscina. A Szolnok, quando siamo saliti nelle stanze e tu sei poi venuto nella mia, non ero seduta sul letto con le gambe distese ma accovacciata sui talloni. All’alba, uscendo dalla mia stanza, mi hai sorriso dicendo che sono pudica perché nel momento in cui hai acceso la luce per prendere l’orologio e il portafoglio ho sollevato la coperta a nascondere i piedi.
Pipi avrebbe potuto spiegarti che non sono affatto pudica. Sarei felicissima di girare senza abiti addosso quando fa caldo. Pipi sa che la ragione è un’altra, sa che ho due calli sul piede destro, mai riassorbiti, nonostante la quantità di scarpe che mi sono fatta confezionare su misura. Come ti sei arrabbiato quella volta che ti ho impedito di accompagnarmi da Szurdusz a provare le scarpe rosse con la fibbia! Non volevo che vedessi il mio piede destro. Non volevo raccontarti di zia Irma.
Ieri è proprio il piede destro che mi si è gonfiato, l’ho teso a Gyurica dentro la pantofola. Se metto la scarpa di Gizike sento un dolore lancinante come quando ero piccola e usavo le calzature che mi passava zia Irma, la quale aveva piedini minuscoli come quelli di una bambina, ed era orgogliosa come una bambina dei suoi piedini straordinariamente minuscoli. Quando ero in prima ginnasio, durante l’estate, ruppi i sandali; una sera andai dal mio vicino Ambrus, il calzolaio, e gli chiesi un po’ di filo peciato per ricucirli. Ambrus me lo dette, ma non lasciò che li riparassi da sola, volle cucire egli stesso la suola con la tomaia. – Quanto le devo? – gli chiesi, Ambrus rispose di portare il cibo ai maiali, e cosí sudai sette camicie per trascinare il secchio del pastone fino al recinto di quei due maledetti bestioni, poi mi spezzai la schiena a sollevare il secchio, costretta a versarlo nel truogolo dall’esterno perché se fossi entrata mi avrebbero travolta. Dovetti anche rammendare, attaccare una toppa sui calzoni blu che Ambrus usava la domenica per recarsi nel frutteto, e a quel punto pareggiai finalmente i conti. In realtà pensai che mi avesse fatta sgobbare un po’ troppo per ripagarlo di quel misero pezzo di filo. Quando rincasai a piedi nudi, con i sandali in mano, papà era fuori, seduto in giardino. – Avrebbe bisogno di un paio di scarpe! – disse. La mamma aggiunse sospirando: – È proprio vero –. Io andai in cucina facendo finta di niente, e guardai che cosa c’era da mangiare. Un paio di scarpe? Certo che avrei avuto bisogno di scarpe. Ma in qualche modo avrei tirato avanti fino alla fine dell’anno scolastico. Di scarpe non ce n’erano.
Quella sera zia Irma passò a trovarci. Mio padre si era già messo a letto, mia madre tirò fuori il liquore di marasche che papà non poteva bere: non beveva mai, fingeva soltanto, e, appena l’ospite se ne andava, rimetteva con cautela il contenuto intatto del suo bicchiere nella bottiglia di liquore rivestita d’argento, versandolo goccia a goccia. Zia Irma mi voleva molto bene: mi prendeva in grembo per subissarmi di carezze, mi portava caramelle di zucchero, io mi lasciavo vezzeggiare come una piccola sgualdrina, sbirciandola con aria trasognata e cercando di capire se mi avrebbe dato dei soldi. In realtà il denaro arrivava di rado, praticamente mai, zia Irma mi portava invece quasi sempre un regalo. Quella volta fu un filo di perline rosse, perché mi ero fatta grande, ormai ero una studentessa del ginnasio; me la agganciò intorno al collo e mi baciò sulle guance. La guardai sbalordita. Se l’avessi rivenduta, il gioielliere l’avrebbe messa in vetrina e zia Irma l’avrebbe riconosciuta. Perline colorate! Che me ne sarei fatta, se non possedevo neppure una gonna decente?! Scivolai piano giú dal suo grembo, sentendo che per quella sera non sarei riuscita a sopportare oltre le sue moine.
Rimasi accanto al tavolo, il mio grembiule al fondo era macchiato, mi ero imbrattata con il pastone dei maiali, i piedi nudi erano lisci, e intorno al collo mi spiccava il rosso del corallo. Zia Irma mi esaminò da capo a piedi e chiese come mi sarei vestita per l’inaugurazione dell’anno scolastico. Mia madre sospirò: il ginnasio prescriveva tre diverse uniformi e io, al momento, non ne avevo neanche una. Eluse la domanda, balbettò qualcosa. Gli occhietti tonti di zia Irma s’illuminarono di gioia. Stese compiaciuta il suo piede per misurarlo accanto al mio nudo, poi si tolse la scarpa riparandosi dietro la tovaglia sfrangiata, e provò il mio sandalo. Constatò orgogliosa e felice che era addirittura un po’ grandicello per lei. Disse a mia madre che mi amava come una figlia e, dato che per un caso fortuito avevamo lo stesso numero di piede, sarebbe stato un immenso piacere per lei mandarmi un paio delle sue scarpe per l’inaugurazione dell’anno scolastico, lei si stancava rapidamente delle calzature che possedeva, se ne faceva confezionare di nuove in continuazione, e le vecchie stavano solo a prendere muffa nell’armadio, naturalmente mia madre non doveva considerare questa proposta in alcun modo offensiva, poiché in fondo erano parenti, cugine di primo grado. Le guardai i piedi: aveva un paio di eleganti scarpe di pelle gialla, con tacchi di media altezza. Erano minuscole e variopinte, sembravano quasi un giocattolo. Mia madre chinò gli occhi.
L’indomani ricevetti un paio di scarpe nere con i bottoni di lato e un rialzo grigio di antilope. Mi recai alla inaugurazione dell’anno scolastico con un vestitino bianco, pur essendo una ventosa mattinata settembrina che minacciava pioggia. La classe era schierata sull’attenti con le divise regolamentari blu scuro, ma alcune allieve avevano freddo e si erano abbottonate i cappotti. Io ero temprata ai rigori del clima come un piccolo orso, e marciai nella sfilata verso la chiesa con un’espressione accigliata in viso, traballando su quelle miserabili scarpe con i bottoni. L’insegnante mi chiamò in disparte per una comunicazione indirizzata a mia madre: avrebbe dovuto procurarmi un paio di scarpe piú consone a una ragazzina ed evitare in futuro di farmi indossare quella roba da adulti cosí vistosa. Mi informai se la scuola avesse intenzione di fornirmene un paio sostitutivo, lei mi domandò come mi chiamavo, quando udí il mio nome arrossí e non mi tormentò mai piú con la questione delle scarpe. L’istituto era stato fondato dal mio bisnonno, portava ancora il suo nome, Ginnasio Mózes Encsy. Ricevevo una borsa di studio, e continuai a frequentare la scuola usando le scarpe con i bottoni.
Dopo un anno si scoprí che il piede destro di zia Irma era piú piccolo rispetto al sinistro di mezzo numero. All’inizio la scarpa mi faceva semplicemente male, ma col passare del tempo cominciai a zoppicare, e alla fine non riuscivo piú a camminare. La sera, quando mi lavavo i piedi, mia madre piangeva vedendo le dita gonfie e malridotte. Avevo ormai quattro paia di scarpe, uno piú piccolo e piú strambo dell’altro. Quando la zia morí, il primo sentimento che provai fu di sollievo: d’ora in avanti non mi avrebbe piú passato le scarpe. Mia madre si era sempre immaginata che avrebbe lasciato a me tutti i suoi averi – quel «tutti» significava l’appartamento, i vestiti, la mobilia –, ma non aveva fatto testamento, e cosí arrivò il fratello, imballò ogni cosa e se la portò via sotto i nostri occhi.
Andai da Ambrus e mi feci tagliare la punta delle scarpe. A quell’epoca le calzature aperte in punta non erano ancora di moda. Quando tornai a casa con le scarpe mozze, mio padre impallidí vedendo le dita dei piedi che facevano capolino dalle calze bucate. Per un pezzo andai a scuola cosí, poi l’insegnante mi procurò un paio di scarpe pescando in qualche donazione religiosa e me le consegnò dopo la messa. Le baciai la mano per ringraziarla e le chiesi che cosa dovessi fare per sdebitarmi. Da quel giorno potei frequentare l’internato per impartire ripetizioni alle ragazze del terzo anno.
A proposito, la lezione di recitazione agli operai nella fabbrica di stoviglie ieri è saltata. Ma anche se si fosse svolta regolarmente non mi avrebbe turbata piú di tanto, ormai sono indifferente a tutto. Qui la cerimonia è durata poco, sono tornata a piedi, Pipi mi ha accompagnata fino al teatro. Ero assolutamente calma, osservavo le vetrine qua e là, sul körút ho mangiato un gelato. Quando sono arrivata a casa, Juli non c’era, e io non avevo piú intenzione di uscire, cosí ho preso un libro dallo scaffale. Mi sono anche coricata, poi mi sono faticosamente rialzata per preparare un caffè. Ho cominciato a macinare i grani, sono stata investita dal loro aroma, e tutt’a un tratto mi è passata la voglia di berlo perché all’improvviso davanti ai miei occhi c’eri tu, seduto in cucina, che macinavi il caffè, ridevi, mi sono ricordata dell’inverno in cui ero andata in tournée a Pécs per una recita di due giorni e al mio ritorno ero stata costretta a una sgradevole traversata in mezzo a una poltiglia di neve e pozzanghere per raggiungere i taxi. Non ti vedevo dall’alba del giorno prima, e detesto recitare se non sei vicino a me. Quando ero arrivata al posteggio ti avevo visto, eri in piedi davanti al tassista, mangiavi un kifli; poi ti eri seduto vicino a me nell’auto e avevi detto che ora un caffè bisognava proprio berlo.
Sono uscita dalla cucina e tornata in camera mia, mi sono seduta alla scrivania per compilare il mio curriculum. È la nona volta che me lo richiedono da quando lavoro in teatro. Ho scritto nome e cognome, poi mi sono messa a scarabocchiare il foglio, a disegnare pesciolini e ochette. Sono uscita dalla stanza e mi sono avvicinata al guardaroba, dovevo soffiarmi il naso. Ho preso tre fazzoletti, poi ho aperto bruscamente il cassetto dei medicinali perché mi ero di nuovo escoriata un dito con la serratura difettosa dell’armadio. Dietro le scatole dei farmaci e i rotoli di garza ho trovato una confezione di ciliegie al cognac che avevi riposto tu là dentro, chissà quando, scrivendoci sopra: «Aspirina». Allora mi sono subito rivestita e mi sono avviata all’Isola.
Avrei dovuto consegnare il curriculum oggi, il nuovo direttore del personale me l’ha chiesto proprio per oggi. Nel frattempo si è già fatto raccontare tutto sul mio conto, anche senza curriculum. Sono sicura che mi chiederà informazioni supplementari. «Dezső Encsy...», dirà, «dunque suo padre era avvocato». Che cosa succederebbe se gli rivelassi che non ha mai esercitato l’avvocatura nel vero senso della parola? Mi riterrebbe una gran bugiarda! Perché ovviamente mio padre era avvocato, e mia madre trascorreva le giornate seduta al pianoforte, voltando le pagine degli spartiti. In casa nostra si sentiva la musica dal mattino alla sera, tra le finestre dello studio fiorivano rigogliose piante esotiche, e mio padre contemplava trasognato il calice purpureo dell’Epiphyllum. Mia madre aveva tre titoli nobiliari, si chiamava Katalin Marton di Szentmarton, Ércík, Táp. Al centro del leggio sul pianoforte luccicava una miniatura di porcellana rotonda: raffigurava Mozart bambino con una minuscola parrucca e un abito celeste. Una volta rubai le uova a una contadina.
La casa in cui vivevamo fu distrutta da una bomba durante la guerra. Ho sempre desiderato mostrartela, ovviamente non per informarti che un tempo avevo vissuto lí. Volevo solo vedere che faccia avresti fatto, che cosa avresti detto girando da piazza dei Greci verso il canneto. La nostra strada era addirittura priva di nome; si chiamava semplicemente «l’Argine di pietra». Si trovava...