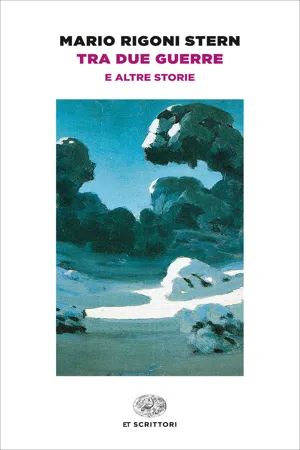![]() Page 95 Storie dall’Est
Page 95 Storie dall’Est![]()
Bielorussia 1975
Da Roma a Mosca.
Bielorussia 1975, o anche trent’anni dopo. Trent’anni da quel 9 maggio 1945, quando, finalmente, fu sconfitto il nazifascismo hitleriano dopo oltre quattro anni di lotta feroce. Una guerra che nella storia dell’umanità è ricordata come quella che ha ucciso il maggior numero di esseri umani. Solo di cittadini sovietici circa diciassette milioni (e c’è chi dice anche venti!), di cui dieci di civili.
Con un gruppo di giornalisti occidentali sono stato invitato dalla «Novosti», l’agenzia di stampa dell’Urss, a compiere un viaggio di circa due settimane nella repubblica socialista della Bielorussia per vedere i luoghi dell’occupazione tedesca di allora e della guerra partigiana; per incontrarmi con la gente delle città e della campagna, con i veterani di quella che da loro è chiamata «la Grande Guerra Patriottica»; per ascoltare e chiedere, per constatare come e quanto è stato ricostruito, e come oggi si vive.
Cercherò di raccontare tutto ciò con semplicità come è mia abitudine e maniera, e se qualche volta il sentimento potrà avere il sopravvento sulla ragione vi prego di comprendermi perché anche chi scrive, trent’anni fa, camminava sparuto e affamato da oriente verso occidente per ritornare in patria. E questi trent’anni di oggi mi sembrano piú brevi di un giorno di allora.
L’aereo sorvolava fiumi, paludi, foreste, città, villaggi; a guardare da diecimila metri tutto pare minuscolo: persino le montagne, i Carpazi, sembrano piatti e solamente la neve sopra una certa quota può dare l’idea della loro altezza. E tutta questa terra dell’Europa orientale è stata camminata da milioni di soldati, sconvolta da immani battaglie, distrutta, bruciata. Non potevo non ricordare, guardando da quassú, che anch’io con altri compagni l’avevo camminata passo a passo, per mesi e mesi: laggiú, dove ora a fatica distinguo un villaggio o una foresta, a noi bastavano una patata e pochi sterpi.
L’aereo andava sicuro con la sua perfezione meccanica, le hostess passavano a porgere caramelle, colazioni e bevande. Le donne russe, le solite care e dolci donne russe, che erano salite a Fiumicino, parlavano tra di loro come le comari sul mercato. Dicevano di Roma e di Napoli, di Firenze; si mostravano e commentavano gli oggetti di poco valore acquistati alla Standa e che tenevano dentro le sporte di plastica. Ma piú ancora, capivo, parlavano di quello che s’aspettavano a casa. Erano un gruppo di operaie in viaggio premio e avevo notato il luccichio dei loro occhi e il sorriso con cui avevano salutato il jet dell’Aeroflot che le aspettava all’imbarco. Allora dissi quelle due parole che mi dicevano i russi compagni di prigionia nel Lager 1/B quando mi vedevano malinconico. Mi guardarono subito, quelle donne, con una simpatia che faceva tenerezza, e mi sentii tra amici. Insomma questa presenza mi diede fiducia per un viaggio che forse affrontavo con una certa stanchezza dovuta ai trascorsi e all’età.
Tra i passeggeri dell’aereo c’era pure una comitiva non numerosa di italiani, uomini e donne, in gita turistica; ed erano euforici come ragazzi in vacanza: il loro ostentato modo di voler apparire eleganti, le loro esclamazioni ad alta voce, il chiamarsi, erano forse una maschera all’emozione di quella che credevano un’avventura fascinosa in un mondo conosciuto solamente attraverso il cinema o i rotocalchi. Al loro accompagnatore chiedevano se a Mosca era possibile camminare per le strade, e se si potevano trovare whisky e champagne, come si sarebbero potute cambiare con profitto le lire con i rubli, e quanto costava il caviale.
Turisti cosí, poi, se ne incontreranno tanti, e di ogni nazionalità dell’Occidente. Sono quelli dei grandi alberghi dell’Intourist, dei negozi «Berioska», delle fotografie sulla Piazza Rossa quando c’è il cambio della guardia al mausoleo di Lenin, dei ristoranti costosi; e ritornando alle loro case, di questo grande paese che è l’Urss poco o niente avranno capito. Il loro turismo fatto di vodka, caviale, costosi souvenir non li arricchirà certamente di conoscenza, e raccontando, poi, diranno delle donne che lavorano da manovali edili o guidano i camion, o del bagno dell’albergo che non funziona perfettamente, o dei contadini per le vie di Mosca con fagotti e sacchi e stivaloni, della fila e del rigore delle guardie per poter visitare il mausoleo di Lenin. Quelli in aereo rimasero delusi quando l’accompagnatore assicurò loro che a Mosca non era possibile assistere a uno spettacolo di striptease.
Il chiacchierio delle donne russe dentro l’aereo era come un sottofondo al paesaggio che tra squarci di nubi s’apriva sotto. Riconobbi il Dniepr, i dintorni di Kiev; intuii il disgelo laggiú sulla terra degli uomini e le betulle che gonfiavano le gemme. E fummo a Mosca, il piú grande villaggio del mondo.
Dalla primavera romana in tre ore e mezzo arrivammo là dove ancora sopra gli stagni il ghiaccio non era completamente sciolto; e tutto questo faceva una certa impressione per il rapporto tempo-distanza. Molto rapide furono le operazioni doganali e di controllo dei documenti. Al di là del cancello erano ad aspettarmi due redattori della «Novosti».
Ero il primo del gruppo dei giornalisti invitati – gli altri sarebbero arrivati all’indomani – e all’albergo Sovietskaja, sulla Prospettiva Leningrado, trovai fin troppo caldo e un prelato ortodosso che scendeva le scale di marmo coperte da tappeti tra gli ossequi del personale. Dopo un breve riposo passato in camera a guardare la televisione dove alcune rigide ragazze cantavano noiose canzoni pseudo occidentali, venne Alioscia, il redattore della «Novosti» che d’ora in poi mi avrebbe fatto da interprete, per accompagnarmi nel pomeriggio a un primo incontro con Mosca. Alioscia parlava un italiano perfetto con una leggera sfumatura romanesca, ricco di vocaboli e ricercato molto piú del mio che è tremendamente dialettale.
Ci avevano messo a disposizione una autovettura Volga per spostarci da una parte all’altra della città, e siccome andando in macchina non sono capace di osservare, iniziai a parlare con il mio accompagnatore di poeti e di scrittori. In comune avevamo molte simpatie, ma quello che piú mi sorprese fu la conoscenza particolare che Alioscia aveva della canzone italiana moderna: De André, la Vanoni, Milva e altri ancora. Alla sua curiosità per essere aggiornato in questo campo non seppi rispondere in modo esauriente.
Finalmente scendemmo a camminare per la Piazza Rossa, attorno alle mura del Cremlino, e tra le chiese e le torri. Nei lunghi silenzi ripensavo epoche storiche lontane e recenti. Reminiscenze letterarie. Ma la gente, moscoviti, cittadini di ogni parte dell’Urss, turisti, studenti del terzo mondo, mi fece apparire anacronistico quel meditare. A ben guardare, Mosca era veramente il piú grande villaggio della terra, e il cambio della guardia al mausoleo, in perfetto sincrono con il battere dell’ora sulla Torre del Salvatore, mi riportava a un’altra realtà: alla Rivoluzione d’ottobre che sconvolse il mondo, a Lenin, a Stalin, all’Armata Rossa. Ma anche a Gagarin.
La sera ci sorprese che ancora camminavamo lungo la Moscova, un vento leggero correva con l’acqua; le luci dei grandi alberghi e dei palazzi piú o meno belli mi erano meno amichevoli che non la fievole illuminazione di un’isba. Prima, quando c’era ancora la luce naturale, mi aveva sorpreso la strana facciata di un palazzone: una metà era completata differentemente dall’altra e ne seppi la storia. Negli anni Cinquanta era sorto tra gli architetti un contrasto: chi era per un progetto e chi per un altro. Il giudizio definitivo venne sottoposto a Stalin che, tra le tante carte alla firma, quel giorno si trovò davanti i due progetti; non sapendo i precedenti, li firmò tutti due. Naturale imbarazzo dei costruttori che, infine, salomonicamente decisero di completare la facciata metà su un progetto e metà sull’altro. Ed è lí a testimonianza di un’epoca passata.
Al ristorante dove cenammo c’era una grande confusione. Come altre volte avevo notato, in quasi tutti i ristoranti o alberghi, specialmente se sono di un certo livello e sono frequentati da stranieri, i cittadini russi sono usi fare grandi cene con balli, fiori, brindisi, bevute. Bene tutto questo: viva l’allegria! Ma, perbacco, l’orchestra e i cantanti rompono i timpani che nemmeno si può discorrere a tavola; e i commensali poi si scatenano a ballare, tra una portata e l’altra e un bicchierino di vodka, nello spazio lasciato libero appositamente. E ballano con slancio, alla moderna. E se non ci sono uomini sufficienti le donne ballano tra di loro. (Questo, mi assicurano, è perché nel dopoguerra gli uomini erano veramente pochi e cosí è rimasta l’usanza). Richieste e cantate sono molte canzoni italiane che mai prima avevo sentito.
Il mattino dopo, un poco intontito per il fumo della sera e per il caldo della camera, uscii sulla strada a respirare profondamente. Il cielo era coperto ma l’aria tiepida: primavera insolita a Mosca. Nell’attesa dei colleghi stranieri che erano in arrivo dai loro paesi, andammo con il metrò fin nei pressi della Bol’saja Pirogovskija per poi raggiungere quel suggestivo angolo di Novodevicij (Nuovo Monastero della Vergine) dove nei periodi torbidi veniva custodita la famosa icona della Vergine di Smolensk.
La Bielorussia che rinasce.
Ora incominciava la parte ufficiale del nostro viaggio, organizzato con meticolosità negli orari e negli incontri. A volte noioso, appunto per la monotonia dell’ufficialità e del riguardo nei nostri confronti, ma anche imprevedibile e lieto in tanti altri momenti. A ciascuno avevano dato un programma scritto nella sua lingua ed eravamo: Robertson per l’Inghilterra, Hollstein per la Repubblica federale tedesca, Strand per la Svezia, Falley per l’Irlanda, Iversson per la Norvegia, Chantenal per la Francia, Peterson per la Danimarca, Kostas per la Grecia. Un bel gruppo davvero, quasi tutti giovani, e di questi il meno professionale ero certamente io.
Il primo dei numerosi incontri avvenne con il vicepresidente del consiglio d’amministrazione della «Novosti», che illustrò minutamente scopi e finalità dell’agenzia prima e del nostro viaggio poi, dicendo che ci lasciavano liberi, naturalmente, di chiedere e di scrivere poi qualsiasi cosa. Solo che nel corso del soggiorno, come ebbi a constatare, alcuni del nostro gruppo che forse non avevano capito, o finto di non capire, il meccanismo politico dell’Urss e meno ancora l’indole dei funzionari o delle autorità, o la complessa struttura burocratica (ma premetto che anch’io ho rinunciato definitivamente a capire la burocrazia sovietica), fecero domande per cosí dire «all’occidentale», suscitando a volte malumore e imbarazzo tra gli interlocutori. Ma la prima cosa da tener presente in questo nostro viaggio era l’occasione dovuta al «trentesimo anniversario della vittoria sul fascismo» (maggio 1945).
Per questo il successivo incontro fu con il segretario responsabile del Comitato sovietico dei veterani di guerra. Ma prima andò cosí.
Dopo aver visto il documentario Sulla Piazza Rossa il Giorno della Vittoria, le cui immagini sono ormai note nel mondo, ci mettemmo in fila per l’omaggio al mausoleo di Lenin e ai sepolti lungo le mura del Cremlino.
La grande piazza era deserta di veicoli e pedoni, solamente lungo i marciapiedi dei magazzini Gum la folla disciplinata stava attenta a non mettere i piedi giú dal profilo; delle transenne chiudevano il passaggio verso la piazza del Maneggio. Come uscimmo dal Museo storico ci accodammo alla lunga fila che in quel tratto della piazza era doppia. Delle guardie armate, impeccabili nella divisa, sorvegliavano il tutto. Mai ebbi occasione di vedere tanti rappresentanti del genere umano e di classi sociali come in quella fila che lentamente ci saliva incontro, mentre noi si scendeva per fare il giro lungo il brutto palazzo del museo e altra gente in silenzio ci raggiungeva. Due ragazze francesi che stavano dietro di noi passarono nella fila accanto per ricongiungersi con il gruppo dei conoscenti ed evitare almeno mezzo chilometro di strada, una guardia le vide da lontano, le individuò e con fermezza gentile ma inequivocabile le rimandò in coda a tutti, ben piú in là di dove erano uscite!
A mano a mano che si procedeva sulla Piazza Rossa le guardie diventavano piú numerose e severe; bisognava seguire attentamente la striscia bianca segnata sulla pavimentazione e sembrava, tanto erano il silenzio e il vuoto attorno, che anche la grande città fosse diventata improvvisamente deserta per un singolare funerale. Nella fila si parlava sottovoce, con rari bisbigli, e si andava a due a due come i frati. Avvicinandoci al mausoleo le guardie osservavano piú da vicino e attentamente, la gente veniva invitata con un gesto a levare le mani dalle tasche e ad abbottonare il cappotto o la camicia. Al collega norvegese, che era davanti a me, una guardia passò destramente una mano su una rigonfiatura che appariva sotto l’impermeabile: erano semplicemente gli occhiali nel taschino della giacca.
All’entrata del mausoleo le due sentinelle erano come il lucido e freddo acciaio delle baionette inastate sui fucili che tenevano a pied’arm. Dentro c’erano fiori ma anche altre guardie, che a ogni piano delle scale scendevano e poi risalivano. Silenzio. Guardie immobili. Garofani rossi. E Lenin dentro la bara di cristallo. Irreale, cereo. La mano sinistra chiusa a pugno con il braccio leggermente flesso lungo il corpo, la destra sul petto.
Quando uscii sulla Piazza Rossa, all’aria, provai un grande sollievo; nel viso degli altri vedevo il mio perplesso stupore. Passammo poi lungo il muro dove sono sepolte le Guardie rosse cadute durante la Rivoluzione d’ottobre, e John Reed, e marescialli e statisti fino a Budyonny e a Stalin. Anche sulla tomba di Stalin – c’è il busto ma non ancora l’iscrizione – era deposto un mazzo di garofani bianchi. Ma le tombe di Gagarin e degli altri astronauti erano interamente coperte di fiori.
Il rituale per la visita al mausoleo di Lenin in nessun luogo oggi, credo, riscontra tale solennità: in nessun altare della patria, in nessuna cattedrale.
Quel pomeriggio ci trovammo seduti attorno a un tavolo nella sede del Comitato dei veterani, che raggruppava ex combattenti, partigiani, reduci della guerra di Spagna eccetera. Il generale Batov, che ne era il presidente, ci spiegò come l’organizzazione fosse estesa a tutte le repubbliche dell’Urss fino al piú disperso villaggio e come gli scopi fossero eminentemente assistenziali e sociali. Non c’erano iscritti o soci, né tessere. Piú volte e con insistenza precisò che chi ha veramente provato gli orrori della guerra è per la pace e che il loro ultimo congresso aveva avuto come tema «Campagna per la pace». Insomma, diceva ancora, lotta alla guerra ma difesa della patria e del socialismo.
Era un «eroe dell’Unione Sovietica» in divisa militare, il suo petto era ricoperto di medaglie. Figlio di contadini della regione del Volga, ex sergente dell’esercito zarista, aveva partecipato alla prima guerra mondiale e alla Rivoluzione d’ottobre, quindi aveva combattuto con le Brigate internazionali assieme a molti italiani di cui ricordava i nomi con singolare calore. A Bilbao, nel 1939 era stato ferito, e poi aveva vissuto tutto il resto tra il 1941 e il 1945: dal Circolo polare fino alla Crimea e alla Germania.
Accanto a lui c’era un altro signore senza decorazioni, vestito di marrone, che stava zitto e ascoltava attentamente, ogni tanto sorridendo alle domande dei giornalisti. Il generale Batov lo presentò e lasciò che fosse lui a rispondere ad altre domande. Chiesi all’interprete: – Per favore, può chiedere al signore in che zona d’operazioni si trovava durante l’occupazione tedesca?
Tradusse subito la domanda e anche la risposta: – Ho anche comandato l’artiglieria nella zona del Don... – Qui l’interruppi con un cenno: – Sparavate molto bene!
– Come può dirlo?
– Ero sull’altra riva del fiume.
L’interprete disse qualcosa.
– Alpini italiani?
– Sí. Alpini italiani. Ricordo fin troppo bene i vostri 152 e le katiusce...
I traduttori sussurravano le nostre parole in un silenzio che pareva imbarazzante. Mi alzai, alla fine, dal mio posto quasi inciampando nel tappeto e mi diressi verso quel signore che mi aspettava in piedi e che allora ci aveva sparato addosso con i suoi cannoni. Ci stringemmo la mano con tanto calore.
Quella sera, dopo aver cenato tra il solito frastuono di orchestra e canzonette, tutti in gruppo andammo alla stazione Bielorussia per salire sul treno per Minsk.
Tre betulle e una fiamma.
Tre betulle e una fiamma. Questo è il semplice monumento che ricorda come su quattro cittadini bielorussi uno sia stato ucciso durante l’occupazione tedesca. Ritrovare quei giorni dopo trent’anni è stato per me riaprire l’angoscia degli incubi che erano sopiti dentro. Nella primavera del 1943, in un’isba della Bielorussia dispersa tra foreste e paludi e zona franca ai partigiani, avevo trovato ospitalità dopo la tremenda esperienza della ritirata di quell’inverno. Erano contadini poverissimi e chissà quanto provati dalla guerra fascista; dividevano con me il poco cibo e il loro calore, e capivano le ferite mortali che avevo dentro. Il vecchio e il ragazzo erano quasi sempre fuori a combattere gli invasori e le ragazze cantavano e filavano. Stavo sdraiato per ore su un po’ di paglia come un cane nella cuccia e ascoltavo in silenzio. Un bambino ogni tanto frignava: era in una culla che penzolava dal soffitto.
Ma credo che piú di ogni memoria siano eloquenti le cifre. Secondo i piani predisposti dai tedeschi, il 75 per cento degli abitanti di questa repubblica dell’Urss doveva essere eliminato, il rimanente 25 per cento schiavizzato nel lavoro coatto per la razza eletta, poiché tutti gli abitanti erano considerati subumani. Dopo la «operazione Bagration» iniziata dall’Armata Rossa il 2 luglio 1944 e che portò alla liberazione della Bielorussia, 2 230 000 civili mancavano all’appello: erano stati uccisi nelle rappresaglie o deportati nei Lager della morte. 209 città su 270 risultavano quasi completamente distrutte, 9000 villaggi avevano subíto danni gravi, 619 erano stati distrutti, 433 rasi al suolo «con sterminio»; 186 non sono stati piú ricostruiti. Minsk nel 1940 aveva 270 000 abitanti: dopo 1100 giorni di occupazione gli abitanti erano 45 000 e quasi tutti ammalati, feriti, affamati. Nei dintorni della città erano stati uccisi circa 300 000 civili.
Quando le truppe sovietiche, il 6 luglio 1944, entrarono nella città il loro stupore fu grande nel vedere che non c’era gente in festa ad accoglierle; c’erano solamente cittadini sparuti con il volto solcato dalle lacrime. Le case e i palazzi erano stati distrutti al 90 per cento; sulla piazza, davanti all’edificio del governo, era stata innalzata una forca lunga decine di metri dove venivano impiccati e lasciati esposti coloro che osavano lottare per liberare la loro terra. Prima di ritirarsi i tedeschi avevano minato e bruciato quello che ancora era rimasto abitabile.
Questo e altro ci racconta Michail Kovaliov, presidente dell’esecutivo del soviet cittadino. I colleghi stranieri ascoltano attentamente le traduzioni e prendono note, e dopo sono io il primo a rompere il silenzio per chiedergli di oggi.
– Per la ricostruzione, – dice, – fummo aiutati da tutte le repubbliche dell’Urss. Nel 1945 il primo piano regolatore prevedeva uno sviluppo fino a 500 000 abitanti, ora siamo 1 150 000; le industrie si sono molto sviluppate: trattori, camion, tessili, prodotti alimentari. La gente abbandona i villaggi e viene nella città, e i problemi sono grossi; prima di tutto bisogna costruire case, e il materiale edilizio non è sufficiente alle richieste. Per le forniture idriche ora ci serviamo di pozzi artesiani, pompiamo dal sottosuolo garantendo 200 litri di acqua a ogni cittadino, ma entro un anno ne avremo altri 300 perché stiamo deviando un fiume verso la città; a 18 chilometri sono già pronti gli impianti di depurazione.
Gli chiedo come è composta l’amministrazione della città. Risponde: – I consiglieri deputati dei lavoratori sono 500 e restano in carica 2 anni; l’esecutivo è composto da 14 membri e comprende: un presidente, 5 vicepresidenti e un segretario; poi ci sono 20 consiglieri delegati ai vari settori operativi: scuole, viabilità, commercio, salute, elettricità e riscaldamento, eccetera; inoltre 7 soviet rionali collaborano con l’esecutivo. I dipendenti, impiegati e tecnici, sono 600.
Alla mia osservazione che questi 600 dipendenti per una città di oltre un milione di abitanti mi sembrano pochi, risponde deciso che sono sufficienti ed efficienti. Gli chiedo ancora della polizia cittadina e dell’ordine pubblico. Risponde: – La polizia prende direttive dal presidente dell’esecutivo del soviet cittadino, l’istruzione della stessa e i mezzi sono forniti dal ministero degli Interni della Bielorussia.
Voglio ancora sapere del bilancio comunale e delle tasse. Risponde: – Per il 1975 l’entrata è di 204 milioni di rubli ed è cosí ripartita: l’80 per cento è dato dall’imposta sui profitti delle aziende e, in piccola parte, dalla tassa di circolazione sugli automezzi; il 12 per cento è dato dall’imposta sugli spettacoli e varie; l’8 per cento dall’imposta sul reddito dei cittadini che colpisce con l’...