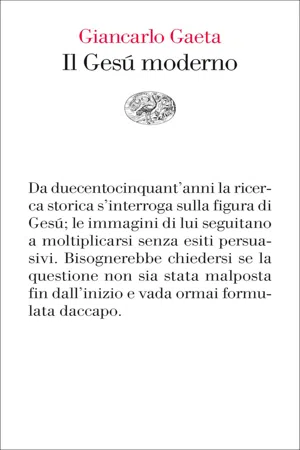
- 152 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Il Gesù moderno
Informazioni su questo libro
La storia della ricerca moderna sulla vita di Gesú è stato il tentativo, di tempo in tempo rinnovato, di ridisegnarne l'immagine tradizionale per portare alla luce ciò che essa cela: l'uomo del proprio tempo, un personaggio marginale vissuto nella Palestina del primo secolo che osò credere in un rivolgimento prossimo dell'esistenza del proprio popolo ad opera di Dio stesso, ma che pagò con la vita il suo sogno. Su quell'evento, decisivo per la civiltà occidentale, storici, sociologi, teologi ed artisti oggi s'interrogano di nuovo, affollandosi intorno a una questione che quante piú risposte ragionevoli riceve, tanto piú sembra sottrarsi ad una comprensione effettiva.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Capitolo terzo
Il nuovo Gesú storico
La lettura di questo lungo excursus sarà forse risultata faticosa, ma dovrebbe aver chiarito la complessità del tema che ci occupa e fino a che punto esso concerna fondamentali questioni storiografiche, teologiche ed ermeneutiche, che tutte si ricapitolano nella questione specificamente moderna del nesso tra fatto storico e interpretazione. O almeno è con una siffatta complessità che gli studi esegetici hanno seguitato a misurarsi finché furono perlopiú prodotti nell’ambito della ricerca storico-critica protestante di matrice tedesca, si trattasse del seminario di Nuovo Testamento tenuto da Günther Bornkamm a Heidelberg o del corso sulle origini del cristianesimo tenuto da Oscar Cullmann alla Sorbona, per citare due diverse e complementari realtà di cui ho fatto personalmente esperienza negli anni di formazione intorno al 1970. È in effetti con il venire meno di tale predominio nel decennio successivo e l’imporsi delle ricerche emerse inizialmente nell’ambito linguistico anglosassone, che anche l’impostazione della ricerca sul Gesú storico è cambiata.
La natura di tale cambiamento va misurata sul deciso abbandono di quello che era stato fin lí il motivo dominante della ricerca, vale a dire la critica al metodo storico oggettivo, nel convincimento che l’ambito dei fatti rappresenta soltanto un primo livello della realtà storica, la cui indagine non deve andare a scapito della considerazione di uno strato piú profondo: quello del significato esistenziale degli avvenimenti; e d’altra parte il riconoscimento del carattere essenzialmente kerygmatico dei racconti evangelici, tale da rendere altamente problematico l’accesso all’effettiva vita storica di Gesú, se non per alcuni tratti frammentari. La combinazione di una siffatta concezione storiografica con la verifica critica circa lo statuto delle fonti relativamente alla vicenda storica di Gesú, aveva determinato tra gli anni Venti e gli anni Settanta una vastissima produzione storico-esegetica sostenuta da un forte dibattito teorico che, come in parte si è visto, accordava la preminenza alla comprensione teologica del dato storico, sia che si riducesse il significato dell’esistenza di Gesú a semplice occasione storica per l’elaborazione dell’annuncio cristiano, sia che le si riconoscesse significato costitutivo per la fede cristologica.
In ambedue i casi, ben rappresentati l’uno da Bultmann l’altro da Käsemann, la ricerca storica, pur conservando la propria autonomia epistemologica, riceveva pieno significato dalla relazione tra i fatti indagati e la domanda dello storico, a condizione che questo fosse disposto a porsi personalmente in questione in tale interrogazione e che la storia avesse qualcosa da dirgli. Entrambi gli orientamenti si opponevano perciò alla ricostruzione della vita di Gesú sulla scorta del puro metodo storico oggettivo, malgrado divergessero sulla valutazione del ruolo di tale vita nella determinazione dei contenuti della fede cristologica. Tuttavia l’affermazione bultmaniana di una sostanziale discontinuità tra la predicazione di Gesú e l’annuncio cristologico dei seguaci, e quindi il riconoscimento che la vicenda terrena di Gesú andasse per intero letta nel contesto giudaico, apriva indirettamente la strada proprio all’impostazione storiografica a cui piú energicamente egli si era opposto; cioè a qualsivoglia considerazione della storia che tentasse di ottenere la sua oggettività mediante l’applicazione di un metodo, poiché in questo caso si potrebbe anche «superare la soggettività del singolo storico, ma restando cosí completamente nella soggettività del metodo»115 .
Ora, è precisamente questo quel che accadde nel momento in cui, esauritosi il tentativo promosso da Käsemann di recuperare elementi di continuità tra il Gesú storico e il Gesú della fede, cadde altresí l’interesse per l’interpretazione comandata dalla problematica esistenziale, a tutto vantaggio di ciò che Bultmann chiamava «la considerazione oggettivante del positivismo storico», dalla quale la soggettività dello storico è inevitabilmente estromessa116 , al pari, per altro verso, della considerazione apologetica, altrettanto oggettivante, che legge a ritroso la storia del cristianesimo come un processo formativo unitario117 . Vi è in questo una coincidenza degli opposti, che occorre tenere presente per meglio comprendere gli sviluppi contemporanei della ricerca sulla genesi del cristianesimo, nella quale del resto si confrontano ormai una pluralità di posizioni storiografiche, che si differenziano e a volte si contrappongono piú in ragione del metodo che non dei presupposti intellettuali e culturali.
1.L’indagine coerentemente storica.
Nel 1985 Ed Parish Sanders, già noto per un importante studio comparativo dedicato al confronto tra Paolo e il giudaismo palestinese118 , pubblicava una voluminosa ricerca che già nel titolo, Gesú e il giudaismo, segnala la novità dell’impostazione. Lo scopo dichiarato è infatti di indagare quale sia stato «l’intento di Gesú e di conseguenza quali siano state le relazioni da lui avute con i suoi contemporanei all’interno del giudaismo»119 . In tal modo l’interesse era decisamente spostato dal dibattito sul significato che il Gesú storico ha avuto per la fede cristiana, alla costruzione di ipotesi criticamente vagliate in grado di condurre a una convincente spiegazione di alcuni tra i principali problemi relativamente alla sua attività pubblica, e a quanto ne conseguí soprattutto per ciò che concerne la nascita di un movimento destinato a separarsi dal giudaismo.
Sanders sviluppava in realtà una linea di tendenza emersa già da qualche tempo e che contava di porre su piú solide basi metodologiche120 . Perciò dedica molto spazio a definire l’oggetto di studio e i procedimenti piú sicuri per pervenire a risultati convincenti. La novità sta nel convincimento che, diversamente da quanto si era a lungo pensato, sussistano le condizioni per uno studio storico del ministero di Gesú e che ormai occorra affrontarlo senza alcuna considerazione per la problematica teologica. Ma questo comportava superare il presupposto critico, ampiamente condiviso, secondo il quale lo stato delle fonti, principalmente interessate all’attualizzazione dei fatti in funzione dell’annuncio cristiano, è tale da impedire un accesso diretto al Gesú terreno. L’obiezione di Sanders è che può sempre essere cambiato il modo di porre importanti domande su Gesú, nonché il modo di utilizzare il materiale dei Vangeli, ampliato, in una certa misura, con il ricorso alla letteratura giudaica121 . Diventava pertanto prioritario reimpostare metodologicamente lo studio dei fatti relativi a Gesú per comprenderne il significato nel loro contesto storico, e quindi formulare ipotesi in grado di stabilire saldi legami tra la sua attività pubblica, la condanna a morte e il sorgere del movimento cristiano.
Il modo migliore per trarre profitto dal materiale evangelico è, per Sanders, quello di rovesciare il ruolo predominante di cui avevano fin lí goduto negli studi i detti attribuiti a Gesú, posto che «l’enorme lavoro, svolto per generazioni, al fine d’indagare il materiale d’insegnamento contenuto nei Vangeli non ha prodotto un convincente ritratto storico di Gesú». L’alternativa consisterebbe allora nell’occuparsi innanzitutto dei «fatti», cioè dell’attività pubblica e delle conseguenze di questa, «che sono entrambe molto salde e sono tali da indicare soluzioni di problemi storici»122 . Solo successivamente saranno recuperati i detti ritenuti probabilmente autentici, nella misura in cui possono essere inseriti in un contesto sicuro123 . È dunque la definizione del contesto ad assumere importanza decisiva per lo svolgimento della ricerca e ad esso lo storico deve applicarsi, ricorrendo ai fatti pressoché indiscutibili relativi alla vita pubblica di Gesú, all’esito della sua vicenda e del suo insegnamento dopo la morte, nonché alla conoscenza del giudaismo del I secolo.
Ma a quale fatto della vita di Gesú attribuire la priorità, in modo che partendo da esso sia possibile tracciare una ragionevole linea di sviluppo che giunga fino alla condanna a morte e a ciò che ne conseguí? Diversamente da Morton Smith, che aveva impostato la sua indagine a partire dai miracoli, nel convincimento di arrivare cosí a comprendere il resto della tradizione su Gesú, Sanders ritiene che occorra individuare un fatto della sua vita pubblica che corrisponda meglio al contesto generale in cui è vissuto. Ebbene, tale contesto è, a suo avviso, l’escatologia giudaica e il fatto, sicuramente autentico, da cui iniziare è la controversia sul tempio, in cui Gesú assunse una posizione gravida di conseguenze. Si tratta evidentemente di un’ipotesi, la cui validità va verificata sulla capacità di fornire risposte convincenti ad alcune rilevanti questioni storiche strettamente legate tra loro.
Preso atto che Gesú visse in tutto e per tutto da ebreo, si tratta di chiarire per un verso il suo atteggiamento nei confronti dei contemporanei, superando la radicata «propensione a considerarlo tanto superiore ad essi da essere privato di un contesto vivente all’interno del giudaismo»124 , e per altro verso di comprendere se la rottura col giudaismo del movimento da lui nato vada attribuita soltanto alla successiva proclamazione di Gesú come Cristo e Signore, oppure «esista una connessione piú che accidentale tra l’opera stessa di Gesú e la comparsa della chiesa cristiana», nel qual caso si potrebbe «tracciare una linea che vada dall’intento di Gesú a quello dei suoi seguaci dopo la sua morte»125 . Infine, ma è la questione centrale, l’ipotesi in campo deve mettere in grado di stabilire una connessione causale tra l’attività di Gesú e la sua morte violenta; cosa possibile nella misura in cui sarà stabilita una connessione ragionevole di Gesú sia con i propri contemporanei sia con il movimento da lui nato126 .
Non è qui il caso di riferire nel dettaglio gli esiti di una siffatta indagine127 , a cui va riconosciuto quanto meno il merito di aver restituito centralità all’attesa escatologica di Gesú e del suo movimento iscrivendola nella «struttura generale dell’escatologia della restaurazione giudaica»128 , vale a dire dell’attesa di un radicale rinnovamento, molto diffusa nel I secolo, che avrebbe dovuto condurre all’instaurazione da parte di Dio di una nuova Gerusalemme e di un nuovo tempio dopo la distruzione di quello attuale. Il Gesú di Sanders non fu pertanto un riformatore religioso, che si sarebbe opposto in modo piú o meno radicale al giudaismo del suo tempo facendosi portatore di una concezione religiosa opposta al formalismo legalista, e perciò spiritualmente e moralmente superiore. Una siffatta concezione avrebbe trasformato la proclamazione del Regno imminente in una verità atemporale, estranea all’aspettativa concreta di coloro a cui era rivolta, né consentirebbe a noi di spiegare perché Gesú sarebbe stato perseguitato e messo a morte, se non in forza di un equivoco circa le sue effettive intenzioni o per ragioni meramente contingenti129 . In realtà egli non fu giustiziato per aver guarito di sabato o per aver preteso di perdonare i peccati o per aver criticato qualche punto della legge o per aver attaccato il formalismo dei Farisei e cosí via, tanto meno per aver fatto o detto qualcosa che potesse suscitare nei Romani il sospetto di velleità insurrezionali. Se Pilato lo condannò a morte come «re dei Giudei» lo fece in modo derisorio contro le autorità che glielo avevano consegnato, le quali erano invece consapevoli che il significato eversivo di quel titolo stava nella sua connotazione religiosa, nella misura in cui avrebbe potuto indurre il popolo a credere che stava per instaurarsi un regno di cui Gesú sarebbe stato il re Messia.
page_no="71" Ma aldilà dell’importante contributo storiografico, dello studio di Sanders va qui rilevato il segno chiarissimo di discontinuità portato nella ricerca sul Gesú storico. È stato giustamente osservato come la sua ricostruzione finisca con il riallacciarsi al paradigma messo in campo da Reimarus e in parte ripreso da Schweitzer, tendente a fare di Gesú un predicatore escatologico che si era riconosciuto quale Messia e, in quanto tale, adeguatamente leggibile all’interno del giudaismo contemporaneo, senza bisogno di ricorrere alle successive interpretazioni cristiane130 . In tal modo tutta una lunga e complessa fase della ricerca su Gesú era dichiarata estranea allo studio storico vero e proprio; per dirla con le secche parole di Sanders stesso, il dibattito sul significato del Gesú storico per la teologia ormai non dovrebbe avere per lo storico altro interesse che quello che si può rivolgere «a qualcosa che un tempo si ritenne affascinante»131 . Viene di conseguenza meno ogni preoccupazione dello studioso circa la propria collocazione rispetto all’una o all’altra tradizione o scuola esegetica, conta soltanto il modo con cui sono poste serie e importanti domande su Gesú e il modo migliore di utilizzare le fonti che lo concernono132 .
Ora, che la critica storica si applichi, libera da preoccupazioni teologiche, a tentare di chiarire almeno le questioni piú rilevanti per la comprensione di quello che poté essere l’intento di Gesú e il ruolo da lui svolto all’interno del giudaismo del suo tempo, e che a tal fine si tenti una nuova utilizzazione delle fonti evangeliche, interrogate su problemi storici nel contesto della storia giudaica coeva, tutto questo costituisce indubbiamente un progresso per la ricerca, nella misura in cui si pone il compito circoscritto di conoscere quel che Gesú volle compiere e di ciò che ne conseguí, e insieme fa piazza pulita di tanti radicati convincimenti circa la superiorità del suo insegnamento rispetto a quello della tradizione giudaica. Sanders osserva giustamente che gli studi su Gesú di scuola tedesca tendono, eccetto quello di Schweitzer, a esaltare il contrasto tra Gesú e i maestri ebrei133 , rappresentati come portatori di una tradizione teologica ormai sterile, senza peraltro fondarsi su un serio studio del giudaismo; con la conseguenza «di proiettare all’indietro, nel pensiero di Gesú, la teologia cristiana»134 , mancando del resto un effettivo interesse per spiegazioni storicamente credibili.
Dunque, il primo obiettivo della ricerca recente su Gesú, impostata da lavori come quello di Sanders, è stato di liberarla dalla presa dell’interesse teologico. Un passo decisivo, a seguito del quale l’intera questione subiva un drastico ridimensionamento, approdando sul terreno, ritenuto piú s...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- Indice
- Premessa
- Tra ricerca e divulgazione
- Il Gesú terreno e il Cristo della fede
- Il nuovo Gesú storico
- Un compito critico
- Bibliografia
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Il Gesù moderno di Giancarlo Gaeta in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Teologia e religione e Cristianesimo. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.