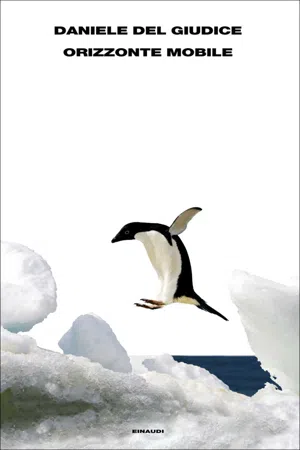Vorresti gridare subito la tua storia, vorresti dire «Talvolta credi di commettere tutti gli errori passati e futuri», oppure «Ogni uomo porta in se stesso una camera», oppure «Se potessi capire come mai è finita cosí», in bilico sopra un filo, un fuso, ma se è vero che ogni uomo ha in se stesso una camera, la tua è tutta in disordine, sul comò si ammucchiano vecchie fotografie, e tu penseresti «È impossibile ricordare tutto», invocheresti la distrazione perché è la sola che scampa al dolore, e intanto in una scatola nell’armadio di cucina c’è un uovo di pinguino, bucato e svuotato dal bianco e dal tuorlo, riportato dal Sud piú profondo, il piú profondo e radicale dei Sud, un gelido Meridione. O forse sta per uscire il tuo numero, qualcuno dice «Sai, il mio numero sta per uscire, lo sento, lo so, sono usciti i numeri di tutti quelli che conoscevo», e ognuno vedendo la pallina fermarsi nella fossetta non ha nemmeno aspettato che il croupier lo annunciasse ad alta voce, si è alzato e si è incamminato verso la porta, col suo numero scritto sulle spalle, come un atleta al termine della gara, uno di quelli che non solo non arrivano primi ma la corsa la finiscono prima della fine. Ecco, vorresti gridare subito un grumo di dolore, o di gioia, che non si articola in parole ordinate, ma tutte insieme, esplose come esplode una stella, e c’è un silenzio attonito e glaciale, e dov’è la calma allora, dov’è la tua calma, dov’è il governo, dove la composta malinconia dell’imperscrutabile capitano, un po’ distratto, un po’ silenzioso, colui che tiene le fila, un uomo sui fili che ha voluto tendersi da sé?
I fili sono trecentosessanta, ma ventiquattro contano piú degli altri, dodici verso destra e dodici verso sinistra, e da qui potrei cominciare, ma cominciare significa decidere un prima e un dopo, dare un ordine, isolare dal flusso, rompere la simultaneità, uscire dalla compresenza, fare come se esistesse una frase alla volta, un’immagine alla volta, un pensiero o un ricordo o un racconto alla volta, uno e poi uno e poi uno, e non tutto insieme. Sforzati di restare in questo disordine, di aderire ad esso, ma non è facile e non sempre è possibile, non sempre ci riesco. In questo istante, in questo preciso istante, potrei essere l’uomo che controlla gli orologi nel turno di notte, un vecchio signore chiuso nell’osservatorio di Greenwich, dove ha trascorso gran parte delle notti della sua vita, in una notte come tante altre, non un guardiano del faro ma un guardiano del tempo, poiché qui dentro non c’è una lanterna che gira, girano solo i meccanismi degli orologi, ventiquattro orologi in fila, ciascuno sfalsato di un’ora, un’ora a crescere verso est dove il sole cresce, un’ora a calare verso ovest dove il sole cala. Ogni orologio un fuso, ogni fuso un filo, lungo i fusi le storie colano giú, colano fino a te che nel frattempo sei già arrivato laggiú a guardarle dal di sotto.
Per sua natura, la Storia non è che scrittura in una forma diversa.
Base Amundsen-Scott, 90° 00′ sud e 139° 16′ ovest, prima settimana dell’estate australe, 2007.
In un alone verde azzurrino spiritato, la luce che qui costituisce la sera, piccole bande di pinguini Adélie passano veloci. Vanno nella direzione opposta al mare. Viaggiano verso sud con una fretta disperata, le pinne natatorie sollevate, il muso sporto in avanti, i piedini di qua e di là, bilanciati con la coda come treppiedi. La loro aria intenta e preoccupata, terribilmente comica per me, sembra dire «I’m late, I’m late, for a very important date», come nel libro di Alice, o piú semplicemente «Non possiamo fermarci adesso, c’è troppo da fare». Li ho seguiti con lo sguardo finché sono diventati dei puntini traballanti sulla distesa bianca, poi senza motivo apparente hanno effettuato una curva ampia, e senza mutare d’affanno sono tornati indietro. I primi ad arrivare qui si sono lasciati cadere sulla pancia, scivolando come un toboga fino a fermarsi. Hanno chiuso gli occhi celesti, si sono addormentati. Del creato fanno parte anche questi esseri la cui natura lo stupore, la fiducia in un ordine delle cose che mai sarà alterato, un ragionare perfettamente logico perché totalmente astratto, e una divorante curiosità: esposti dunque ai peggiori contrattempi. È stato opportuno da parte del buon Dio sistemarli quaggiú in Antartide, poiché alle nostre latitudini avrebbero già preso il potere in nome delle forze del Bene e dell’Ilarità, o sarebbero stati sterminati. Ma che i pinguini fossero animali pieni di preoccupazioni lo sapevo già da prima.
Sono arrivato con una missione di biologia marina di cui fa parte Jeremy Miller, un gallese di Cardiff che si occupa dei Gentoo, i pinguini piú alti tra quelli di taglia piccola. I pinguini Gentoo valutano ogni passo prima di fare un saltino da una pietra all’altra. Considerano intensamente la pietra successiva: se è levigata o ruvida, se umida o asciutta, con muschio o senza, e quando l’approdo è stato valutato nei dettagli si raccolgono in un’espressione finale da «Cosa sarà di me!», aprono le natatorie e fanno il salto, pochi centimetri, arrivando leggermente sbilanciati, stupiti di essere ancora in piedi. Molti anni fa, nel mio primo viaggio in Antartide, ero venuto qui accompagnando un’altra missione che lavorava con i pinguini Adélie, dei veri acrobati al confronto: schizzavano fuori dal mare come pupazzi a molla, perfettamente eretti, e atterravano sulla banchisa un paio di metri piú in alto. Non sempre atterravano, qualche volta si impiantavano contro la parete bianca ed eretti ricadevano in acqua, sbucando nuovamente fuori senza perdere contegno, sbattendo e ricadendo e risaltando, finché ci riuscivano.
I pinguini sono ovunque, non c’è bisogno di cercarli, con Jeremy li incontriamo spostandoci da una base all’altra, mentre camminiamo presi ognuno dalle sue preoccupazioni, il tempo meteorologico, la direzione giusta da seguire. Una mattina ci apparve lontano una rookery affollatissima e qualcuno di questi uccelli isolati. Trovammo due adulti e uno piú piccolo sulla riva del mare. Ci furono curiosità reciproche e convenevoli finché i due adulti si tuffarono in acqua, scomparendo. Tra tutte le espressioni di cui i pinguini sono capaci quella della desolazione è irresistibile, poiché è una desolazione senza rimedio. L’animale piccolo, il pulcino rimasto solo, cominciò a gridare camminando lungo la riva, guardando in ogni direzione. I pinguini vedono meglio nell’acqua, dove gli scende una seconda palpebra trasparente, una specie di lente a contatto naturale che li protegge dal salso e corregge la loro ipermetropia. Vedevo benissimo i suoi genitori, impettiti sulla riva un centinaio di metri piú avanti, e cercavo di indicarglieli ma lui incespicava sui sassi senza piú badarmi, con quell’aria affannata da «I’m late, I’m late», finché dovette convincersi che i suoi genitori erano partiti via mare lasciandolo lí: soltanto allora si voltò verso l’acqua e pieno di sconforto e disgusto si buttò. Ormai sapevo di cosa si trattava. La scena familiare cui avevo assistito era un momento fondamentale della crescita, quando il pinguino giovane viene obbligato a procurarsi da solo in mare il krill e il plancton di cui si nutre, che fino a un certo punto gli viene fornito come poltiglia rigurgitata dal becco dei genitori. Mi accorsi che stavo antropomorfizzando i pinguini, cosa che mi ero ripromesso di non fare, e ne parlai con Jeremy, meglio attenersi alle molte spiegazioni sui comportamenti dei pinguini di diverse specie che le spedizioni dei biologi osservavano e catalogavano. Il guaio delle storie, con i pinguini, è che sono narrate da un unico punto di vista, quello umano. Alla loro fantasia e curiosità, inesauribili, sovrapponiamo ciò che appartiene a noi, mutandone il senso.
Può darsi che anche i pinguini siano portati a pinguinomorfizzare gli umani, e questo certamente accadde qualche settimana dopo, quando in una traversata a piedi, mentre accompagnavo una missione internazionale di dieci biologi, incontrammo una carovana di Imperator, la specie piú grande. Loro, i pinguini in fila, noi, umani in fila. Due comunità egualmente in marcia, i pinguini dall’interno verso le coste per procurarsi cibo, noi dalle coste verso l’interno per raggiungere le regioni piú fredde abitate dagli Imperator. Loro, noi, vivevamo la stessa solitudine in un oceano di ghiacci e nevi, e le stesse preoccupazioni. Giunti a una rispettosa distanza il capo dei pinguini Imperator, un individuo voluminoso e importante della loro specie, allungò il collo verso di noi in un profondo inchino e con il becco contro il petto fece un lungo discorso gorgogliando. Finito il discorso, da quella posizione di riverenza fissò negli occhi Jacques, capo della missione, per vedere se aveva capito. Né Jacques, l’etologo piú esperto, né chiunque di noi poteva comprendere quel discorso. Allora il pinguino ripeté di nuovo il lungo gorgoglio con la testa china, senza spazientirsi. Chi si spazientiva erano gli altri pinguini dietro di lui, cominciavano a dubitare che il loro capo avesse combinato qualche pasticcio. Si fece avanti un altro di loro, spingendo da parte il suo predecessore. Con lo stesso inchino e lo stesso sguardo in alto tenne un nuovo discorso che sarebbe rimasto per noi altrettanto incomprensibile.
Ma la grande passione dei pinguini erano i cani. Se li scoprivano in una base antartica andavano a trovare solo loro, senza piú passare dagli uomini. Facevano molti inchini e lunghi discorsi, i cani seguivano abbaiando e schiacciandosi sulle zampe anteriori; poi qualcuno riusciva a sciogliersi dalla catena e succedeva un massacro. I pinguini guardavano i propri compagni morti con assoluto stupore, e con l’espressione da «Non m’importa cosa sarà di me» cercavano di parlare ancora ai cani, non fosse per gli uomini che intervenivano a salvarli. Del resto questi uccelli hanno una loro speciale idea della presenza e dell’assenza, come ebbi modo di constatare un giorno con un involontario esperimento. Mentre uno di loro tornava dall’acqua verso il suo posto nella rookery mi sono trovato sulla sua traiettoria; prima mi ha guardato stupito, poi ha cercato di attraversarmi come se non esistessi. Avanzava, urtava contro le mie gambe, faceva marcia indietro. Dopo un po’ ha cominciato a colpirmi con le pinne natatorie. A me veniva da ridere, ma i colpi erano velocissimi e facevano male. Dato che non mi spostavo, ha compiuto un giro completo della rookery, e io a mia volta ho fatto un passo aspettandolo sul lato opposto. Quando è arrivato e mi ha visto ancora lí aveva un’espressione di totale incredulità. Il suo ragionamento era ineccepibile: aveva fatto un giro intero, perciò io dovevo essere sparito, non potevo esserci ancora. Un giro completo vale un cambiamento delle cose, altrimenti che si gira a fare?
A forza di osservarli mi sono convinto che il segreto dei pinguini è nel loro essere al tempo stesso impeccabili e impacciati. Questi animali dotati di grazia e autoironia, virtú che attribuiamo alle specie piú evolute, sono in realtà dei grandi incompiuti. Non ce l’hanno fatta a diventare pesci, dato che l’acqua non è il loro elemento definitivo; pur essendo uccelli non volano piú, e come bipedi sono lenti e preoccupati. Rimasero bloccati in questa ambiguità in ere antichissime e da allora non sono cambiati piú. Ma nei ghiacci, nel vento ruggente, con i pinguini si finisce per perdere la testa. Soprattutto d’inverno, nella notte perenne, notte di notte e notte di giorno, buio totale, quel buio costante che scardina la mente, distrugge il sonno, inutile guardare l’orologio, tanto è sempre l’ora dello stesso buio.
E in una di quelle notti che non sono notti alla rookery di Cape Crozier nei sessanta gradi sotto zero, in pieno buio polare, andammo in cinque o sei a vedere la cova delle uova dei pinguini Imperator. Curiosamente la cova è compito dei maschi, non delle femmine. Per prendere le uova bisognava alzare di lato gli animali, che cercavano di trattenerle sdrucciolando a piedi uniti sul ghiaccio. C’era bufera e non si vedeva quasi niente. Jeremy scostò un pinguino, allungò la mano e sentí una cosa ovale e fredda. Era un uovo sí, ma di ghiaccio. Perfettamente modellato. Il pinguino s’era perso l’uovo, si vergognava, se n’era fatto uno finto. Jeremy e il pinguino si guardarono, sconvolto l’umano, mortificato l’animale, chissà se perché scoperto in quella sua struggente finzione o perché sapeva che gli sarebbe stata portata via anche quella.
Fu allora, in quel giorno-notte, che Jeremy con l’uovo di ghiaccio in mano scoppiò in lacrime, cominciò a gridare, si mise a correre, e piú correva e piú si spogliava, buttò via il berretto, buttò il giaccone termico, si tolse perfino la camicia di lana cotta e tutto il resto, piangendo e inciampando nei ‘sastrugi’, dune di ghiaccio formate dal vento. Lo rincorremmo, lo trovammo a terra quasi nudo. Gli sollevai la testa, gli misi addosso il mio giaccone, gli gridai nel vento «Sei pazzo, vuoi morire?» e nel vento Jeremy mi rispose «Tanto se muoio qui nemmeno Dio se ne accorgerà». Cercai di calmarlo, intanto qualcuno aprí la radio e chiamò i soccorsi. L’elicottero è arrivato presto, avevamo segnalato la nostra posizione con fiaccole incandescenti.
Nei giorni successivi Jeremy si è ripreso abbastanza in fretta, a dire il vero anche perché ha conosciuto una ricercatrice fisica italiana, Teresa Montaruli, impegnata nel gruppo di studio sulla neutrino-astronomia e il Progetto Nemo. Teresa gravita tra l’Università di Bari e quella di Madison, Wisconsin, e ci ha parlato dei nuovi orizzonti osservativi, stanno costruendo enormi infrastrutture per rivelare altri messaggeri dell’universo, i neutrini, particelle neutre e molto elusive perché risentono solo della ‘forza debole’, una delle forze fondamentali della materia; e quelle particelle, i neutrini, sono di carica nulla e hanno massa nulla o quasi nulla al contrario dei fotoni che interagiscono con la materia elettromagneticamente. I neutrini non sono assorbiti dalla materia e nemmeno deflessi dai campi magnetici, ed è per questo che portano informazioni sulle sorgenti che li hanno generati. A parte i neutrini emessi dal Sole e una manciata da una supernova, non sono mai stati osservati neutrini dal cosmo. Però, i neutrini hanno i loro telescopi, ‘telescopi di neutrini’, si chiamano cosí gli strumenti che servono a rivelarli. Non avevo saputo trattenermi: «Neutrini e pinguini!»
Teresa è gentile, e la sera dopo, a cena nel ristorante della base, nel punto piú basso del pianeta e nel ghiaccio piú avvolgente, ha cercato di tradurre il tutto per noi non in altri termini, piuttosto in concetti, ma non è stato facile. Ci ha spiegato con pazienza che se le sorgenti accelerassero non solo elettroni ma anche protoni, la produzione dei neutrini insieme ai fotoni sarebbe garantita; e che i neutrini potrebbero prodursi anche grazie all’annichilazione della materia oscura che la forza di gravità accumula al centro del Sole o della Terra, o al centro della galassia. Teresa indicava i neutrini con le sue belle mani quasi fossero lí presenti, Jeremy ascoltava e anch’io ascoltavo, le misure planetarie mi facevano venire in mente Robert Sheckley e i confini tra il genere e la letteratura consueta. Questa materia oscura, ha ripreso Teresa, sarebbe costituita da nuove particelle, ‘particelle massicce debolmente interagenti’ o WIMP, previste dai modelli elaborati per estendere la teoria che oggi impieghiamo per descrivere la materia. E comporterebbe l’unificazione di tutte le forze: ha ricordato la ‘supersimmetria’ e le teorie extradimensionali, che contemplano altre dimensioni dopo le tre spaziali e quella temporale.
Qualche volta tra scienza esatta e phantāsia può avvenire una collusione, ma il fisico non deve abbandonare la severità della sua disciplina. Teresa si è trattenuta un po’, poi ha continuato: «Per la rivelazione dei neutrini occorre dotare di strumenti idonei spazi molto grandi, e contrastare cosí la bassa probabilità di interazione con la materia che è tipica delle WIMP. Per questo è impossibile realizzare i telescopi di neutrini in gallerie sotto le montagne. La ricerca di eventi rari richiede lo schermo di grossi strati. Migliaia di metri sotto il mare oppure sotto i ghiacci polari».
«Nei prossimi anni la comunità scientifica europea dovrebbe costruire un rivelatore delle dimensioni di un chilometro cubo, e presto sarà installata una torre prototipo molto alta proprio in Italia, a Capo Passero, per le buone caratteristiche dell’acqua e del mare. Ci aspettiamo grandi cose dagli osservatori di neutrini nel Mediterraneo, perché contrariamente a quelli del Polo Sud avranno l’opportunità di osservare il centro della nostra galassia. Qui in Antarti de hanno iniziato a costruire l’IceCube Neutrino Detector immergendo dei sensori nel ghiaccio, in pozzi verticali, con un trapano a forma di cono che spruzza acqua calda. I dati raccolti aiuteranno a comprendere i raggi cosmici, nel piú profondo dei ghiacci si lavora per le galassie e per le supernove. È come guardare le stelle nel pozzo».
Siamo nella base McMurdo, detta cosí dal nome del tenente americano che cartografò la zona nel 1841, ma io preferisco chiamarla con l’altro nome, base Amundsen-Scott, dai due esploratori che giunsero qui per primi nella corsa verso il Polo Sud geografico, con vantaggio di Amundsen e dolorosa tragedia per Scott e la sua spedizione. Certo non saprei ripetere alla lettera le parole di Teresa e a volte non c’è modo di tradurre il vocabolario della fisica, non sempre si hanno i verbi per raccontarla. E se devo essere sincero mentre parlava mi sono distratto perché ho ripensato al mio primo viaggio verso l’Antartide. È trascorsa una certa quantità di tempo ma lo ricordo perfettamente, quella volta non ero arrivato dalla Nuova Zelanda, come sarebbe stato piú semplice, ma dal Cile, da Santiago.
Mi imbarcai sul grosso Jumbo verso le nove di sera, e attorno a mezzanotte crollai dal sonno, notte e sonno continuamente interrotti e sofferenti, per la posizione e la sensazione di trasporto. Al risveglio nell’aereo c’era ancora buio e silenzio, cercai di lavarmi come potevo, per la prima volta scoprii di avere i piedi gonfi. Poi di nuovo le luci accese, e dei neonati che si lamentavano piano. È curioso come i neonati sopportino bene i lunghi viaggi in aereo: a parte un pianto disperato la sera prima, durante la notte avevano sempre dormito tranquillamente. Dai finestrini era spuntato un filo tenerissimo di azzurro appena distinguibile dal nero delle nubi, e all’alba la discesa su Rio de Janeiro. Riconoscevo nell’ampio giro di avvicinamento la baia e la città e il Pan di Zucchero. Poi una sosta di circa un’ora senza uscire dall’aeroporto. Al di là della lunga vetrata si vedevano le piste, le colline e la città in un’immagine lunga e stretta, colorata dei colori contrastati e netti dell’alba e del primissimo mattino. Erano le sei, ora di Rio.
Non rimisi ancora l’orologio, non sapevo bene cosa fare con le quattro ore di differenza, la posizione del sole imponeva il suo ritmo alla giornata e l’orologio ne imponeva un altro. Rimettendolo indietro mi sembrava di cancellare quelle quattro ore, le avevo vissute certamente ma il semplice gesto di ruotare le lancette le faceva sparire, quattro ore venivano espunte dalla mia vita come se non le avessi mai vissute. E quali ore espungere: quelle della partenza da Francoforte quando il comandante aveva comunicato nell’interfono la rotta di viaggio dando per l’arrivo a Rio de Janeiro la previsione meteo, la temperatura, e anche l’ora di Rio? Come dire: l’orologio potete rimetterlo anche adesso, tanto dormirete, tanto passerà una notte e quando vi sveglierete l’ora non sarà piú la stessa. Potevo cancellare i momenti piú disagevoli di quella notte, che so, quando quel bambino qualche fila piú avanti aveva pianto istericamente. O quelle del sonno, piú facili da sottrarre allo scorrimento della vita. Potevo eliminarle in blocco, uno stock di quattro ore filate con tutto il male che hanno dentro o sceglierne alcune per un totale di quattro. Un pilota di linea per mestiere di queste cancellazioni di tempo deve subirne tante, ma anche tante aggiunte, quando vola verso est, aggiunte di tempo che non ha mai vissuto: alla fine sarà piú vecchio? sarà piú giovane?
Mi era dispiaciuto, partendo da Rio, non avere un posto accanto al finestrino e nemmeno la macchina fotografica carica. L’aereo ha costeggiato ...