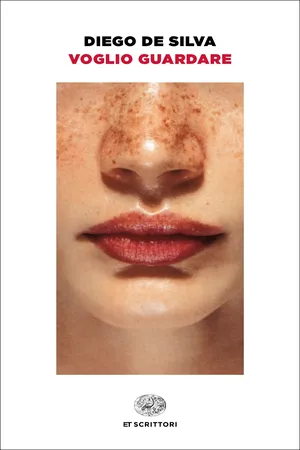Il litorale odora di ristoranti e di appena bruciato. Si contano le macchine, alle quattro di pomeriggio. Il mare è là ma non si sente. Sui cartelloni della pubblicità è pieno di occhi azzurri e denti dritti e cosce accavallate.
Sotto il manifesto di una radio locale – una faccia di femmina coperta da grandi occhiali scuri che sfiora la manopola della sintonia con le labbra socchiuse – Celeste aspetta.
Ha sedici anni e un corpo qualsiasi. Né bassa né magra. Porta spesso una bandana, in cui nasconde i capelli. Mai gonne, mai cappotti. Non si trucca, tranne un po’ di ombretto. Fa il terzo scientifico.
Oggi guarda in alto. La conosce, questa tinta del cielo. Sta per piovere, e sporco. Quell’acqua marcia che macchia i vestiti come varechina, e lascia sulle macchine una sabbiolina marrone che appiccica (spesso vedi la gente che prima di partire pulisce il vetro con un fazzoletto di carta, ché il tergicristallo farebbe solo peggio).
Celeste odora l’aria, la guarda, tira fuori la lingua e l’assaggia, con un dito si tasta prima una guancia e poi l’altra, come se dall’aderenza dell’umidità a quella zona della pelle potesse calcolare quanto manca alla caduta della pioggia.
Non si ferma mai a pensare a cose come queste. Se hanno fondamento, senso. Le fa. Non le ha imparate da nessuno. Non le ha mai dette a nessuno.
Si passa ancora l’indice sulla faccia, arriva fin sotto gli occhi, poi si guarda il polpastrello, lo strofina delicatamente contro quello del pollice come analizzasse una traccia, mescolasse gli elementi di un qualche tipo di materia. Stima con sufficiente approssimazione che farebbe in tempo a rientrare. Abita vicino, del resto. Però non ha voglia. Fa scivolare lo zainetto Invicta lungo il fianco, fino al marciapiede, poi ci si siede sopra senza cura. Porta le ginocchia sotto il mento e le cinge con le braccia. Con le punte dei piedi batte un tempo alternato senza musica.
La Uno verde, è la seconda volta che passa. Il tipo dentro sta sudando di vergogna, ancora combatte con la dignità e insiste senza decidersi. Lo sa, eccome se lo sa, che ormai si vede. Ancora meglio sa che piú continua e peggio è. Guida che pare abbia il freno a mano tirato. Il rossore gli è arrivato alla fronte, e manco la fa finita. Passa ancora vicino a Celeste, neanche rallenta, le butta l’occhio un attimo e continua, come uno stronzo.
Celeste lo segue con la testa mentre il motore scoppietta. Quello la guarda nello specchio retrovisore. Ha un’espressione repressa, infelice. Ma ti vedi, pensa Celeste. Adesso per tornare ti devi fare la galleria, tutto il traffico dall’altra parte e mezza litoranea al contrario. Bene che ti va ci metti altri venti minuti, mezz’ora.
Aveva il parrucchino, dice Celeste. E riprende a battere il tempo con i piedi. Stavolta canta.
Inizia a piovere. Celeste si annoda meglio la bandana. Sono solo poche gocce, starà seduta ancora un po’, poi andrà a mettersi sotto la gabbietta dei pullman. Si solleva il bavero del giubbotto di jeans, si abbottona davanti.
Passa un’altra macchina. È giovane questo qua, sa di pulito, di tennis, ha capelli vaporosi, il maglioncino di filo senza camicia, quei corpi vestiti sempre con pochissimo, quei corpi per cui è sempre primavera, occhi che distinguono e preferiscono. La macchina è vecchiotta, ma come lui ha addosso quel tanto di vissuto che si fa osservare (Celeste se l’immagina d’estate, con la sabbia sui sedili, in doppia fila davanti a un bar coi tavoli all’aperto a sera tardi, ad aspettare il raduno di giovani che si accordano su dove andare).
Le passa accanto. La guarda con una tale insistenza da far pensare che le chiederebbe addirittura spiegazioni, se fosse a piedi.
Celeste sorride senza restituirgli gli occhi. È abituata a questo tipo di incredulità. Non si fanno capaci. È solo quando l’hanno superata, quando è tardi, che capiscono. E poi li riconosce, quando tornano.
Quante volte Celeste ne ha scorto da lontano, nel chiuso della macchina che se ne andava, il puntuale no-no con la testa, rassegnazione impotente e condanna insieme.
Si rimette in piedi mentre la pioggia s’infittisce. Chissà che fa prima a prenderne uno che ad arrivare sotto la tettoia del pullman. Chiama lei, col pollice.
Il primo che passa manco s’accorge. Tiene tutt’e due le mani sul volante e gli occhi strettissimi. Farà fatica a vedere, con la pioggia fine.
La macchina successiva è una donna.
Il terzo la guarda con il solito stupore.
Quello dopo accosta.
– Ho capito bene? – chiede abbassando il finestrino.
Celeste, le mani nelle tasche del giubbotto, si china in avanti col busto e lo valuta. Aspettando la sua risposta, lui muove la testa in direzione di lei come faticasse a metterla a fuoco.
Avrà qualcosa piú di cinquant’anni, la cravatta che gli fa scalino sulla pancia, mani grassocce, il solito imbarazzo sul sorriso, ma è ben vestito.
Pulito, d’aspetto.
Educato, da come ha chiesto.
E la moquette della macchina odora di nuovo.
La bambina corre sfrenata tra i singhiozzi lungo il corridoio della casa con i muri altissimi. Fugge come da un solletico, da un’emozione che si fa tanto piú incombente quanto piú lei gioca ad allontanarsene. Scalpita e squittisce, si lancia esageratamente in avanti con le braccia morte schiaffeggiando l’aria, istintivamente consapevole del ruzzolone che rischia eppure eccitata fino all’ebbrezza dal suo stesso moto incoerente.
Dall’imbocco del corridoio, l’uomo la guarda.
La bambina butta la testa all’indietro, valuta la distanza che li separa, lo guarda a propria volta come a ricordargli le condizioni della caccia. Gli sorride, si blocca. Stringe i pugni, li morde, riprende la corsa.
L’uomo sta ai patti.
Verso il tinello, il corridoio si stringe a imbuto formando un angolino appena illuminato dalla luce ingiallita dalle tende della finestra. La bambina cade in avanti continuando a singhiozzare. Rinuncia a rialzarsi ed entra carponi nella stanza. È bello il verso che fa, sillabe amusicali, tutte rumore e saliva.
L’uomo cammina.
La stanza è divisa al centro da un divano a tre posti e due poltrone davanti: di là zona pranzo (tavolo, sedie e piccola dispensa), di qua conversazione. La bambina si accuccia dietro lo schienale del divano.
L’uomo arriva, calcando attentamente i passi. In ginocchio, la bambina stringe i pugni sotto il mento e soffoca una risata. Accentuando il rumore di ogni movimento, l’uomo fruga dappertutto. Dietro le tende, la porta, intorno al televisore, sotto il tappeto. Finalmente si avvicina al divano, guardandosi bene dall’affacciarsi allo schienale. La bambina si tappa la bocca con le mani. L’uomo toglie i cuscini dal divano, chiama la bambina per nome, le domanda dove s’è ficcata. Una volta. Due. Tre. Poi dichiara la resa.
La bambina sbuca dal suo nascondiglio con un urlo felice, come un giocattolo a molla compresso in una scatola. L’uomo fa la faccia sbalordita, si posa le mani sui fianchi, da perdente, piega la testa su una spalla, solleva le sopracciglia e gli angoli della bocca. La bambina dà manate alla spalliera del divano, saltellando sul posto. Poi fa il giro e si tuffa sull’uomo, abbracciandolo alla vita. Lui s’inginocchia e le posa le mani sulle spalle. La bambina gli lega la testa con le braccia. L’uomo sente il respiro della bambina perdere progressivamente l’affanno. Le bacia la fronte e la testa. Le accarezza la schiena, poi chiude le braccia intorno a lei.
Il fiato della bambina aumenta appena. Toglie le mani dalla testa dell’uomo e prova a muoversi. Ci riesce, ma dopo un attimo. Non la naturale linearità di un atto libero, da qui a lí, com’è abituata; ma l’ambigua sensazione del ritardo, dell’impedimento, del metodo di un’intenzione subdola, immediatamente occultata. L’assale una paura mai sentita, che si liquefà immediatamente e le annega gli occhi. Cerca la faccia dell’uomo. Lui le sorride, ma gli tremano le labbra. La bambina lo guarda con colpa, come a voler chiedere scusa di qualcosa che non le sembra di aver fatto. L’uomo le serra un braccio dietro la schiena, le afferra i capelli con l’altra mano. La bambina non tenta di liberarsi, anzi si affida, accettando il merito di una punizione che nemmeno capisce. L’uomo trattiene e strappa. Un’unica manovra di due atti volti in direzione opposta. È immediato, competente.
Il rumore del collo che si spezza pare lo scoppio di una corda tesa. Ma è peggio lo scricchiolio che segue, un suono delicato, inerme.
L’uomo si morde le labbra. L’improvvisa leggerezza di quel corpo finalmente privato di tensione gli dà sollievo. Distende la bambina sui cuscini del divano, le accarezza la fronte, le guarda gli occhi ancora stupiti di orrore. Si rialza. Esce dalla stanza, riattraversa il corridoio, va in cucina. Si lava le mani nell’acquaio usando del detergente da stoviglie. Si asciuga con un foglio di carta da rotolo, lo appallottola, lo getta nel cestino dei rifiuti sotto l’acquaio. Mette sul fuoco una caffettiera già carica. Si siede al tavolo e aspetta, la testa bassa, come di vergogna. Poco dopo si alza, apre due ante della dispensa pensile, zucchera abbondantemente una tazzina vuota. Versa il caffè che intanto ha raggiunto l’orlo della macchinetta. Lo beve d’un fiato, con un colpo secco del capo all’indietro e una fatica lacrimosa negli occhi, da pellicano che ingoi un pesce piú impegnativo di altri. Sente il bruciore e lo approva, aspettando che la sua stretta si allenti. Sciacqua la tazzina nell’acquaio, l’asciuga, la rimette nella dispensa. Senza guardare, apre lo stipo basso dell’acquaio, tende la mano verso il contenitore dei sacchetti di plastica avvitato alla facciata interna dell’anta, tira fuori una busta nera da immondizia, la comprime alla meno peggio, se l’infila in una tasca dei pantaloni. Poi torna nel tinello.
La bambina è dove l’ha lasciata, le braccia scivolate in direzione del pavimento, le mani dischiuse, come nella pantomima di un parto, di una salvezza. L’uomo la prende sulle braccia, la porta in camera da letto, la distende sulle lenzuola, la spoglia, si spoglia. Piega con cura i vestiti e la biancheria suoi e della bambina, li infila nella busta di plastica nera che tira fuori dalla tasca. Posa la busta sul pavimento. Va nella stanza da bagno accanto. Apre il rubinetto della vasca. Da un armadietto a due ante prende un paio di forbicine, un flacone di borotalco e dei guanti di plastica in politene, da analisi. Poggia il flacone e i guanti sul bordo del lavandino. Si taglia le unghie delle mani. Le raccoglie in due fogli di carta igienica ripiegati, butta nel cesso la pallottola di carta e scarica. S’infila i guanti. Torna in camera da letto. Prende la bambina in braccio muovendosi lentamente, come per paura di svegliarla. Le tiene le braccia in modo che non penzolino. La porta nel bagno. La immerge nell’acqua della vasca. Chiude il rubinetto. Torna in camera da letto. Dal cassettone prende un asciugamano grande, un phon, un pennarello indelebile. Torna in bagno. S’inginocchia accanto alla vasca. Stende l’asciugamano sul pavimento. Tira fuori il cadavere dall’acqua. Lo avvolge nell’asciugamano e con quello lo tampona dalla testa ai piedi. Lo rivolta e ripete l’operazione sul dorso. Fa scaricare l’acqua della vasca, risciacqua attentamente la ceramica servendosi del telefono della doccia. Riprende le forbicine, taglia le unghie delle mani della bambina e le scarica nel water secondo la stessa procedura usata per le proprie. Inserisce il cavo del phon nella presa della corrente. Asciuga la bambina e la cosparge di borotalco, lasciandole soltanto una piccola zona scoperta, un ovale, sul petto. Stappa il pennarello indelebile e lí, un po’ in stampatello un po’ no, scrive un nome.
A cavalcioni del cliente, Celeste batte la testa contro il soffitto dell’auto per la terza volta.
– E piano, cazzo! – Si blocca puntellandosi con le mani sulle spalle di lui, dimostrandogli che le basterebbe muoversi tanto cosí per farlo uscire. Poi lo guarda con severità.
– Scusa, – sussurra quello, completamente in suo potere. Poi aspetta che sia lei a riprendere. E lei riprende, a occhi chiusi, contorcendosi e ansimando senza mai aprire la bocca, come le piacesse da morire. Chi lo sa, se le piace.
Il cliente la tiene per la vita, segue quella specie di danza con la bocca insalivata, la faccia stravolta.
Celeste non apre gli occhi eppure sorride come se lo sapesse, come lo stesse guardando mentre le si annulla fra le gambe. E questa consapevolezza l’appaga, la fortifica. È bello pensare che quest’uomo tornerà a casa con una crepa nella vita.
Gli scompiglia i pochi capelli che gli sono rimasti e lo bacia. Il cliente spalanca gli occhi con meraviglia mentre la lingua della ragazzina si avvinghia alla sua, la punzecchia, la percorre e l’accartoccia con fame da innamorata.
Celeste bacia. La trova perbene, la negazione della lingua in bocca.
Il cliente l’avverte che sta per venire.
– Lo so, – fa Celeste.
– E tu? – dice lui.
– Non ti preoccupare, – dice Celeste («Gentile», pensa).
L’uomo eiacula, tarantolato dallo stupore di un orgasmo che quasi lo addolora. Sorride a Celeste che segue con un broncio pieno di sesso i sussulti del suo corpo e ancora non crede che questa ragazzina qualunque, senza un rossetto, un lucidalabbra, un tacco, una...