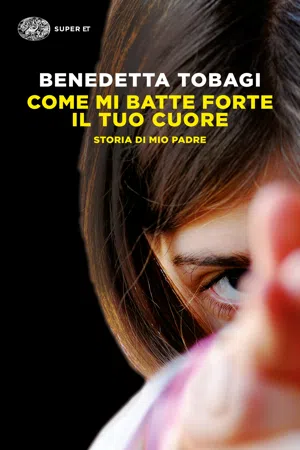![]()
1. In principio era il vuoto
– Che cos’hai?
– Mancanza.
WIM WENDERS, Il cielo sopra Berlino.
– Mi perdoni la domanda, ma lei…
– Forse non lo sa, ma ha un cognome illustre…
– Tobagi? Come il giornalista?
– Lei è per caso parente?
– Quel Tobagi?
Sí.
Sí,era mio padre.
Sí. Sí. Sí. Sono la figlia. La piú piccola.
Sí, è passato molto tempo. Avevo tre anni e mezzo.
– Allora non ti ricorderai nulla.
(Quasi nulla. La morte non si può dimenticare. Ma la gente che ne sa?)
– Poverina.
– Posso stringerle la mano?
– Deve esserne fiera.
– Suo padre era un martire. Un eroe.
E infinite variazioni sul tema.
Quante volte è successo? Negli anni le domande si sono sedimentate l’una sull’altra come le placche di una corazza. Ho imparato a incassare il colpo tenendo lo sguardo dritto, senza lasciar trapelare il dolore.
Sono sempre stata la figlia del «povero Walter» (un’espressione che detesto), famoso inviato speciale del «Corriere della Sera», vittima della «barbarie terroristica», ogni minuto della mia vita; prima di essere me, mi sono dibattuta a lungo tra «Benedetta» e «la figlia di Tobagi», eroe e martire. Far coesistere i due mondi non è stato ovvio né facile. Tanto piú che ogni giorno sperimentavo, fin nelle piccole cose, di non essere figlia, ma orfana. Una scorticatura su cui non ricresce mai la pelle.
Paradossale: non poter dimenticare neanche un momento un padre che non c’è e non potrai mai avere vicino. Un nome onnipresente e un vuoto abissale.
«Nessun maggior dolore | che ricordarsi del tempo felice | ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore». La mia esperienza della mancanza abitava invece il limbo del non ricordo. Le forme della sofferenza sono molteplici, diverse ma ugualmente terribili.
Alle medie scoprii che nelle cellule vegetali ci sono organuli simili a bolle d’aria, i vacuoli, attorno ai quali si organizza il resto della struttura. Mentre ricopiavo diligente il disegno dal libro di scienze sul mio quadernone pensavo, desolata: sono io. Abbarbicata attorno a dei vuoti in cui cerco disperatamente di non cadere.
Ho sentito un artista spiegare che secondo la fisica contemporanea il vuoto non esiste: c’è invece un meraviglioso, caotico continuum affollato di minuscole particelle subatomiche. Dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo, con gli anni ho capito che potevo provare a colmare almeno in parte il mio vuoto dando voce e corpo al nome che stava sulle targhe delle vie di mezza Italia, cercando di scoprire chi fosse quell’uomo sconosciuto che aveva occhi cosí simili ai miei.
Ci sono cose difficili da capire. Pensieri che la mente di una bambina non può contenere. Per esempio: papà è morto. I bambini non sanno la morte. Non è solo morto, di malattia o per un tragico incidente: è stato assassinato.
Come te lo spieghi? Come lo spieghi?
Ho un ricordo nitido di me stessa nel cortile della scuola materna mentre cerco di chiarire agli altri bambini, curiosi, quello che è successo. Hanno ucciso papà. Ma queste cose succedono nei film, non può essere vero. Non mi credono, sono smarrita, sconcertata. Allora insisto: «Hanno ammazzato papà, gli hanno sparato, bum! bum!, con la pistola» e mimo con le dita la forma dell’arma.
La mia mano piccolissima, senza saperlo, ripete il famigerato segno della P38, l’arma-simbolo degli «anni di piombo»: il gesto rabbioso dei giovani dell’Autonomia Operaia, l’area dell’antagonismo piú estremo, nelle assemblee del 1977, l’anno in cui sono nata.
Ci sono cose che i bambini non dovrebbero preoccuparsi di capire, almeno in tempo di pace, ma parecchi figli degli anni Settanta hanno dovuto adattarsi alla cruda realtà.
Papà scriveva sul giornale e una mattina i terroristi gli hanno sparato. Dapprima era molto difficile dare un senso non solo agli avvenimenti, ma persino alle parole. Sentivo dire che papà l’avevano ucciso i terroristi di sinistra. I «rossi», i comunisti. Allora i comunisti sono tutti cattivi e assassini. Ma no. Allora lui era di destra, era forse un «fascista»? Ma no, era di sinistra anche lui, però «riformista». Cioè? Era socialista. Ma era un giornalista, non un politico.
Non capivo.
Gli assassini di papà vennero presi, processati e condannati, ma uscirono subito di prigione. Avevo sei anni e la mia confusione fu totale. Avrei voluto fingere che fosse tutto un brutto sogno, ma la realtà sbucava fuori da ogni angolo. Dev’essere stato allora che ha cominciato a germogliare in me l’idea fissa di capire esattamente cosa fosse successo. Capire per controllare l’abnorme.
Quella mattina i killer hanno ucciso anche la mia innocenza, l’atteggiamento di fiducia che i bambini hanno verso un mondo che si immagina ordinato, lineare, ragionevole, dove c’è chi ti protegge e non può succederti nulla di male.
Potrei raccontare la mia storia come un romanzo di formazione al contrario: di norma si parte da una situazione protetta, se non confortevole; crescendo, l’impatto con la realtà provoca delusioni, incrina le sicurezze, ridimensiona sogni e speranze. Io muovevo da una inospitale spianata di sassi, segretamente convinta che il mondo è cattivo e può capitarti il peggio. Ero una bambina-vecchia. Avevo bisogno di costruirmi un orizzonte di fiducia, la capacità di sperare.
Il mondo attraverso lo specchio della bambina del Settantasette era un posto inquietante dove i buoni morivano, i cattivi uscivano di prigione, i grandi erano molto infelici e sempre preoccupati per cose incomprensibili, c’era un continuo via vai di gente strana col sorriso che non arriva fino agli occhi, e – regola fondamentale – non bisogna mai fidarsi di nessuno. Niente è come sembra.
Nel dubbio, la maggior parte del tempo stavo zitta e guardavo.
Ero triste.
Nell’adolescenza andò pure peggio. Alla vita si aggiunse la letteratura e il vuoto di mancanza si allargò a macchia d’olio mescolandosi a un incipiente vuoto di senso, con esiti infausti. So che non è molto originale, ma intorno ai quattordici anni fui sconvolta da Giacomo Leopardi. Il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia mi gettò, non esagero, in uno stato di prostrazione. «La bellezza è verità, la verità bellezza, questo è tutto ciò che sappiamo sulla terra», dice un altro romantico che mi ha guastato l’adolescenza. Nessuna speranza: il vuoto è cosmico. Purtroppo non studiammo La ginestra, per cui scoprii solo qualche anno dopo la meravigliosa risorsa dello «stringersi in social catena».
Non soddisfatta, mi tuffai in letture inquietanti. Ho passeggiato nei corridoi bui di Buzzati e di Kafka, poi mi prese una folle passione per le atmosfere torbide del primo McEwan. La mia libreria era un baule pieno di serpenti a sonagli, ma non potevo smettere di affondarci le mani.
Crescevo pensando che il mondo non fosse un bel posto dove stare. Poi, ci si mise di mezzo anche la storia, che ho amato da subito, ma abbonda di esempi che incitano a nutrire profonda sfiducia nella natura umana: una luttuosa successione di violenze, abusi e omicidi politici, argomento che calamitava piú di ogni altro la mia attenzione. In quinta ginnasio mi appassionai alle complessità della Roma repubblicana e presi a cuore soprattutto la vicenda dei fratelli Tiberio e Caio Gracco. Nel secondo secolo avanti Cristo, mentre la repubblica era scossa da profondi mutamenti economici, da tensioni sociali e squilibri nei rapporti di potere, questi due indomiti tribuni della plebe promossero una serie di progetti di riforma per scalfire i privilegi del latifondo e lo strapotere dei patrizi. Furono uccisi, assieme ai loro seguaci. I due fratelli erano per me il simbolo perfetto del destino di tanti uomini ammazzati per le loro idee, stroncati nel tentativo di migliorare pacificamente la società.
Mentre stavo studiando la storia dei Gracchi giunse una visita inattesa. La mamma aveva accolto la richiesta di incontrarci di Francesco Giordano, uno dei terroristi che parteciparono all’assassinio di mio padre. Aveva fatto il «palo» quella mattina. Come «irriducibile» (aveva, cioè, rifiutato di collaborare con la magistratura, fornendo informazioni in cambio di riduzioni della pena) scontò quasi interamente la condanna inflittagli. Era impegnato nel volontariato, aveva ottenuto la semilibertà, aveva una compagna e una figlia. Credo cercasse il suo momento di catarsi. La mamma era stata in corrispondenza con lui per tutti gli anni di carcere: incontrarlo era l’esito naturale di un percorso liberamente scelto, ma voleva che fossimo pre-senti anche noi figli.
Non ricordo che parole furono pronunciate, quel pomeriggio resta appannato nella mia memoria. Mio fratello, Luca, vent’anni, reagí con fastidio e una certa durezza. Vorrei aver saputo fare come lui. Ma avevo sedici anni, ero preoccupata per la mamma e mi sentivo annichilita. La presenza di quell’uomo sul divano bordeaux del tinello era perturbante.
Il baratro mi si è riaperto sotto i piedi. Il vuoto. Talmente profondo da riassorbire ogni traccia di rabbia e qualunque altro sentimento, foss’anche una pietà o una misericordia che non volevo permettermi di provare. Sentivo soltanto una disperazione che mi toglieva l’aria dai polmoni come un colpo troppo forte.
Avvicinarsi al dolore fa molta paura, sfiorandolo s’impara a tenersene a distanza, scegliendo vie lunghe e tortuose. Spesso, per scansare gli ostacoli, ci si allontana troppo dal tracciato della propria anima e si finisce per smarrirsi – nel deserto, magari, invece che nella foresta. Si rischia di morire di sete, anziché sbranati dai lupi.
Il cammino verso mio padre era pieno di pietre d’inciampo, era infestato di rovi. Mi avvicinavo e poi mi allontanavo un passo avanti e due indietro, con lo stesso atteggiamento diffidente e circospetto con cui approcciai la soglia della classe in prima elementare e ogni altra novità della mia infanzia. Non sapevo da che parte cominciare. Allora non potevo certo immaginare che a condurmi per mano sarebbe stata la stessa persona che volevo raggiungere.
page_no="12"
![]()
2. Rappresentazioni
Non ho ricordi di mio padre da vivo: è morto troppo presto. In compenso sono cresciuta assediata dall’immagine pubblica di Walter Tobagi.
A volte si trattava di rappresentazioni vere e proprie: ricordo il busto di bronzo inaugurato nel palazzo di un ente locale, che da piccola trovavo terrificante, oppure un ancor piú terribile ritratto a olio di cui un artista sconosciuto aveva voluto omaggiare il nonno Tobagi. Era ricavato da una fotografia non molto riuscita di mio padre seduto alla macchina da scrivere. Dalla vecchia Olivetti usciva un lunghissimo foglio di carta bianco avorio che andava ad avvolgersi attorno al suo collo: non so se nelle intenzioni dell’autore dovesse simulare una stola vescovile, un regale ermellino o un cappio. In ogni caso, meglio lasciar perdere.
Essere al centro di una tragedia pubblica aveva molti risvolti spiacevoli. Primo, mi collocava in una scomoda posizione di visibilità, del tutto indesiderata. Secondo, avevo l’impressione che l’invadenza di questa immagine pubblica, anziché avvicinarmelo e aiutarmi a conoscerlo, non facesse che spingere mio padre un po’ piú lontano da me, come quando insegui un pallone tra le onde.
Chi era davvero Walter Tobagi? Perché lo hanno ucciso?
Mi ha confortato il fatto di non trovarmi sola nella difficoltà di dare un senso agli eventi. Che un giornalista progressista come lui sia diventato obiettivo dei terroristi di sinistra desta a tutt’oggi sconcerto. Ritrovo l’eco delle perplessità della mia infanzia nelle parole di un ex terrorista tedesco della Raf, che, guardando all’esperienza dei «compagni» italiani, si chiede perché mai, mentre in Germania si colpivano capitani d’industria ed ex nazisti, a sud delle Alpi sotto il piombo dei sedicenti rivoluzionari caddero piú spesso i riformisti.
Con gli anni, gli elementi materiali del contesto diventavano per me piú intelligibili, ma si facevano avanti problemi di comprensione piú sottili e insidiosi.
Vi è un fenomeno caratteristico che interferisce con la memoria delle vittime del terrorismo (ma il discorso può essere esteso anche ai «cadaveri eccellenti» delle mafie): una vita intera viene risucchiata, come in un buco nero, dalla potenza di una fine tanto drammatica. L’identità della vittima è schiacciata. Quel che resta è solo il simulacro scintillante, ma vuoto, dell’eroe; nel mio caso, un martire della libertà di stampa. Tutto ciò rende assai piú difficile capire chi fosse realmente il defunto e tracciare un bilancio obiettivo della sua attività.
Di papà, come di altre vittime del terrorismo, si è parlato moltissimo, ma, come spesso accade, per lo piú attraverso semplificazioni e stereotipi. A ciò si aggiunge il fatto che anche le rappresentazioni stilizzate che si possono ritrovare nella stampa, nella pubblicistica sul terrorismo e nei libri di storia non sono del tutto coerenti tra loro.
Sembra non esserci pieno accordo nemmeno sulle ragioni per cui divenne «obiettivo» dei terroristi.
Walter Tobagi era:
«il giornalista che meglio aveva capito il partito armato, … socialista, attivo nell’organizzazione professionale, anche in polemica con quella che riteneva l’egemonia comunista nel piú importante quotidiano italiano, peraltro influenzato dalla loggia P2 di Licio Gelli».
page_no="14" Cosí lo descrive il noto politologo Giorgio Galli, una delle autorità in materia di terrorismo rosso. Mentre Giorgio Bocca lo liquida sbrigativamente definendolo:
«un giornalista medio, un brav’uomo che si dà da fare nel sindacalismo professionale, perché ormai la politica e i partiti sono entrati nei giornali, … trasformato nel nemico numero uno, nel cervello della manipolazione informativa».
Passando per Indro Montanelli, che ebbe a scrivere:
«Era d’idee (forse anche di tessera, non so) socialiste, ma moderate, in tono col suo carattere fermo ma mite, con la sua solida cultura, con la sua etica di galantuomo. Si era occupato, come tutti, di terrorismo, ma facendolo da cronista coscienzioso e misurato qual era, di stile efficacissimo per le sue fresche coloriture, ma sobrio, asciutto, allergico a ogni sensazionalismo. L’unico motivo che può aver richiamato su di lui le pistole dei killers è la carica che ricopriva, di presidente dei giornalisti lombardi».
Nelle testimonianze sono frequenti i riferimenti al sindacato di categoria, che dischiudono un altro orizzonte problematico. Walter Tobagi svolse per molti anni un’intensa attività in quest’ambito, sia come consigliere e poi presidente dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti, che come membro del comitato di redazione del «Corriere della Sera». I colleghi della corrente sindacale da lui fondata, Stampa Democratica, ricordano che gli avversari non esitarono a bollarlo come «fascista» per un accordo con il raggruppamento che esprimeva le posizioni piú conservatrici, o, piú spesso, lo accusarono di non essere altro che una pedina nelle mani dell’allora segretario del Psi, Bettino Craxi. Craxi aveva interesse a minare la compattezza della corrente di maggioranza, Rinnovamento, di fatto rappresentativa delle forze del compromesso storico.
Nella maggior parte dei casi, una pioggia di elogi postumi e alcuni silenzi imbarazzati hanno nascosto quanto mio padre sia stato contestato nell’esercizio di questa attività. Oppure, se di un’opposizione si è parlato, è stato spesso per conferirle significati extrasindacali e risvolti oscuri. Per anni è infuriata una feroce polemica circa l’esistenza di mandanti, morali e materiali, dell’omicidio Tobagi, da cercare proprio fra i colleghi giornalisti.
Tutti si sentono in dovere di parlare bene dei morti (se si escludono – deplorevoli eccezioni a confermare la regola – i casi in cui campagne diffamatorie sono proseguite anche post mortem). Quando poi si tratta della vittima di un brutale assassinio politico, la retorica è pressoché obbligata.
Sin dal giorno successivo all’omicidio ha cominciato a sedimentarsi l’iconografia ufficiale del «martire Tobagi». Le pagine dei quotidiani del 29 maggio 1980, pur nell’uniformità del cordoglio, offrono una panoramica articolata delle rappresentazioni date di mio padre dopo la sua morte. Frammenti di specchio che rimandano immagini differenti a seconda della prospettiva politica, una carrellata in cui già si profilano con chiarezza i due «miti» principali che sarebbero stati all’opera da quel momento: il «cronista buono» e il «martire socialista».
Morte di un cronista buono è il titolo dell’accorato articolo di fondo del «Corriere della Sera» firmato dal direttore Franco Di Bella e dal suo vice, Gaspare Barbiellini Amidei. Entrambi conoscevano molto bene mio padre, lo stimavano e non dubito che gli fossero sinceramente affezionati. Davanti alla sua morte scelgono un registro che oscilla fra i toni patetici e la chiamata alle armi. Evocano la legione delle testate Rizzoli e i duecentotredici cronisti del «Corriere», una schiera di opliti pronti all’attacco in punta di penna, chini a riempire le pagine bianche del taccuino da cronista di Walter (come, anni addietro, nello schieramento avverso, tanti giovani avevano teso le mani a raccogliere il fucile della «compagna Mara», figura simbolo delle Br). Qui, dal pulpito piú illustre, si pone la pietra angolare per la costruzione del «santino» di Walter Tobagi. Non un buon cronista, ma un «cronista buono». La professionalità sparisce, annegata nel pathos. L’uomo, dietro il cronista, può essere buono: e lui lo era.
«La Brigata XXVIII Marzo puntò su una creatura mite e sognatrice di un mondo piú giusto che si batteva contro la prepotenza e l’ipocrisia che dominano nella società. Walter Tobagi era un cattolico impegnato anche nella vita parrocchiale … Ma era soprattutto un giornalista, uno storico, uno che si occupava della nostra “difficile” categoria, un uomo buono, se posso usare parole inattuali. La sua unica colpa era stata quella di cercare cosa c’era dietro alle Brigate Rosse e che cosa le ispirava, cosa volevano», scrisse Enzo Biagi nel 2005, con affetto e semplicità. L’aveva conosciuto bene, fu lui a incitarlo a scrivere il suo ultimo saggio, Che cosa contano i sindacati?, sull’evoluzione del ruolo delle confederazioni negli anni Settanta.
Tornando al «Corriere», a tutt’oggi non è piacevole per me rileggere di essere stata esibita dalla direzione in questo fotogramma falsamente neorealista: «Due orfani in tenerissima età e una giovane vedova piangono in una casa di un quartiere popolare, a Porta Genova».
No, non sono cresciuta in una casa di ringhiera: per fortuna mio pad...