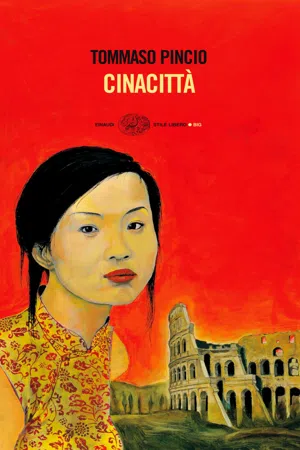![]()
7. Prese dunque il via una nuova e inquieta routine
Prese dunque il via una nuova e inquieta routine.
Ora, nel recarmi alla Città Proibita, speravo di cuore di non trovarvi Wang. Già, perché la strana circostanza iniziò a ripetersi con sorprendente regolarità. Dico strana, ma il termine piú appropriato sarebbe «sospetta». Pareva, infatti, che il mio amico di biliardo si presentasse in ritardo al preciso scopo di lasciarmi solo con Yin. Scacciai però questa idea dalla testa giudicandola assurda. Quale vantaggio poteva mai ricavarne Wang? Per giunta, stare solo con Yin mi piaceva, era davvero sciocco farsi inutili paranoie.
Si era venuto a creare un rapporto tra noi due. Le parlavo, adesso. Per dirla tutta, parlavo io e basta. Lei seguitava a essere piú muta di una statua, non reagendo in alcun modo alle mie parole.
Provavo l’acchito e le raccontavo di tutto. Di me, del mio passato, di ciò che facevo quando non ero alla Città Proibita. Le confidavo emozioni e opinioni. Persino i sogni, se mi capitava di farne. I classici discorsi che si potrebbero fare parlando da solo, insomma, o magari dallo psicoanalista. Credo che l’immagine sia proprio questa, un biliardo che si trasforma nel lettino del dottor Freud. Solo che nello studio degli strizzacervelli non ci sono fanciulle esotiche che ti portano birra ghiacciata sculettando.
Comunque mi aprii davvero tanto con Yin. In capo a un mese sapeva piú lei di me di chiunque altro, ammesso che mi stesse ad ascoltare. Soltanto su un punto mantenni un ferreo riserbo, i miei problemi di soldi. È un’accortezza fondamentale, del resto, una sacra regola che avevo appreso frequentando la Città Proibita: mai dire a una puttana come è messo il tuo conto in banca.
Ma il vero motivo per cui tacevo su questo punto era un altro: volevo che Yin mi guardasse con un qualche interesse, vale a dire come una potenziale preda. Se avesse saputo che tra non molto avrei avuto difficoltà in merito a dove sbattere la testa, ai suoi occhi avrei cessato di esistere. È cosí che ragiona una ragazza della sua specie, se non la totalità del genere femminile.
Non che meditassi di farmi una storia in senso stretto né tantomeno di darle una bottarella. La vedevo ancora come puttana e, in quanto tale, fonte di sciagure. Non volevo ridurmi come gli aspiranti mariti che tanto avevo sbeffeggiato. Tuttavia era in cima alle mie fantasie, la desideravo e non potevo fare a meno di trastullarmi all’idea che pure io significassi qualcosa per lei.
A tenermi a distanza da Yin c’era anche il fatto che non smetteva di trafficare col naso. Temevo si fosse beccata la febbre romana. Ripetevano fino alla noia che i normali rapporti tra persone non erano fonte di contagio, ma ormai avevo imparato a non fidarmi delle rassicurazioni dei mezzi di informazione. E poi l’intimità è l’intimità, con tutta la buona volontà non mi riusciva di ascrivere il congiungimento carnale nel novero delle normali interazioni tra persone.
I miei intendimenti amorosi li concentravo cosí sulla ragazza del ricevimento. Non ero per nulla cotto di lei, il suo viso dalla pelle grassa e cosparsa di brufoli non era minimamente paragonabile agli scombussolamenti che mi regalava la vista di Yin. Era soltanto una ragazza passabile, a malapena carina, un tempo la si sarebbe definita un tipo. La sua attrattiva maggiore, a parte la giovane età, era la dolcezza. Suscitava una gran voglia di proteggerla. Inoltre, aspetto tutt’altro che marginale, non era una puttana.
Al mio rientro in albergo, se lei era dell’umore di sfogarsi, mi fermavo ad ascoltarla per un’oretta. Non sempre era cosí. Fu lei stessa a precisarmi che aveva un caratteraccio. Era dei gemelli, mi disse, come se ciò bastasse a giustificare che certe mattine mi salutava con un grugnito per poi voltarsi dall’altra parte. Anche questo mi sorprese, credevo che in materia di astrologia i cinesi fossero molto attaccati alle loro tradizioni. Insomma, che ragionassero in termini di draghi, serpenti e maiali.
Ogni tanto buttavo lí qualche parola carina o consolatoria. Ma la maggior parte del tempo era lei a tenere banco. Ripensandoci, la dinamica del mio riavvicinamento alla sfera del femminile era ripartita in modo davvero equo. Con una parlavo, con l’altra ascoltavo. Una volevo stuprarla, l’altra volevo coccolarla. Yin era confinata nel limbo delle fantasie perverse, la ragazza del ricevimento colmava invece la mia mancanza d’affetto.
Comunque sia, tra l’una e l’altra, avevo abbastanza pensieri da tenere occupata la mente notte e giorno. Oscillavo tra questi due poli fregandomene del resto. E dire che erano in arrivo questioni ben piú serie sulle quali meditare.
Al termine della nostra prima conversazione, la ragazza del ricevimento mi aveva consegnato una lettera arrivata la notte precedente. Era della banca. L’estratto conto, pensai. Salii in camera senza aprirla. Entrando la depositai sul tavolo e andai a letto, dove ebbi spazio solo per le mie fanciulle.
La sera seguente, poco dopo il risveglio, l’occhio mi cadde di nuovo sulla busta. A questo punto non potevo piú tirarmi indietro. Presi uno yogurt dal frigo, mi sedetti al tavolo e guardai cosa conteneva. Si trattava dell’estratto conto, in effetti. Il colpo della cifra riportata nel saldo mi lasciò intontito per almeno mezz’ora. Un numero che ancora adesso è stampato nella mia mente fino all’ultimo decimale, quattromilaseicentodue virgola tredici. Lo ricordo come fosse ieri, il numero che mi separava dal tracollo definitivo, oltre c’erano fame e disperazione. Stavo alle calende greche. Che ne sarebbe stato di me? Sarei andato a vivere come un barbone al Colosseo, tra appestati e bestie romene, o mi sarei deciso a partire per il Nord?
Quattromilaseicentodue virgola tredici. Poco piú dell’equivalente di quattro mesi di affitto. Ma se avessi pagato il signor Ho quando lui pretendeva, vale a dire il primo di ogni mese, con quali globi sarei andato avanti? Dove avrei preso i soldi per i pranzi al chiosco dei pesci luminosi e le birre ghiacciate alla Città Proibita?
Ringraziai il cielo di aver versato sei mesi anticipati. Potevo stare tranquillo per un po’. Sei mesi sono pur sempre sei mesi, mi rincuorai. Potevano succedere un sacco di cose in sei mesi. Poteva scoppiare una guerra, per esempio. Se mi diceva bene, poteva persino arrivare la fine del mondo… Non era poi una speranza tanto assurda, considerando quel che era capitato a Roma solo perché aveva preso a fare piú caldo del solito.
Mai sottovalutare l’eventualità di un’apocalisse, le catastrofi sono sempre dietro l’angolo. Ti spremi le meningi per uno stupido problema di soldi e senza manco accorgertene scopri che, a parte te, non è rimasto nessuno sulla faccia del pianeta azzurro, proprio come in quel film di fantascienza che mi piaceva tanto da piccolo.
Cosí confortato, diedi un’ultima e noncurante occhiataccia all’estratto conto. Dopodiché lo infilzai allo spillone che troneggiava sul tavolo.
page_no="226" Trovare una soluzione all’imminente emergenza economica non fu la sola cosa che trascurai in quel periodo. Cessai di espandere la mia cultura generale attraverso Google e Wikipedia, per esempio. La lettura della biografia di Marx procedeva a rilento, non andavo oltre una mezza pagina a sera. Adesso, per ingannare l’attesa dell’ora di uscire, guardavo al computer il famoso film di Fellini sulla Dolce Vita che mi ero scaricato da Internet.
So che è una lacuna imperdonabile per una persona che si picca di essere un conoscitore d’arte, ma prima dell’anno senza inverno non lo avevo mai visto. Non per intero, quantomeno. Ci avevo provato, una volta o due, ma mi ero sempre appisolato. Naturalmente, avevo una vaga idea di cosa parlava. Come tutti, avevo presenti le immagini del bagno nella fontana di Trevi. Ma il film in sé era un oggetto misterioso per me.
Non me ne rammaricavo affatto, se devo essere sincero. Me lo figuravo come il genere di pretenzioso e noioso pasticcio che manda in brodo di giuggiole l’intellettuale italiano medio. Non ho mai approvato granché la modernità artistica. Quanto a creatività, la penso alla maniera del grande Giorgio de Chirico. Sono per la bella pittura, l’unica vera arte. Non so proprio come abbia potuto resistere a lavorare per tanti anni in una galleria dove si esponevano le cagate piú assurde.
Quando vidi La dolce vita per la prima volta mi compiacqui di non essermi sbagliato. Si trattava proprio di un pasticcio. Una storia talmente sgangherata che in confronto il romanzo di Hemingway pare un trattato di logica matematica. Alla seconda visione, però, cambiai idea.
Il fatto è che mi identificavo. A forza di sentirmi chiamare Marcello da Wang, il nome mi era penetrato fin nelle ossa. Mi ci ero abituato, e ogniqualvolta lo sentivo pronunciare sobbalzavo. D’altra parte, non c’era piú nessuno a Roma che mi chiamasse con quello che mi avevano dato i miei genitori.
Pure la balla del giornalista era diventata quasi vera. In fondo, la realtà non è che una deformazione mentale, una specie di malinteso collettivo. A dispetto dei nostri sforzi, non penetriamo mai l’essenza delle cose. Il mondo sarà sempre come lo vediamo. Vale anche per gli esseri umani. Siamo come ci vedono gli altri e noi non possiamo che adeguarci. Le persone in genere sono molto meno aperte di quel che si crede, se cerchi di spiegargli che sbagliano tendono a ingrugnirsi, se poi all’origine dello sbaglio c’è qualcosa che gli hai detto tu vanno ancora piú in bestia. È la ragione per cui, spesso e volentieri, i leader politici come Craxi si ritrovano la gente contro.
Questo Marcello della Dolce vita lo si potrebbe definire un fallito, un giornalista da strapazzo che combina assai poco se non fare il nottambulo, quello che alla mia maniera si definirebbe uno sperperatore di esistenza. Era perciò pressoché impossibile che non mi identificassi. L’intero film è un inno allo sperpero, infatti.
Ma a gratificarmi piú di ogni altra cosa, l’elemento che mi induceva a rivederlo a piú riprese, era l’atmosfera di elegante serenità che, nonostante tutto, lo pervadeva. Come se nel perdersi e nel rovinarsi non ci fosse nulla di davvero cupo e maledetto, come se non ci fosse strada migliore per tornare bambini che quella di partecipare a un’orgia delle piú depravate.
Non seguivo il film dall’inizio alla fine, ovvio. Facevo partire il file e lo guardavo sognando a occhi aperti, assentandomi per intere sequenze. In cima alle mie fantasie c’era Yin. A lei assegnavo la parte di Anita Ekberg. Avrebbe fatto la sua figura, diciamolo. Quella biondona scelta da Fellini non era niente di speciale. Con un elmetto verde in testa l’avresti scambiata come niente per un soldato della Wehrmacht. La mia Yin, invece. Che spettacolo figurarsela entrare nella fontana di Trevi nottetempo, avanzare strafottente e svogliata nell’acqua, nuda come nella sala del biliardo, la pelle piú bianca del travertino, una statua barocca animatasi per incanto.
Alla ragazza del ricevimento riservavo invece il ruolo della moglie che tenta il suicidio e che Marcello porta all’ospedale dopo aver passato la notte con una prostituta. Immaginavo di trovarla al mio rientro priva di sensi e riversa sul bancone. La salvavo con la respirazione bocca a bocca.
È però evidente che un simile andazzo non poteva protrarsi in eterno. Non si trattava piú di routine, c’era in gioco ben altro adesso. Se non fossi passato all’azione, presto o tardi tutto questo sognare mi sarebbe venuto a noia, il meraviglioso senso di aspettativa che mi coglieva alla vista delle due fanciulle sarebbe scemato fino a estinguersi. La mia vita sarebbe tornata desertica com’era prima e io sarei rimasto solo coi miei problemi di soldi, e soltanto a quelli avrei potuto pensare. E allora sai che angoscia.
Non ne potevo piú di stati ansiosi. Quanto all’arrovellarsi su problemi meschini e insolubili, ritenevo di avere già fatto la mia parte. Volevo cambiare ruolo. Anelavo a pensieri positivi, adesso. Anzi, nemmeno a pensieri. Volevo sensazioni, segnali, iniezioni emotive di fiducia, squarci di luce sul futuro, l’illusione di un rinnovamento. Volevo credere che non tutto era perduto, confidare in un’altra occasione. Volevo sperare contro ogni speranza. In pratica, l’impossibile.
Una sera stabilii che era giunta l’ora di sbilanciarmi con la ragazza del ricevimento. Le avrei detto qualcosa di carino al momento di uscire per il pranzo. Lei avrebbe avuto tutta la notte per riflettere sulle mie parole e quando fossi tornato dalla Città Proibita avremmo chiacchierato un po’, poi l’avrei invitata a bere un drink in un posto tranquillo e magari anche a salire su da me, dopo.
Al bancone del ricevimento non c’era anima viva. Nulla di cui stupirsi. Nessuno le dava mai il cambio e di quando in quando andava a stendersi su un lettino dietro la cascata.
Suonai il campanello e attesi. La vidi apparire dopo circa un minuto coi capelli piuttosto arruffati.
– Cosa vuoi? – disse stropicciandosi un occhio con il dorso della mano.
– È per quel preventivo della riparazione degli ascensori. Il signor Ho mi ha detto di firmarlo per accettazione e lasciarlo a te –. Depositai il foglio sul bancone posandoci sopra il campanello in modo che l’aria mossa dai ventilatori non lo facesse volare via.
Lei lo guardò, un po’ storcendo il muso e un po’ sbadigliando.
– L’ho firmato, – dissi.
– Vedo che tu firmato ma potevi portare anche di mattina quando non dormo. Ascensori mica ripara domani.
Aveva ragione, coi tempi dell’albergo c’era da dubitare che la cosa andasse in porto prima di un mese. Era visibilmente contrariata e aveva addosso un odore di sonno che trovai irresistibile.
– Scusa se ti ho svegliata.
Rispose con un mezzo grugnito. – Tanta fretta per firma. Hai anche soldi, per caso?
Si trattava di trecento globi, mica bruscolini. In effetti, contavo di sborsarli solo dopo che avessero sistemato quei benedetti cosi.
– Non con me, – dissi. – Magari li prelevo col bancomat e te li dò quando torno.
page_no="230" Mi guardò di traverso quasi subodorasse qualcosa. Quindi sbadigliò di nuovo e disse: – Bene, tu dato foglio. Ciao.
Aprii la bocca ma non ne uscí nulla. Per un istante mi parve di percepire con nitidezza l’afrore delle sue ascelle e me ne inebriai. Poi fui assalito dal timore che si fosse accorta che le stavo fissando le tette, mi aveva appena lanciato una delle sue occhiatacce. Non portava reggiseno e me l’ero immaginata che si toglieva la maglietta prima di stendersi sulla branda dietro la cascata. Immaginai anche un’alternativa, che se la lasciava indosso togliendosi invece jeans e mutandine. La vidi distesa con le gambe leggermente divaricate. Era la prima volta che la desideravo in senso fisico, come desideravo Yin.
– Che c’è ancora? – chiese lei, sempre piú scocciata.
– No, niente. È solo che…
– Cosa?
– Lo sai che ieri ti ho sognato?
Sarebbe stato piú corretto dire che l’avevo pensata un sacco. Ma lí per lí il sogno mi era sembrato, come dire, una cosa meno impegnativa.
Lei arricciò il naso in un modo che non prometteva nulla di buono, e allora mi affrettai ad aggiungere: – C’era anche il signor Ho.
Aggrottò la fronte.
– Nel sogno, intendo.
– Perché tu dici questo?
– Cosí, tanto per dire. Non lo trovi strano?
Lei mi guardò ancora male e disse: – Io trova strano tu.
Poi, con un gesto brusco, sfilò il foglio da sotto il campanello e si dileguò dietro la cascata, lasciandomi godere in perfetta solitudine il finto rumore dell’acqua e il mugghio eterno dei ventilatori.
page_no="231" Mi sentivo uno schifo. Mai i ravioli del chiosco di fronte al negozio di acquari seppero di soda caustica come quella notte. Li mandai giú solo perché il pranzo mi costava trenta globi.
Come potevo essere stato tanto idiota? Sarà pure stata dei gemelli, ma mi aveva trattato in un modo che non lasciava dubbi. E comunque, che pensavo di fare? Mettere su famiglia? Quella ragazza aveva poco piú della metà dei miei anni, il giorno in cui nacque c’era già l’Aids. Quando morí Gaëtan Dugas io ero già in procinto di dare gli esami di maturità, mentre lei non era nemmeno uno spermatozoo. Che coppia avremmo potuto essere mai, lei con il suo italiano smozzicato, io senza un centesimo? Dovevo proprio aver smarrito il lume della ragione.
Lo sguardo rivolto all’espressione sorda dei pesci, conclusi che tutto sommato era un bene che fosse andata cosí. Hai visto mai che alla fine rinsavivo e mi davo una smossa? Non era tanto per dire. Il fallimento dell’approccio era stato una salutare doccia fredda. D’incanto vedevo l’assurdità della situazione. Cosa ci facevo ancora a Roma, a morire di caldo in una città che mal sopportavo già prima dell’invasione barbarica? Cosa c’entravo io con questi cinesi che si permettevano di guardarti dall’alto in basso nonostante i loro modi da carrettiere?
Sí, credo proprio che sarei rinsavito, non fosse stato per ciò che mi attendeva quella notte alla Città Proibita. Il destino mi stava offrendo su un piatto d’argento un’ultima opportunità. Col senno di poi capisco che c’era solo da prenderla al volo, soltanto quello dovevo fare, andare in un’agenzia di viaggi e acquistare un biglietto per Milano. Dopodiché, dritto in albergo a fare le valigie.
E invece, come al solito, ho pensato di avere tutto il tempo. Invece di impedire che quel barlume di lucidità scintillasse invano, mi recai alla Città Proibita rimandando all’indomani l’ora delle decisioni irrevocabili.
È vero, mai a...