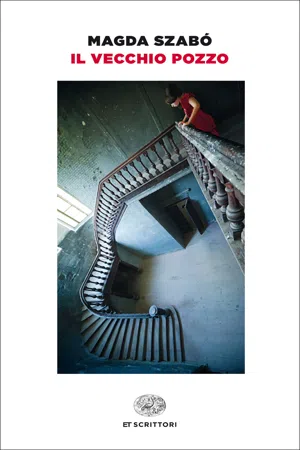![]()
La scuola, i miei mariti
Nessuno, nemmeno un re, avrebbe potuto contare su un precettore come il mio: la mamma, che mi insegnò ogni materia nei primi anni delle elementari.
C’era un motivo per cui lo faceva. Ero una bambina debole, il piú delle volte mi prendevo malattie infantili dal decorso complicato non appena infilavo il naso in classe a inizio anno scolastico, e perdevo cosí tante lezioni che una volta guarita non sarei potuta stare al passo coi miei compagni. Mi trasformai in una specie di allieva privatista presente in aula con molta saltuarietà, assistevo alle lezioni come un’ospite, rispondevo a una domanda ogni tanto, per dimostrare che non avevo trascorso le mie assenze a giocare e basta, poi, a fine anno, sostenevo un esame separatamente di fronte a una piccola commissione. Mia madre aveva compiuto studi magistrali, ma un diploma non sarebbe bastato a rendere quegli anni ciò che furono. Non era l’insegnante, bensí la scrittrice che inventava giochi stupendi per tenermi aggiornata con il programma scolastico, e io imparavo senza accorgermi di studiare, provavo solo un gran divertimento. Non ho piú incontrato in vita mia un’altra maestra dotata della sua capacità di trasmettere il sapere. Quando lavorai come insegnante, se ottenni dagli allievi migliori risultati rispetto a colleghi nelle mie stesse condizioni, e se il mio metodo didattico conduceva a soluzioni piú originali ed efficaci degli altri, fu solo perché misi in pratica il suo esempio, la sua idea di pedagogia. Dimostrò nel latino il talento speciale che possedeva (quante capacità speciali possedeva!): oltre a leggerlo e capirlo in maniera eccellente, mio padre lo sapeva parlare con fluidità, ciononostante aveva scarsa voglia di occuparsene con me, e quando iniziai a studiarlo al ginnasio fu la mamma a prendere il libro di testo per fornirmi un aiuto se mi arenavo su qualche passo ostico della versione; eppure, lei conosceva unicamente il francese e il tedesco. Riuscí non solo a spiegarmi una lingua che nessuno le aveva mai insegnato e che era stata costretta a scoprire insieme a me, ma anche a farmela amare cosí profondamente che, arrivata all’università, non mi sfiorò nemmeno l’ipotesi di scegliere una materia diversa. Anche allora mi rivolsi a lei quando ebbi bisogno di una mano per la grammatica finnica; lei si comportò come con il latino, studiò per un paio di giorni la struttura del finlandese poi, come quando ero piccola, si sedette accanto a me e chiarí tutto ciò che prima era oscuro, definí le caratteristiche di una lingua a lei totalmente sconosciuta, ancor piú del latino che, se non altro, usava parole di significato internazionale, entrate nell’uso corrente.
Non sapevo scrivere nella calligrafia ordinata delle altre diligenti allieve, e non imparai mai a farlo; nelle nostre lezioni non mi sentivo ordinare «allunga quella gambetta cosí, arrotonda bene la o, metti il trattino nella zeta», la mamma riteneva che la forma delle lettere fosse poco importante, in compenso appresi piú in fretta della media a riconoscere l’alfabeto e a fissare i pensieri con la mia orribile scrittura. Saper leggere e scrivere fu un punto di svolta nella vita, compresi subito quanto fosse importante che sequenze di lettere scritte o stampate formassero parole e messaggi, se guardavo quell’insieme di segni potevo decifrarne il significato e, se volevo, potevo anch’io trasmettere messaggi su carta o conservare per sempre le rime sparse, le poesie rudimentali che avevo in mente e il piú delle volte svanivano rapide dalla memoria.
Delle mie fugaci apparizioni a scuola la cosa meno piacevole era l’edificio, da bambina avevo una spiccata sensibilità per gli odori, là dentro sentivo continuamente puzzo di urina e un alito nero che emanava dalle assi del pavimento, spalmato ogni giorno con uno stomachevole liquido oleoso. Nei confronti delle maestre, pur non essendone pazza, non provavo antipatia, anzi, trovavo riposante l’impersonale, uniforme bonarietà di quelle miti signorine bianche, profumate e noiose come le gelatine di frutta. Come avrei potuto interessarmi alle loro tiritere, disponendo in privato di una mamma che spiegava in modo divertente ogni argomento noioso, rideva sempre e rendeva vivi idee e oggetti? Chi poteva competere con lei che tirava fuori dal cilindro un solerte personaggio, il «Predicato»? Si chiamava cosí perché «predicava» sempre qualcosa, affermava che qualcuno era andato via, tornava a casa o mangiava, altre volte che qualcuno era coraggioso, codardo o rubicondo, altre volte ancora che uno diventava due, o che quella cosa era una spiaggia e non una farmacia. L’unico aspetto della scuola davvero piacevole erano le compagne di classe. Cosí numerose, cosí diverse per sembianze e personalità; le loro marachelle spiritose, la loro scaltrezza, persino la loro semplice presenza rendevano stupenda la vita comune in aula. C’era sempre quella che teneva nascosti in cartella piccoli oggetti meravigliosi, scatolette; quella coraggiosa che sfidava spaventose conseguenze incidendo scritte sul banco; quella che usava un inchiostro di colore differente dalle altre; quella manesca; quella che conosceva straordinarie parole proibite. Quando trascorrevo mezza giornata a scuola, tornavo a casa eccitata ricordando gli episodi piú emozionanti, ogni ora succedeva qualcosa tra le alunne, spesso la maestra neppure lo notava, ce ne accorgevamo solo noi, e serbavamo il segreto nel commovente silenzio di cui le bambine piccole sono capaci.
Avevo voglia di stare con le coetanee. Per ragioni casuali, all’inizio della mia vita ebbi solo compagni di gioco maschi, la maggior parte abitavano nella nostra strada, e nessuna delle mie cugine aveva un’età adatta alla mia, o erano già mezze adulte o cosí piccole che non sapevo come giocare con loro. Il mio fratellastro venne ad abitare da noi solo dopo la morte del padre e aveva quasi dieci anni piú di me, il mio idolo dunque non fu lui bensí Guriga, che aveva pochi anni piú di me ed era il ragazzetto piú perfido della città. Con me faceva il buono, come un capitano di ventura dall’animo nobile che ha trovato un neonato sulla porta della città appena messa a ferro e fuoco e lo prende sotto la propria egida: ero la sua protetta, mi insegnò tante cose. Mi affidò il compito di portare da mangiare ai ratti in cantina, e io, dopo aver vinto paura e disgusto, mi scoprii a osservare con interesse quei topolini nati glabri che crescevano e diventavano piú grandi con i miei succulenti bocconi. Pochi altri precetti mi sarebbero tornati utili quanto quelli di Guriga: nel periodo in cui insegnai in una scuola maschile, il mio prestigio in classe raggiunse livelli eccezionali quando gli adolescenti scoprirono che i topi non mi provocavano il minimo turbamento, né da vivi né da morti, e che sapevo tante cose sugli indiani. L’indiscutibile competenza professionale che dimostravo nelle questioni piú sentite dai miei alunni, conquistata proprio grazie alla particolare educazione di Guriga, mi permise di vincere l’avversione naturale che i ragazzi provavano verso la lingua e la letteratura ungherese: si misero a studiare per farmi un favore, per dimostrarmi che apprezzavano la competenza dell’insegnante sui problemi «veri» della vita.
Gli amici di Guriga mi avevano accolta nella banda su suo ordine, ero l’unica femmina. Potevo entrare nel loro accampamento, e non in semplice veste d’osservatore, né tollerata nel ruolo minore di sorella o sposa: mi consideravano come un maschio, un guerriero di pari valore. Devo dire che disponevo di un equipaggiamento decisamente piú appariscente rispetto alla media, al massimo qualcuno sottolineava il proprio rango con una triste penna d’oca, io invece indossavo un vero copricapo di piume e nastri, esibivo addirittura un’ascia di guerra, che papà aveva costruito inchiodando un pezzo di latta a un manico di legno sul quale, dato che quel genere di lavoretti manuali lo divertivano moltissimo, aveva poi sbalzato un ornamento floreale. Era un raro tomahawk, con al centro un grazioso tulipano sormontato da grandi lettere, «M» e «SZ». Non ero dunque sola, né costretta alla perenne permanenza in un mondo di adulti, però giocavo con i maschi, e mi mancava un’amica del mio sesso. Il dono piú grande che mi fece la scuola fu Agancsos, la conobbi in terza, la mia prima, eterna amica.
L’Agancsos che vive in fondo al vecchio pozzo ha lo stesso viso che mi è rimasto impresso dalla prima volta in cui la vidi, capelli corti biondo oro, occhi blu scuro; dato che è appena caduta, ferendosi il visetto, le spiccano sul naso due vistose croste, una a forma di prosciutto, l’altra di pagnotta: se avessi anche un coltello potrei mangiarmelo, il naso di Agancsos. Vedevo in lei una creatura esotica, perché non era nata a Debrecen, ma a Kassa, la sua famiglia si era trasferita a Debrecen quando Kassa era finita fuori dai confini nazionali ungheresi. A casa la chiamavano con un vezzeggiativo, Mädy, anche se il suo nome anagrafico era Edit; a me non piaceva nessuno dei due, e ne coniai uno mio. All’epoca ero appassionata di storia dei tartari, e con grande modestia mi scelsi il soprannome Genghis, la mia amica era il khan Ögödaj, ma a forza di storpiarlo divenne prima Ogacs, poi Ogancs, Agancs, e infine Agancsos. Mai khan fu piú dolce, amato, giocherellone, sensibile a ogni follia che partoriva la mia immaginazione, appena proponevo un nuovo gioco quell’Ögödaj biondo partecipava con il massimo entusiasmo, trepidante di gioia. L’amicizia sbocciò improvvisa, senza sintomi premonitori, come una malattia, eravamo cosí unite, anche nell’aspetto esteriore, che chi non ci avesse conosciuto – dato che stavamo sempre insieme – ci avrebbe scambiate per sorelle. Se ripenso a lei, la vedo spesso sotto il portone di via Sant’Anna, piange, cerca di proteggersi il sedere con le piccole mani, e vedo me stessa osservarla da dietro i cespugli di gelsomini e urlare cosí forte, presa da compassione, che la padrona di casa, o la Von Gold, si affaccia alle finestre del primo piano: la scena potrebbe svolgersi anche nel cortile. Se non le davano il permesso di venire da me, fuggiva, perché l’unico nostro desiderio era di stare insieme, e io avevo una casa piú grande, avevamo piú spazio, piú occasioni per fare i nostri giochi. E quando suo padre, il signor Béla, scopriva che la figlia non lo aveva ascoltato, veniva a riprenderla e la batteva sul sedere, sotto il portone, con il bastone da passeggio nero munito di un pomo d’argento, per insegnarle che non doveva correre a casa nostra ogni momento, e che non si deve disobbedire. Agancsos era diversa dagli altri bambini, valeva piú di tutti loro messi insieme, anche se mi facevano vedere i ratti e godevano fama di eroici indiani. Agancsos era una bambina, con lei potevo finalmente parlare di cose che ai maschi non interessavano e a loro non avrei mai detto, neppure se mi avessero ascoltata; non avrei saputo spiegare le ragioni del mio pudore, sentivo soltanto che non mi andava di farlo. Agancsos capiva immediatamente ciò che ritenevo importante nella vita, senza bisogno di spiegazioni, e afferrò subito l’essenza profonda dell’arte, qualcosa piú importante della realtà, sapeva seguirmi nei giochi di fantasia, anzi mi dava il suo contributo per svilupparli insieme, manifestando la mia stessa ossessione degna di una morfinomane.
Fin dalla piú tenera età ebbi ben chiaro che i miei genitori erano persone straordinarie, perciò l’ultima cosa al mondo che avrei fatto sarebbe stata rattristarli, mai avrei confessato che desideravo follemente sposarmi. Non volevo ferirli, addolorarli, temevo pensassero che non li amavo abbastanza, mentre era esattamente il contrario, perché il matrimonio contemplava la loro presenza, immaginavo che l’unico cambiamento nel ménage famigliare sarebbe stato il mio consorte, venuto a vivere con noi. Ma il desiderio di un marito non mi lasciava mai, ritenevo assurdo che nello sciocco ordine del mondo adulto una ragazza dovesse aspettare tutto quel tempo per potersi sposare. Nulla era piú solenne, e affascinante, delle foto nuziali affisse nelle vetrine dei fotografi, o dei maestosi sposalizi cui avevo assistito in chiesa; le fedi che esponeva il mio amico gioielliere erano i suoi pezzi piú preziosi.
Avevo la certezza assoluta che sarei stata un’ottima moglie, qualora mi fossi sposata. Su quel che bisognasse fare dopo la chiesa, le idee erano piú confuse, sapevo solo che la maggior parte degli adulti sbagliava in qualcosa, perché dopo divorziavano, si avvelenavano la vita con continui dissapori e discussioni; lo capii presto ascoltando avida, dalla prima all’ultima parola, i discorsi della mamma quando un ospite si sfogava con le lamentele. Mi stupiva che un marito maltrattasse e umiliasse la moglie, o viceversa, la moglie il marito, ma orecchiavo composta e silenziosissima, covando anche un discreto orgoglio, perché certe cose nella mia futura casa non si sarebbero mai dette, chiunque avrebbe potuto guardare il mio matrimonio trasparente come un vetro. Un giorno provai a buttar lí che forse era il momento giusto di trovarmi un marito, ma papà spiegò che dovevo togliermi simili ghiribizzi dalla testa, le bambine per legge non possono sposarsi, neanche se vogliono e se hanno il consenso dei genitori, la norma parlava chiaro, avrei dovuto aspettare di compiere almeno sedici anni; rimasi profondamente delusa. Mi arroccai sulle mie idee anche quando cercarono di spiegarmi che quel desiderio, a parte tutto, era assurdo: come avrebbe potuto una bambina piccola condurre una casa, curare la famiglia? E un bambino della mia stessa età provvedere alle necessità materiali? L’eventuale bambino sposo, che ovviamente andava ancora a scuola, sarebbe stato tutt’altro che adatto al matrimonio. Risposi che non avevo la minima intenzione di sposare uno come Miki o Zoli, due coetanei, e neppure Guriga, il piú anziano di noi, forte e rispettato, io volevo sposare un adulto fatto e finito, e possibilmente subito; papà ascoltò il ragionamento e scoppiò a ridere, la mamma mormorò confusa: – Gesú Maria! – Scossero la testa, dissero che era impossibile, risero, io tacqui ferita, mi sentii incompresa, capii che non mi avrebbero aiutata a compiere quel passo. Andai in cortile, prendendo atto che il mio desiderio cozzava contro fortissime resistenze, probabilmente invincibili, e cominciai a meditare su come affrontare il problema. A un certo punto arrivò Agancsos, le comunicai che non volevano sposarmi, anche lei, che fremeva come me dalla voglia di diventare moglie, si rattristò, poi si illuminò all’improvviso: – E se non dessimo retta a nessuno, – propose, – e ci sposassimo comunque? – Non sul serio ovviamente, ma solo per gioco; sarebbe stato piú o meno lo stesso. Non dovevamo preoccuparci delle spiegazioni dei miei genitori, avremmo finto che tutto seguisse i nostri sogni; d’ora in avanti, ogni volta che fossimo state insieme, avremmo parlato e assunto i comportamenti di due amiche sposate. – Come a teatro? – le chiesi in estasi, perché nella proposta di Agancsos intravidi subito potenzialità enormi. – Come a teatro, – rispose.
Apriti sesamo. Il sesamo si era aperto.
Si era spalancato e non si richiuse piú, per lo meno nel mio caso: quel giorno iniziò il regno della fantasia sconfinata. All’improvviso i giochi precedenti mi parvero banali, eppure erano stati cosí divertenti; ho detto che la mamma per contribuire al bilancio domestico fabbricava gatti, cagnolini, scimmiette di pezza che dava al giocattolaio: naturalmente, realizzava per me una copia di ogni esemplare. Ne avevo cosí tanti che se andavamo a giocare a casa di Agancsos serviva la cesta della legna per trasportarli tutti. Dopo la proposta della mia amica non contarono piú niente: probabilmente anche Dio stesso, dopo la Creazione, aveva provato la nostra stessa soddisfazione, eravamo finalmente padrone del nostro destino, potevamo prendere marito, scegliere chi essere. Poiché la legge ci vietava il matrimonio, e sposarci lo stesso probabilmente sarebbe stato abbastanza complicato, non dovevamo piú avere otto anni. Decidemmo di comune accordo che ne avevamo sedici, i nostri mariti ne avevano appena compiuti ventiquattro. I loro personaggi non nacquero subito, perché fu necessario procedere con la massima attenzione per non tralasciare nemmeno un desiderio, all’inizio ebbero solo un nome e sembianze esteriori, per la bionda Agancsos dagli occhi blu andò bene un uomo tenebroso con capelli e occhi neri, per me, che ero scura, ovviamente un biondo con gli occhi azzurri. Il marito di Agancsos si chiamava Roger, il mio Robert, entrambi erano conti, sul fatto che dovessero essere aristocratici e ricchi sfondati non nutrimmo dubbi, le discussioni protratte per giorni riguardarono solo le eventuali professioni. Il fatto che lavorassero ci sembrava un tratto di virilità, ma non fu facile decidere il grado di istruzione adatto a un conte; quando lo individuammo, il problema successivo fu scegliere la carriera piú degna: per semplificare le cose, decidemmo che i nostri conti mariti avrebbero svolto tre lavori insieme, amministravano immensi latifondi, facevano i chirurghi ed erano tenenti d’aviazione. Spesso venivano convocati per celebri parate aeree o missioni di volo segrete, talvolta combattevano in guerra, ricevevano decorazioni, altre volte salvavano vite umane eseguendo miracolose operazioni, e agivano sempre in coppia. Se non avevano impegni chirurgici o in cielo, stavano con noi mogli nelle proprietà, andavano a cavallo, ricevevano ospiti, in tempo di pace vivevano alla luce del sole, se scoppiava la guerra e non finivano in prima linea, nel sottosuolo. Perché i castelli delle nostre tenute, dove ci spostavamo parte a cavallo e parte in aereo, non erano soltanto un’esibizione di sfarzo grazie alla loro parte visibile fuori terra; sfogliando le annate belliche del «Tolnai Vilaglapja» avevo visto troppi mostri con il volto coperto da maschere antigas, trincee, soldati feriti, per non restarne influenzata. Di ogni castello c’era una copia esatta nel sottosuolo, munita di impianti per la circolazione dell’aria che erano prodigi di tecnologia, Agancsos aveva pensato anche a un camino con una speciale cappa per l’aspirazione del fumo. Immaginammo di avere figli, solo maschi (il problema all’inizio provocò animate discussioni, l’una cercò di convincere l’altra a partorire una femmina in modo che i ragazzi potessero poi sposarsi, ma nessuna delle due volle insinuare il dubbio che il rispettivo aristocratico consorte, il conte, non avesse a cuore la trasmissione dell’avito cognome, cosí nacquero solo figli maschi), erano di una bellezza mozzafiato, intelligenti, coraggiosi, somigliavano nei tratti somatici un po’ alle mamme e un po’ ai padri.
I nostri giochi presentavano i tipici tratti della drammaturgia brechtiana. Non disponendo di scenografie, e trovando raramente costumi da indossare, a parte i rari casi in cui la mamma ci permetteva di usare uno dei suoi vestiti, magari la stola merlettata ereditata dalla bisnonna o il ventaglio in piume di struzzo, ci mettevamo in un angolo della stanza e decidevamo semplicemente in quale luogo ci trovavamo, e quali abiti indossavamo. Chiunque ripensi ai giochi della propria infanzia ricorda quanto poco importante fosse appesantire la fantasia con elementi esteriori, bastava sedersi tra le quattro gambe all’aria del tavolo capovolto, immaginando di essere in un mare in tempesta, e solo un folle non avrebbe visto che le onde intorno esplodevano davvero in rabbiosi spumeggii. Dato che nelle nostre messinscene eravamo in due, prima di giocare stabilivamo chi avrebbe deciso dove ci trovavamo e che cosa bisognava fare, poi iniziava l’azione, piú o meno cosí: – Io adesso sono Roger e devo andare in guerra, arriva la richiesta della partenza immediata, tu in principio non sai niente –. Agancsos cessava di essere lei, diventava la moglie del conte Roger, madre di un bambino, parlava come pensavamo parlasse la moglie di un conte, raccontava con dolcezza le novità della tenuta, qualche pettegolezzo sulla vita di società che riteneva curioso per me, nei panni del conte Roger, ma appena le annunciavo che dovevo arruolarmi e sarebbe toccato a lei vegliare fedelmente su tutto durante la mia permanenza al fronte, cambiava repentinamente umore. Non riuscivamo a simulare il pianto, però lo spiegavamo: – Ora devo piangere, – diceva Agancsos, come fosse la regista di se stessa, quando mi ritiravo nei miei saloni per affidarla insieme col bambino al fedele servitore, e dato che il fedele servitore era uno dei miei ruoli, dialogavo in un monologo. Con lo stesso sistema decidevamo quando marito e moglie si baciavano. – Qui c’è un bacio, – diceva quella che al momento non recitava un ruolo preciso. Era commovente, incantevole.
Tutto sommato preferivamo le situazioni tristi ai giorni spensierati della vita aristocratica. Condivamo spesso l’esistenza di sapori tragici, il conte-chirurgo-aviatore precipitava con l’aereo, sopravviveva a mille pericoli, rischiava l’amputazione di una gamba o della mano. Se cadeva Roger con il suo apparecchio, io, Robert, impugnavo il bisturi e naturalmente lo salvavo, se l’incidente capitava a Robert, era Roger a strapparlo alla morte, e dopo confortavo Agancsos in lacrime. Se prevedevamo scene corali, con personaggi immaginari di contorno, per esempio un ballo nella magione di Lesley (era il luogo in cui abitavo, sa Dio come trovai quel nome; non sapevo bene come fosse fatto una magione, sentivo però che doveva trattarsi di una casa molto nobile, raffinata, degna di un’aristocratica), stabilivamo un canovaccio con le frasi da dire, chi dovesse tacere e ascoltare o anche guardare, e quali fossero le espressioni appropriate, agendo cosí da attori e da narratori al tempo stesso. La nostra concezione di un teatro che prescindeva da elementi visivi esteriori anticipava in modo molto naïf le moderne teorie registiche, possedeva una rude semplicità che non sarei piú riuscita a tradurre in pratica quando mi fossi dedicata a testi teatrali in maniera professionistica. Recitavamo per ore vite immaginarie, che bastavano a consolarci di voglie irrealizzabili, di amarezze patite. Nelle condizioni economiche dei nostri genitori, non potevamo permetterci nulla, ma noi inserivamo gli oggetti ambiti, i desideri, nel dramma a puntate delle nostre vite; se una bambina ci aveva maltrattate, organizzavamo una stupenda serata dove la nemica veniva oscurata dalla nostra bellezza ed eleganza, nessuno la invitava a ballare, e per infierire decidevamo che alla fine rubava un cucchiaio, perché a quel punto un servitore la accompagnava alla porta, anzi, lo faceva uno dei nostri mariti, spesso il conte Roger – il piú duro, perché avevamo stabilito che Robert, il mio marito dagli occhi blu, fosse piú dolce –, e la scaraventava giú dalle scale con un bel calcio nel sedere. Altre volte Agancsos decideva che dopo il matrimonio saremmo vissute in una sola casa, con una di noi al pianterreno, l’altra al piano superiore, i figli crescevano in una stanza comune, i nostri mariti diventavano ottimi amici e, se per caso una delle due fosse stata libera, quando l’altra moriva ne avrebbe automaticamente sposato il vedovo. Delle eventuali reazioni da parte dei naturali eredi di Roger e Robert non ci preoccupavamo affatto, trovavamo piú che naturale esaudire l’ultimo desiderio di una moglie moribonda.
Recitavamo, per tutto il tempo in cui eravamo libere.
A un certo punto ci stancammo dei castelli e dei soliti personaggi. Il passo da quelle policrome esistenze immaginarie, molto teatrali, ai giochi che mettevano in scena la Vita, fu breve. I nostri piccoli drammi, che pensavamo come film (oltre a essere le spose di Robert e Roger, nella variegata gamma dei nostri personaggi eravamo anche due attrici cinematografiche, nonché proprietarie della Star produzioni, gli stabilimenti dove si giravano i nostri film; avevamo sotto gli occhi gli effetti del successo che si poteva ottenere con la recitazione, perché sia Lia Putty, la stella del muto, sia Aranka Hettyey, un’attrice di prosa, erano parenti di papà), in parte erano frutto d’invenzione e nascevano come le sceneggiature embrionali buttate giú da scrittore e regista insieme, in parte erano recite di famose opere teatrali lievemente manipolate, o rielaborazioni personali di letture che adattavo ai nostri scopi e alla mia visione del mondo. Come ho detto, avevo accesso a un’infinità di libri, e se un classico non mi soddisfaceva pienamente lo cambiavo. Ne ricavavo canovacci assolutamente originali, tipo la storia del medico famoso e dell’orfana (la fanciulla all’inizio lavorava in ospedale come donna delle pulizie, poi, dopo i debiti studi, diventava un luminare piú famoso dei colleghi maschi, e al culmine della carriera sposava il professore che in principio era stato sprezzante nei suoi riguardi), una di quelle che interpretavamo piú spesso perché ci piaceva moltissimo (Agancsos era una straordinaria orfanella, appena le spiegai ciò che doveva fare – «Tu lavi le scale, io arrivo, soffri» – lei si mise a sfregare gradini inesistenti utilizzando un secchio inesistente, piagnucolando talmente forte che l’avrebbero sentita anche i sordi, e aveva tutti i motivi di questo mondo, perché io, in base al plot narrativo, le calpestavo le dita delle mani, tutte e dieci, mentre mi dirigevo con passo svelto e fare borioso verso la sala operatoria), ma spesso ricorrevamo a favole completamente inventate. Ricavare drammi da un romanzo classico, o da un’opera teatrale, era un’operazione rapida, semplice, talvolta bastava cambiare un finale, se no prendevamo un episodio e lo sviluppavamo per conto suo o lo mescolavamo con un altro. Amleto, nella nostra versione, sposava Ofelia: perché era proprio la poveretta che doveva annegare? Nel fiume dove lei in origine muore facevamo precipitare l’intera famiglia reale, come vendetta per la morte del padre, Amleto era il pe...