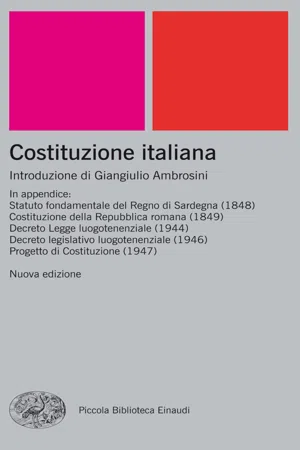![]()
Introduzione
1. La decisione costituente.
L’idea di Costituzione ha lunga storia in Italia. Recepita dalla rivoluzione francese, prende forma piú volte ricalcando quasi alla lettera i modelli altrove elaborati1. La Restaurazione non pone fine all’idea costituzionale, ma inverte la linea di tendenza emersa nell’ultimo decennio del Settecento: la Costituzione cessa di essere espressione della volontà popolare e nelle sue disposizioni scompare ogni riferimento alla sovranità popolare. Le nuove Costituzioni si presentano formalmente come atti unilaterali del sovrano; nonostante questo carattere, il distacco dalle «leggi fondamentali» delle monarchie assolute è profondo. Le Costituzioni dell’Ottocento non sono atti di autolimitazione del potere regio, come forse possono indurre a ritenere i preamboli con le formule di perpetuità e irrevocabilità della Costituzione; proprio queste formule testimoniano i limiti oggettivi del potere costituente del sovrano, il quale può sí «concedere» la Costituzione, ma è privo della potestà di abrogarla o di limitarla. Le pressioni popolari, che rendono in qualche modo obbligata la concessione regia; le forme in cui viene articolata l’organizzazione dei pubblici poteri, che trasforma in «rappresentativa» la monarchia; l’abbinamento alle norme di organizzazione dei poteri pubblici di principî fondamentali relativi ai diritti dei cittadini; sono tutti elementi che concorrono a rendere piú evidente la rottura con gli schemi prerivoluzionari. La rivoluzione francese e l’ideologia che la sorregge hanno lasciato il segno, l’idea di Costituzione e la lotta per la sua realizzazione rimangono un punto di riferimento per le rivendicazioni di libertà. Lo dimostrano le esperienze costituzionali che numerose si susseguono fino al 1848, in un alternarsi di proposte, piú che di concrete attuazioni, spesso interrotte o limitate nel tempo dal precipitare degli eventi politici2.
Diversa, non per i contenuti ma per le vicende che la circondano, è l’esperienza relativa allo Statuto concesso il 4 marzo 1848 da Carlo Alberto3. Destinato ad un ambito politico e territoriale ristretto, lo Statuto del regno sardo diviene Statuto fondamentale del Regno d’Italia senza mutare i suoi tratti formali. La sua lunga esistenza, che conduce sino alle soglie della Costituzione repubblicana, dimostra la idoneità dello strumento costituzionale e la sua capacità di adattamento quando i rapporti di forza non subiscano sostanziali mutamenti. Violentato e mutilato dal fascismo, lo Statuto non perde del tutto la sua efficacia, consentendo quanto meno la sopravvivenza dell’istituto monarchico. Il mutamento dei rapporti di forza, che determina l’abbattimento del fascismo, e il nuovo ruolo assunto dalle masse popolari e dai partiti politici impediranno la pretesa di una sua tardiva reviviscenza. Sarà la stessa monarchia, ridotta al ruolo di luogotenenza di un regno anacronistico, a siglare formalmente una serie di atti di revoca di una Costituzione nelle intenzioni destinata a non essere revocata, e ad attribuire alla volontà popolare il ruolo, già nei fatti conquistato, di unica fonte di legalità.
È vero che, pur nella secolare vicenda statutaria, proposte di modifica e attività costituenti non sono mancate. Già una legge dell’ 11 luglio 1848, conseguente all’accordo fra il governo piemontese e il governo provvisorio lombardo, dispone che «con il mezzo del suffragio universale sarà convocata una comune assemblea costituente, la quale discuta e stabilisca le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale con la dinastia Savoia, secondo l’ordine di successione stabilito dalla legge salica». Ma questa legge resta priva di seguito, cosí come resteranno sulla carta i progetti di una costituente nazionale formulati nel Granducato di Toscana o nella Repubblica romana. La formazione dello Stato unitario procede non in virtú di decisioni assunte da assemblee costituenti, ma in virtú di plebisciti i quali eludono i problemi istituzionali. Dove costituenti vi furono, come a Bologna, Modena, Parma e Firenze, esse si limitano ad accogliere passivamente il principio dell’annessione, anticipando di poco l’esito dei plebisciti. Unica eccezione in questo quadro è fornita dalla Repubblica romana, la quale elabora una propria Costituzione mediante una Assemblea costituente; la stessa scelta repubblicana è operata in sede costituente4. Formalmente entrata in vigore, la Costituzione della Repubblica romana resterà comunque priva di efficacia per il succedersi degli avvenimenti politici5.
Di costituente si ritorna a parlare alla fine del secolo, nel prolungarsi della crisi del Parlamento e di fronte ad un episodio di eccesso di potere dell’esecutivo, l’emanazione non in forma di legge di un decreto (22 giugno 1899 n. 227) limitativo della libertà di stampa. Il dibattito proposto in Parlamento dalla sinistra, che invoca la necessità di modificare le strutture organizzative statali contro il prevalere del potere regio, viene troncato dalla intransigenza della destra, alla quale la sola idea della costituente appare attentato alle prerogative regie, quelle «prerogative» che invece rivendica, contro il «parlamentarismo», con il ritorno allo Statuto6. Il tema rimane accademico, con tutte le precisazioni che le regole giuridiche impongono: non vera costituente, in considerazione della diversa legittimazione dello Statuto attraverso i plebisciti, al piú un’assemblea straordinaria che operi alcune modifiche nel rispetto delle istituzioni monarchiche7. Lo Statuto, comunque, resta immutato.
Senza problemi di assemblea costituente, ma con attività fuor di dubbio costituente8 per il tipo di alterazioni operate nell’ordinamento costituzionale, il fascismo modifica la struttura organizzativa dei poteri e i diritti fondamentali dei cittadini. È sufficiente pensare alla limitazione delle prerogative regie e alla loro riduzione a mera forma, allo svuotamento del Parlamento fino alla sua soppressione come organo rappresentativo, all’accentramento dei poteri nel capo del governo, alla istituzione di nuovi organi costituzionali (il gran consiglio del fascismo), alla sovrapposizione del partito unico alle istituzioni pubbliche, alla soppressione dei diritti di libertà. Alla vigilia del 25 luglio 1943 lo Statuto albertino si può considerare vigente solo in alcune sue parti, neppure le piú rilevanti.
La necessità di una costituente che detti nuove norme sulla organizzazione dei poteri pubblici e sui diritti dei cittadini, senza essere espressamente contemplata, è implicita nei documenti politici dei partiti e dei gruppi che operano in esilio o nella clandestinità. È piú che evidente che l’abbattimento del fascismo abbia, come necessaria conseguenza, il ricorso ad un organo espressione della volontà popolare che provveda a ricostruire su nuove basi la struttura dello Stato. Anche se non manifestata in maniera specifica, la volontà costituente emerge in ogni affermazione avversa al fascismo, in ogni atto destinato a rivendicare le libertà civili, in ogni riconoscimento della volontà popolare.
Il 25 luglio 1943 sembra segnare un passo indietro rispetto alla ipotesi costituente. L’arresto di Mussolini, dopo il voto contrario del gran consiglio, e la nomina del maresciallo Badoglio a capo del governo sono atti di autorità regia, destinati a ripristinare i poteri da tempo abdicati nella sostanza e a dimostrare la continuità dello Statuto, quasi il fascismo e la sua legislazione fossero una parentesi transitoria, eliminabile senza scosse all’assetto istituzionale preesistente. Con la revoca del ministro capo del governo e la nomina di altri al suo posto, il re null’altro fa se non applicare una norma dello Statuto (l’art. 65), cosí come, sciogliendo le Camere e fissando le elezioni nel termine di quattro mesi (dalla fine dello stato di guerra), applica un’altra norma statutaria (l’art. 9).
Fuori dall’apparenza, gli atti regi non rispondono alle norme costituzionali in vigore. Se è vero forse che lo Statuto è ancora in vigore nelle norme ora ricordate, queste norme non possono essere isolate dall’insieme delle disposizioni introdotte dal fascismo, in particolare da quelle relative al gran consiglio del fascismo e alla camera dei fasci e delle corporazioni. Come è stato osservato9,
la deliberazione del gran consiglio si sarebbe potuta utilizzare, secondo del resto l’intento che l’aveva ispirata, per una soluzione della crisi nell’ambito del sistema in cui tale corpo era inserito, non mai per sopprimere il sistema stesso. Se il mutamento per iniziativa del Re della persona del capo del governo, per potere essere efficace, doveva importare come effettivamente importò, il contemporaneo mutamento di tutta la struttura costituzionale creata dopo il 1922, evidentemente esso non si poteva ricondurre alla normale esplicazione della prerogativa regia.
In sostanza, lungi dal compiere atti di ordinaria amministrazione, il re compie direttamente atti di natura costituente, appellandosi formalmente al passato e proponendosi come continuatore di esso, ma sostanzialmente innovando l’ordinamento vigente.
Il tentativo di presentare la restaurazione statutaria come atto legittimo e necessario si scontra sia con le condizioni richieste dai governi con i quali sono in corso trattative per l’armistizio, sia con l’atteggiamento dei partiti politici usciti dalla clandestinità. Una delle condizioni dell’armistizio è quella di defascistizzare lo Stato10 e di riconoscere al popolo italiano il diritto di scegliere democraticamente la propria forma di governo, una volta cessate le ostilità11. D’altra parte i partiti politici, riuniti nell’organismo unitario del CLN, esigono l’immediata costituzione di un governo di larga base democratica da cui siano esclusi uomini in qualunque modo compromessi con il fascismo, e sostengono che ogni decisione definitiva circa la ricostruzione dello Stato democratico sia rimessa alla volontà popolare al termine degli eventi bellici e a liberazione del territorio avvenuta. Sia l’uno che l’altro atteggiamento hanno come immediato riflesso la cessazione di efficacia dello Statuto e la sostituzione ad esso di una Costituzione provvisoria. Bisogna attendere il giugno del 1944 per addivenire ad un atto formale che definisca i limiti della provvisorietà del nuovo ordinamento, di fatto instaurato, e sanzioni la decisione costituente.
Un cenno, sia pure sommario, alle vicende intermedie, appare necessario. L’iniziale opposizione regia alle richieste dei partiti politici si trasforma in rinvio di ogni decisione alla liberazione di Roma, nella consapevolezza che l’immediata costituzione di un governo rappresentativo dei partiti antifascisti avrebbe significato riconoscere che soltanto essi gestivano il potere politico e che la fonte della legalità non era piú lo Statuto. Il governo Badoglio resta un governo di affari, nel fallimento di ogni trattativa con i partiti, con la conseguenza dell’accrescersi del divario fra potere reale e potere formale. Fra i partiti politici, peraltro, non vi è unanimità di opinioni sulle questioni istituzionali. Da un lato si sostiene la necessità di conservare l’istituto monarchico, pur esigendo l’allontanamento del re e la rinunzia al trono da parte dell’erede legittimo; eventi da realizzarsi mediante la reggenza da parte del figlio, minore di età, del principe ereditario (è la tesi del partito liberale). Dall’altra parte si richiede la chiamata in giudizio del re e la costituzione in Parlamento dei rappresentanti dei partiti politici (è la tesi del partito socialista e del partito di azione, cui si associa il partito comunista, proposta al congresso dei partiti del CLN a Bari il 28 gennaio 1944). Respinta la tesi liberale, non favorita neppure dalla monarchia, la tesi delle sinistre è superata da un compromesso: i partiti del CLN esigono la formazione immediata di un governo investito di pieni poteri, formato dai partiti rappresentati nel congresso del CLN (socialisti, comunisti, democratici cristiani, liberali, azionisti, oltre una rappresentanza locale della democrazia del lavoro) e con il compito, tra l’altro, di preparare un’assemblea costituente da convocarsi dopo la cessazione delle ostilità12.
Le deliberazioni del congresso di Bari prendono forma in una serie di atti: il ritiro dalla vita politica del re, annunciato il 12 aprile 194413 e reso esecutivo con il regio decreto 5 giugno 1944 n. 140; le dimissioni del gabinetto Badoglio e la formazione di un nuovo governo con la partecipazione dei partiti del CLN (22 aprile 1944), sotto la presidenza dello stesso Badoglio; la decisione attuata con decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 15114, secondo cui le forme istituzionali siano scelte dal popolo attraverso una Assemblea costituente eletta a suffragio universale. Con quest’ultimo atto legislativo è sanzionata la fine di ogni tentativo di restaurazione dello Statuto albertino e lo Statuto stesso perde ogni vigore. Non è atto di continuità statutaria la nomina di un governo i cui componenti sono imposti dai partiti politici, come non lo è l’espediente della luogotenenza generale del regno. A questo proposito va sottolineato come non si dia luogo alla abdicazione del re e alla successione al trono del principe ereditario, bensí si dia vita ad una soluzione che non ha precedenti. Non che la luogotenenza, non prevista espressamente dallo Statuto, non abbia esempi numerosi nella prassi; ma la luogotenenza del 1944 ha caratteri assolutamente dissimili da quelli sino allora conosciuti15 e soprattutto contrasta con la temporaneità, che le è connaturale, la decisione «definitiva e irrevocabile» del re di ritirarsi dalla vita politica. La rottura con lo Statuto non potrebbe essere piú netta e, a sottolinearla ulteriormente sul piano formale, può essere significativa una norma secondaria del decreto n. 151, relativa alla nuova formula di giuramento dei ministri all’atto dell’assunzione in carica 16.
I momenti successivi di realizzazione della decisione costituente si individuano nella istituzione della Consulta nazionale, con funzioni consultive del governo e con il compito di elaborare un progetto di legge per le elezioni dell’Assemblea costituente17, nella istituzione del Ministero per la Costituente18, nella approvazione della legge elettorale19. La decisione costituente si perfeziona con il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 9820, che scinde la decisione sulla forma di Stato demandata ad un referendum popolare, dalla redazione del nuovo testo costituzionale affidata all’Assemblea costituente eletta a suffragio universale. L’esito del referendum del 2 giugno 194621 e delle contestuali elezioni per la Costituente22 concludono la fase preliminare della attuazione costituzionale.
2. La Costituente.
La Costituzione repubblicana non nasce, come dimostrano le vicende relative alla scelta costituente, da decisioni affrettate o da colpi di mano operati da forze politiche occasionalmente maggioritarie. Nasce da una profonda meditazione, da una consultazione popolare, da una dialettica tra forze politiche diverse e insieme unite dalla comune esigenza di rinnovare le strutture organizzative dello Stato e di restituire, potenziati, i diritti civili violentemente soppressi dal fascismo.
Travagliata è la decisione costituente, non minore è il travaglio nella redazione del testo costituzionale. I lavori dell’Assemblea costituente si protraggono oltre il prevedibile e si concludono dopo circa diciotto mesi di dibattiti il 22 dicembre 1947, quando il testo definitivo è approvato dalla stragrande maggioranza dei deputati23. Non tutti i 556 eletti all’Assemblea partecipano direttamente ai lavori di redazione del testo costituzionale, per ovvi motivi di carattere pratico. Un organismo cosí numeroso, e investito di compiti politici di varia natura, non potrebbe evidentemente affrontare con sufficiente approfondimento i problemi che si pongono nella individuazione degli aspetti essenziali di un documento di tanto rilievo. Si addiviene, pertanto, alla nomina di una speciale Commissione, composta di 75 membri in rappresentanza e in proporzione a tutte le forze presenti nell’Assemblea, con il compito specifico di redigere un progetto di Costituzione da sottoporre all’intera Assemblea. La Commissione si suddivide in un primo tempo in tre sottocommissioni, per i diritti e doveri dei cittadini, per l’ordinamento costituzionale, per i diritti e doveri economico-sociali. La seconda di queste, di fronte ai problemi complessi e alla entità del compito affidato, si suddivide poi in due sezioni, una relativa al potere esecutivo, l’altra relativa al potere giudiziario, ed ancora all’interno della prima sezione si opera una ulteriore suddivisione, mediante l’affidamento dell’ordinamento regionale ad un comitato ristretto di dieci membri. Il lavoro espletato da sottocommissioni, sezioni e comitato deve infine essere sottoposto al giudizio della Commissione, che lo deve proporre all’Assemblea per l’approvazione definitiva.
La mancanza di coordinamento fra le diverse parti del testo e la sovrapposizione delle materie inducono a rinviare l’esame del progetto da parte della Commissione dei 75, preferendosi affidare ad una commissione detta di «coordinamento» l’unificazione dei diversi testi elaborati e la formulazione di un progetto omogeneo ed unitario, politicamente e giuridicamente coerente. Viene cosí istituito un comitato di 18 membri, che elabora il testo definitivo del progetto24. Questo viene fatto proprio, senza sostanziali variazioni, dalla Commissione dei 75.
Il 31 gennaio 1947 il progetto di Costituzione viene presentato alla Assemblea costituente25, accompagnato da una relazione di sintesi dei lavori preliminari. La discussione in Assemblea si apre il 4 marzo e si sviluppa attraverso 170 sedute, la presentazione di 1663 emendamenti, lo svolgimento di 1090 interventi, la votazione su numerose questioni controverse e su alcuni ordini del giorno. La votazione finale non conchiude i lavori, è necessario un ulteriore esame da parte di un comitato di revisione, appositamente costituito per perfezionare la forma e lo stile del testo. Il comitato opererà, al di fuori della forma, anche alcune variazioni che rivestono carattere sostanziale26.
Come appare da questa sommaria sintesi dei lavori della Costituente, l’elaborazione del testo costituzionale è opera di non lieve impegno. I problemi di carattere tecnico, talvolta prima ancora di quelli di carattere politico, rendono prudenti e critici i deputati eletti il 2 giugno 1946. La Costituente ha come compito primario la redazione del testo costituzionale, al tempo stesso ha compiti eminentemente politici ed in parte legislativi, non dissimilmente da un Parlamento, onde la sua attività risente delle vicende politiche generali, dei condizionamenti internazionali, dei mutamenti delle maggioranze governative. Le decisioni su singoli punti vengono in alcuni casi raggiunte con strette maggioranze, frutto di compromessi o rinunce da parte delle forze politiche che esprimono diverse e contrastanti ideologie27.
Ciò nondimeno il testo risulta complessivamente lineare e tale da cogliere, sinteticamente, i maggiori problemi che si agitano nel momento storico in cui viene formulato. Giudicato da taluni avanzato rispetto alla società italiana del dopoguerra, da altri è considerato arretrato rispetto ai filoni culturali e giuridici del mondo occidentale a cui, in ultima analisi, piú direttamente si ispira. Ritenuto compromissorio fra le forze politiche dominanti nel contesto politico, da altri è valutato tale da eludere immediate compromissioni e quindi da rinviare la soluzione dei nodi principali della società alla successiva evoluzione dei rapporti...