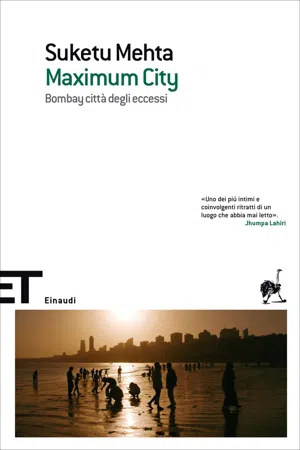![]()
Parte prima
Potere
![]()
Geografia personale
Nella città di Bombay presto vivrà piú gente che nel continente australiano. urbs prima in indis, recita la targa sulla Porta dell’India. È anche l’Urbs Prima in Mundis, perlomeno in un settore, quello che costituisce il primo test di vitalità di una città: il numero di persone che ci vivono. Con i suoi quattordici milioni di abitanti, Bombay è la città piú grande su un pianeta di abitatori di città. Bombay rappresenta il futuro della civiltà urbana del pianeta. Che Dio ci aiuti. Ho lasciato Bombay nel 1977 e ci sono tornato ventun anni dopo, nel 1998, quando era diventata Mumbai. Ventun anni: il tempo sufficiente a un essere umano per nascere, ricevere un’istruzione, avere l’autorizzazione a bere, sposarsi, guidare, votare, andare in guerra e uccidere. In tutto questo tempo, non ho perso il mio accento. Parlo come un ragazzo di Bombay; come tale vengo identificato a Kanpur o in Kansas. «Di dove sei?» In cerca di una risposta – Parigi, Londra, Manhattan –, finisco sempre per rispondere: «Di Bombay». Per qualche ragione sepolta tra i relitti della sua attuale condizione, quella di catastrofe urbana, è la città che ha piú presa sul mio cuore, una bella città sul mare, un’isola-stato di speranza in un paese antichissimo. Sono tornato a cercare quella città con una domanda molto semplice: Si può tornare a casa? Mentre cercavo, ho trovato le città dentro di me.
Sono un uomo di città. Sono nato in una città agonizzante, Calcutta. Poi mi sono trasferito a Bombay e ci ho vissuto nove anni. Poi a New York, otto anni a Jackson Heights. Un anno a Parigi. Cinque anni nell’East Village. Un altro annetto avanti e indietro da Londra. Le uniche eccezioni sono stati i tre anni a Iowa City, che non è propriamente una città, e altri due a New Brunswick, una cittadina universitaria del New Jersey che mi ha preparato al ritorno in città. I miei due figli sono nati in una grande città, New York. Ho scelto di vivere nelle città, e sono quasi certo che morirò in una città. In campagna non so cosa fare, anche se non mi dispiace per i weekend.
Appartengo a una famiglia di mercanti giramondo. Il mio nonno paterno lasciò il Gujarat rurale nei primi anni del secolo per andarsene a Calcutta a lavorare con suo fratello nel commercio di gioielli. Quando, negli anni Trenta, il fratello di mio nonno si avventurò per la prima volta in territorio internazionale, in Giappone, dovette tornarsene indietro e chiedere scusa, turbante in mano, agli anziani della casta. Ma i suoi nipoti – mio padre e mio zio – continuarono a muoversi, prima a Bombay e poi, attraverso il nero oceano, ad Anversa e a New York, per accrescere ciò che era stato dato loro. Il nonno materno lasciò il Gujarat per il Kenya quando era giovane, e adesso vive a Londra. Mia madre è nata a Nairobi, ha studiato a Bombay e adesso vive a New York. Nella mia famiglia, decidere di andarsene a vivere in un altro paese non è mai stato motivo di profonde riflessioni. Si va dove gli affari chiamano.
Una volta, con mio nonno, sono tornato nella casa di famiglia a Maudha, un villaggio del Gujarat diventato adesso una cittadina. Seduto nel cortile della vecchia casa con le sue massicce travi di legno, il nonno cominciò a presentarci ai nuovi proprietari, una famiglia di saraf, prestasoldi gujarati, ai cui occhi Maudha era la grande città. – Questo è mio genero, che vive in Nigeria.
– Nigeria, – disse il saraf, annuendo.
– E questo è mio nipote, che è di New York.
– New York, – ripeté il saraf, sempre annuendo.
– E questa è mia nuora, che è di Londra.
– Londra.
– Adesso vivono a Parigi.
– Parigi, – ripeté rispettosamente il saraf. Se a quel punto mio nonno avesse detto che lui viveva sulla luna, il saraf avrebbe annuito senza battere ciglio e ripetuto: «Luna». La nostra dispersione era tale da rasentare il farsesco, eppure eravamo lí, in visita alla casa dove mio nonno è cresciuto, una famiglia ancora unita. La famiglia era l’elastico che ci spingeva a ritrovarci, per quanto lontano ci fossimo spinti.
Fu la muqabla, la competizione commerciale, che costrinse mio padre a lasciare Calcutta. Le modalità con cui i gioielli venivano acquistati e venduti nel giro d’affari di mio nonno. Un gruppo di venditori si dava appuntamento con il broker nell’ufficio del compratore, poi avevano inizio le contrattazioni. Il prezzo non veniva detto ad alta voce bensí indicato dal numero di dita che il venditore sollevava sotto un lembo del dhoti, e che l’acquirente stringeva. I sonori insulti all’acquirente erano parte integrante della trattativa. «Sei impazzito? Credi forse che io venda a quel prezzo?» Facendo mostra di estrema frustrazione, il venditore usciva sbattendo la porta e senza smettere di urlare. Ma stava ben attento a dimenticare l’ombrello. Sarebbe tornato a riprenderlo dieci minuti dopo per dar tempo all’acquirente di riconsiderare la propria offerta e concludere l’affare, e a quel punto il broker avrebbe detto: «Su, una stretta di mano!», e tutto si sarebbe risolto con grandi sorrisi. Fu a causa di queste sceneggiate che mio padre decise di lasciar perdere il commercio di gioielli a Calcutta. Non sopportava gli schiamazzi e gli insulti; era un uomo educato.
Il fratello di mio padre era partito per Bombay nel 1966, contro la volontà di mio nonno, che non vedeva perché se ne dovesse andare. Ma lo zio era un uomo giovane e Calcutta si avviava al tramonto. A Bombay, entrò nel commercio di diamanti. Tre anni piú tardi, poco dopo la nascita della mia sorella minore, a Ahmadabad, i miei genitori passarono da Bombay. Lo zio si era appena sposato e propose a mio padre di restare. E cosí facemmo. Quattro adulti, un bambino e una neonata in un appartamento di una stanza, con ospiti che andavano e venivano in continuazione. Vivevamo come una sola famiglia, dividendo la casa, le spese e facendo bastare il poco spazio disponibile. Come fanno a starci, quattordici milioni di persone su una sola isola? Come facevamo noi nell’appartamento di Teen Batti.
Mio padre e lo zio trovarono la loro nicchia nel commercio dei diamanti. Ci trasferimmo in un appartamento con due stanze da letto, in un complesso edilizio in riva al mare, il Dariya Mahal, un tempo proprietà del marajà di Kutch. Una famiglia di industriali marwari aveva acquistato il palazzo e i terreni circostanti: tagliarono gli alberi, svuotarono il palazzo di tutti gli oggetti antichi e ci misero una scuola per bambini. Intorno al palazzo fecero costruire un complesso di tre edifici: Dariya Mahal 1 e 2, edifici di venti piani che sembrano libri mastri aperti, e il Dariya Mahal 3, dove io sono cresciuto, il figliastro di dodici piani, tozzo e stolido.
Mio zio e mio padre facevano regolari viaggi di affari ad Anversa e negli Stati Uniti. Quando mio padre volle sapere che cosa volevo dagli Stati Uniti, gli chiesi una maglietta gratta e annusa di cui avevo letto su una rivista americana, invece lui tornò con un’enorme confezione di marshmallow. Prima che la zia se ne impadronisse, mangiai piú che potei di quelle cose bianche cotonose, cercando di capire di cosa fossero fatte. A sentire lo zio, fu dopo uno di quei viaggi che mio padre ebbe la sua epifania, mentre si faceva la barba, come spesso succede quando ci si guarda allo specchio senza particolare concentrazione. Decise di trasferirsi negli Stati Uniti. Non per la libertà o per il modo di vivere, ma per fare piú soldi.
La vita di ogni persona è dominata da un evento centrale che configura e distorce tutto ciò che viene dopo e, in una visione retrospettiva, tutto ciò che era avvenuto prima. Per me, fu l’andare a vivere negli Stati Uniti, a quattordici anni. Un’età difficile per cambiare paese. Non hai ancora finito di crescere nel posto in cui sei e nel posto in cui vai non ti senti mai a tuo agio. Io non sapevo assolutamente niente degli Stati Uniti, non c’ero mai stato. Ero molto diverso dalla successiva generazione di miei cugini, Sameer, per esempio, che a sedici anni è volato da Bombay a New York ed è sceso all’aeroporto JFK con in testa un berretto da baseball dei Mets e già con un mezzo accento americano. Nel giro di ventiquattr’ore io passai dalla fanciullezza all’età adulta, dall’innocenza alla conoscenza, dalla predestinazione al caos. Tutto ciò che mi è capitato da allora, ogni atto, minuscolo o enorme – il modo in cui adopero la forchetta o faccio l’amore, la scelta di una professione e di una moglie –, è dipeso da quell’evento centrale, quel fulcro del tempo.
C’era una pila di Reader’s Digest nella stanza sul retro della casa di mio nonno a Calcutta, oscura, calda, protettiva. Lí, durante l’estate, avevo letto avventurose biografie, spy stories su comunisti codardi, e antiquate storielle di bambini e militari che tutta la famiglia poteva godersi. Fu la mia introduzione agli Stati Uniti. Potete immaginare la mia sorpresa quando ci arrivai. Fui comunque fortunato, anche se allora non lo sapevo, perché fra tutte le città dove poteva portarci mio padre scelse New York. «È proprio come Bombay». Cosí di solito viene descritta New York in India.
Il primo anno dopo il trasloco negli Stati Uniti, ordinai per posta i tesori fino allora inaccessibili che avevo visto reclamizzati nella seconda di copertina dei fumetti. Per i miei amici di Bombay ordinai il cicalino della gioia, il fantasma fluttuante, l’hovercraft, e i quattrocchi ai raggi x. Arrivò una scatola marrone. Prima di aprirla restai a fissarla per alcuni minuti; ecco ciò che per tanti anni mi era stato precluso. Poi si rovesciò fuori la mercanzia. Il fantasma fluttuante era un sacchetto di plastica bianca per pattumiera con un’asticella fissata al bordo superiore: teoricamente lo si doveva ruotare nell’aria per spaventare la gente. I quattrocchi ai raggi x erano un paio di occhialoni di plastica, simili agli occhiali tridimensionali che ti danno nei cinema per vedere i film di fantascienza, con uno scheletro approssimativo disegnato su entrambe le lenti. L’hovercraft era una specie di ventilatore rosso collegato a un motorino e in effetti, accendendolo, si sollevava scivolando su una superficie piatta. Il cicalino della gioia era un piccolo arnese metallico da infilare intorno al palmo, come un anello, in modo tale che stringendo la mano della vittima si premeva un pulsante e l’arnese vibrava bruscamente. Guardai quella roba sparpagliata sul pavimento. Mi era già successo anche a Bombay di sentirmi fregato; conoscevo bene quella sensazione. Comunque spedii il pacco ai miei amici di Bombay suggerendo i possibili usi dei vari oggetti; il fantasma, per esempio, poteva essere attaccato a un cordino e fatto penzolare sui balconi dei piani sottostanti, magari per spaventare i bambini piccoli nel buio.
Sapevo che i miei doni sarebbero stati apprezzati. Quale che fosse il loro valore, erano pur sempre importati, e come tali andavano custoditi gelosamente. Nel salotto della nostra casa di Bombay c’era uno stipetto a vetri. Conteneva gli oggetti importati dall’Europa e dall’America, i trofei dei viaggi di lavoro di mio zio: automobiline Matchbox, bottigliette di liquore in miniatura, un cilindro di fiammiferi giganti a foggia di guardiano della torre di Londra con tanto di colbacco di pelliccia come chiusura, un modellino della Tour Eiffel. Conteneva anche dei giocattoli per bambini: un razzo Apollo 11 a pile, un’auto della polizia con un lampeggiante blu girevole, una bambola capace di bere e bagnare il pannolino, che non veniva tirata fuori quasi mai. I bambini del palazzo si riunivano intorno allo stipetto e guardavano i giocattoli... giocattoli che non eravamo autorizzati a toccare per timore che li rompessimo.
Anche nella nostra casa di New York c’era uno stipetto. Conteneva i souvenir dell’India: una coppia di bambole, nonno e nonna, lui in dhoti, lei in sari di cotone; una statuetta di marmo di Ganesh; una maschera di legno di Hanuman; un modellino del Taj Mahal con una luce che brillava all’interno; una danzatrice di bharata natyam con la testa che oscillava sul collo; un orologio di bronzo forgiato come la mappa ufficiale dell’India con tutto il Kashmir ripreso a pakistani e cinesi. Quando nacque il nuovo bambino, non aveva il permesso di aprire lo stipo e giocare con quegli oggetti: erano troppo fragili, poteva farsi male. Passava il suo tempo con il naso schiacciato contro il vetro, fissando la sua eredità, come una vespa alla finestra.
Quando ci trasferimmo a New York, Bombay mi mancava come un organo del mio corpo. Lasciando Bombay pensavo di essere sfuggito alla peggior scuola del mondo. Mi sbagliavo. La scuola maschile cattolica che frequentavo a Queens era peggio. Si trovava in una enclave di classe operaia bianca assediata da immigrati di paesi piú scuri. Fui uno dei primi iscritti appartenenti a una minoranza, un rappresentante di tutto ciò da cui cercavano di difendersi. Ero stato appena ammesso, quando un ragazzo lentigginoso con rossi capelli ricciuti venne al tavolo dove stavo consumando il mio pranzo ed esclamò: – Lincoln non avrebbe mai dovuto liberare gli schiavi! – Gli insegnanti mi definivano pagano. Nella foto nell’annuario scolastico mi si vede mentre guardo l’obiettivo con la didascalia «È talmente efficace che posso anche saltare un giorno», chiaro riferimento allo slogan di una marca di antisudoriferi. Era cosí che la scuola mi vedeva: un infedele puzzolente, che emanava gli odori schifosi della cucina del suo paese natale. Il giorno del diploma, varcai il cancello coronato di filo spinato, posai le labbra sul marciapiede e baciai il suolo per la gratitudine.
A Jackson Heights ci riavvicinammo a Bombay, io e il mio migliore amico, Ashish. Anche lui si era trasferito a Queens da Bombay, a quindici anni. I pomeriggi piú felici erano quelli in cui andavamo a vedere i film hindi all’Eagle Theater. Con una sola lettera cambiata, prima era l’Earle Theater, un cinema a luci rosse. Sullo stesso schermo che prima si riempiva di peni mostruosi eiaculanti in molteplici vagine si vedevano ora le leggende del dio Krishna dalla pelle blu; nei nuovi film non veniva mostrato un solo seno, non un bacio. Forse il cinema era stato purificato. Io comunque esaminavo attentamente i sedili prima di sedermici.
Nei film mi capitava di intravedere il Dariya Mahal, il palazzo dove un tempo abitavo. Parlavamo l’hindi bombaita, io e Ashish, quando volevamo parlare di persone accanto a noi in metropolitana o insultare i nostri insegnanti in loro presenza. Divenne la lingua del sabotaggio. Era una lingua adatta alle barzellette; una lingua da maschi. Bevevamo e imprecavamo in hindi. Andavamo a spasso per le strade di Jackson Heights, Ashish, il suo vicino Mitthu e io, cantando le canzoni dei film hindi degli anni Settanta, quando eravamo stati portati via. Tornavamo a casa sulle ali della musica, la linea aerea piú a buon mercato. Nelle sere di primavera, l’aria si addolciva e ci portava notizie da casa, dal passato, che in gujarati è detto bhot kali, tempo spettrale. Una sera accostò un’auto della polizia. I poliziotti scesero: – Cosa state combinando? – E noi: – Niente! – Tre giovani gujarati per la strada, che cantano in modo sospetto. – Lo sapete che potete essere arrestati per vagabondaggio? – Era un reato punibile con la galera: andare a spasso nel tempo spettrale. Proseguimmo, e quando l’auto della polizia si fu allontanata riprendemmo a cantare, addolcendo il paesaggio di Jackson Heights, rendendolo familiare, trasformandolo in Jaikisan Heights.
Quello fu veramente il tempo dell’esilio, quando forze piú grandi di me mi impedirono di tornare indietro. Era diverso dalla nostalgia, che è solo il desiderio di sfuggire alla linearità del tempo. Compilai, sul retro del diario scolastico, un calendario che iniziava con i primi giorni di primavera. Mio padre mi aveva detto che a fine anno mi avrebbe mandato a Bombay. Ogni giorno facevo una croce su quello appena passato e contavo i restanti giorni come se stessi scontando una condanna. La sera ero felice perché era un giorno di meno negli Stati Uniti e un giorno di piú verso la mia liberazione. Poi, una settimana prima delle vacanze estive, mio padre mi comunicò che non poteva mandarmi in India. Ci sarei andato l’anno successivo, dopo il diploma. Ero perduto.
Esistevo a New York, ma vivevo in India, prendendo piccoli treni della memoria. I campi al tramonto. Gli uccelli che ti volano sopra la testa tornando al nido, l’auto che accosta lungo la strada e tu che scendi. Riandavo ai dettagli: la complessità dell’albero di peepal contorto sul ciglio della strada, le formiche che ci girano intorno. Vai a far pipí tra i cespugli, alzi la testa e guardi. Un luogo tiepido, intimo, umido, sei di nuovo protetto. Non c’è in giro nessuno, né nei campi, né intorno alla capanna che intravedi in lontananza. In città ti aspetta il pranzo, a casa della zia, ma tu vuoi restare lí, attraversare i campi per conto tuo, raggiungere la capanna del contadino, chiedere un po’ d’acqua, vedere se puoi restare qualche giorno nel villaggio. Sbucano un paio di mosche e si mettono a ronzarti intorno alla testa; cerchi di mandarle via e continui a pisciare, rovinando le scarpe. Dici: – Bhenchod!
Mi mancava quella parola, mi mancava poter dire bhenchod a persone che capiscono. Non significa «quello che fotte sua sorella». Cosí è troppo letterale, troppo volgare. È piuttosto un intercalare, una sottolineatura, innocua come «merda» o «accidenti». Si possono identificare i diversi paesi dell’India in base all’uso che fanno di questa parola: dal punjabi bhaanchod allo smilzo pinchud bombaita, al bhenchow gujarati, all’elaborato bhen-ka-lowda di Bhopal. I parsi lo usano in continuazione, le nonne e i bambini di cinque anni, casualmente e senza nessuno scopo preciso se non di riempitivo: «Qui, bhenchod, portami un bicchier d’acqua». «Sbrigati, bhenchod, che oggi sono andata in quella bhenchod di una banca». Da bambino, mi sforzavo di non imprecare il giorno del mio compleanno. E con i bambini jain ci giuravamo di «non usare la parola che inizia per B».
Nel mio primo inverno a New York, con addosso una giacca di gommapiuma che i miei avevano comprato a Bombay e che, anziché preservarlo, disperdeva nell’atmosfera il tepore del mio corpo, scoprii che urlando quella parola potevo produrre calore. Camminando tra le raffiche di nevischio, a testa bassa, ruggivo: «Bhenchod! Bheyyyyyn-chod!» Nel tragitto verso la scuola, quasi due chilometri, percorrevo le tranquille strade residenziali di Queens, cosí credo che i bravi pensionati irlandesi, italiani e polacchi che durante il giorno stavano in casa abbiano udito quella parola urlata a pieni polmoni, nelle giornate molto fredde, da un ragazzetto scuro di pelle vestito in modo inadatto al clima.
Quando a diciassette anni tornai finalmente a Bombay per una vacanza, tre anni dopo che me n’ero andato, la città e i miei amici erano cresciuti in modo strano, folle. Tutti fumavano, tanto per cominciare, e io no. Tutti bevevano, e io no. Nitin mi mostrò un trucco con la bottiglia prontamente svuotata di Chivas Regal che gli avevo portato: ne strofinò il fondo con le mani finché il vetro fu caldo e allora ci accese sotto un fiammifero. Ne saettò fuori una seducente fiammata blu. Sapeva cosa fare con la bottiglia quando era piena, e sapeva cosa farne quando era vuota.
I miei amici avevano abbandonato gli scogli sul mare di fronte al Dariya Mahal, ora accerchiato da una baraccopoli, per le attrazioni di una sala giochi. Il vecchio palazzo al centro del cortile, che era diventato una scuola femminile, era cresciuto di un piano. Me ne rammaricai. Abbiamo bisogno di veder conservate intatte le stanze dell’infanzia, gli stessi quadri alle pareti, il letto nello stesso angolo, la stessa inclinazione della luce del sole alla stessa ora del giorno. Avevo l’impressione che la stanza fosse stata affittata a un pensionante e che non avrei mai potuto tornarci. Non ero piú un bombaita; d’ora in poi avrei fatto esperienza della città in veste di NRI, indiano non residente. Ma pur vivendoci, interi universi della città mi restavano estranei quanto i ghiacci artici e i deserti arabi.
La mia famiglia cercò di coinvolgermi nel commercio di diamanti. La mattina mi alzavo e andavo in ufficio con lo zio. Non fu un apprendistato soddisfacente. Ben presto ne ebbi abbastanza dell’«assortimento», suddividere le pietre lucenti in base alle imperfezioni. Commettevo un sacco di errori. – Prendi cantonate, come il presidente Carter, – disse il socio dello zio, nel 1980. Non entrai in affari, ma continuai ad andare avanti e indietro, trascorrendo periodi sempre piú lunghi in India, anche sei mesi ogni volta. Non era un vero e proprio viaggiare, piuttosto una forma di lavoro migrante. Assumevo impegni a occidente – avevo cominciato a scrivere dell’India – e li svolgevo a oriente. Tornavo ogni quattro anni, poi ogni due, poi una volta all’ann...