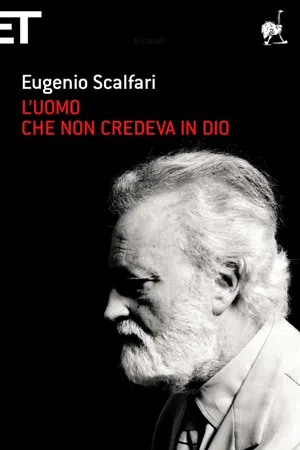![]()
Capitolo nono
Un mestiere crudele
Tra la scrittura e i pensieri c’è una strettissima corrispondenza. Tra i pensieri e le parole. Tra le parole e la scrittura. Si può pensare senza parole? Si può parlare senza scrivere?
Gli studiosi del linguaggio hanno formulato varie teorie su questi complicati e misteriosi rapporti, da Humboldt e Wittgenstein fino alla nascita di una vera e autonoma scienza dei segni. Alcuni sostengono che è il pensiero a creare la parola, altri l’opposto. Io credo che le parole nascano da bisogni e da paure primarie e dalla nostra innata socievolezza. L’uomo ha fame, sete, terrore delle belve e dei tuoni, è invaso da un flusso continuo di emozioni che richiedono di essere espresse e comunicate. Il linguaggio nacque cosí.
La scrittura viene dopo, quando lo svilupparsi della socievolezza renderà necessario comunicare con interlocutori lontani e quando, piú tardi, si vorrà anche lasciare ai posteri memoria di sé. Quest’uso della scrittura segnerà un salto qualitativo della specie, la nascita delle Arti, delle Muse e delle Grazie. Cioè dello stile.
È un altro connotato esclusivo della nostra specie quello di voler interloquire con i posteri, e durerà fino a quando la nostra specie scomparirà. Il bisogno di interloquire con i posteri fornisce un segnale prezioso per misurare la nostra vitalità. L’indebolirsi della sua intensità segnala un inizio di declino.
Noi ci troviamo ora in una fase di declino e ne abbiamo la percezione perché avvertiamo sempre meno il bisogno di interloquire con i posteri. Il bisogno di futuro si è affievolito.
Con il diffondersi della scrittura nacquero anche nuovi mestieri. Scrivere diventò un mestiere. Insegnare a scrivere e a leggere un altro mestiere. Il dominio, fin lí riservato alla spada, incluse anche i detentori del sapere. Guerrieri e sapienti, spesso in lotta tra loro, si impadronirono del potere dominando la moltitudine dei disarmati e degli ignoranti.
Sono trascorsi secoli, anzi millenni, ma la vera lotta di classe è ancora quella tra chi possiede gli strumenti della conoscenza e della guerra e chi ne è privo. La modernità, la globalizzazione, il progresso fulmineo delle tecnologie hanno accentuato questa diseguaglianza, ma al tempo stesso hanno fornito alla classe dominata nuovi strumenti di inclusione e di liberazione. Sicché il futuro dello scontro si gioca oggi sul terreno dell’accesso ai saperi.
Vagheggiare la scomparsa del dominio e delle classi che se lo contendono sa molto di utopia. È piú ragionevole sperare che l’esercizio del dominio non assuma connotati castali e non chiuda l’accesso agli strumenti della conoscenza. Insomma la democrazia, nelle forme richieste dalla struttura politica, culturale, economica che di volta in volta le forze sociali configurano. I detentori del potere puntano invece su forme autocratiche. Il pendolo della storia oscilla da secoli tra queste due alternative.
Tra i vari mestieri che hanno la scrittura come base principale, quello di piú recente diffusione è stato il giornalismo. Le condizioni della sua nascita datano dall’invenzione della stampa, preliminare necessario ma non sufficiente. Affinché si creasse il bisogno di diffusione delle notizie era necessario che si formasse un’opinione pubblica. Il giornale diventa cosí la voce dell’opinione e il suo promotore.
I lettori condizionano i giornali o sono i giornali a dominare i lettori? Lasciatemi dire, come persona esperta dei fatti, che questo dilemma è mal posto anche se ricorrente. Opinione pubblica e giornali sono due facce della stessa medaglia, l’una non si dà senza gli altri e viceversa.
La nascita del giornalismo coincide con l’affermarsi dei partiti nell’Inghilterra settecentesca e, in Francia e in Europa, con i volumi dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert. Con l’Illuminismo e il dibattito culturale e politico tra le diverse élite, perché quella era la struttura sociale dell’epoca.
Da allora i mutamenti sono stati enormi, l’opinione pubblica si conta ormai in milioni di persone, i giornali in decine di migliaia, la stampa scritta è stata affiancata e superata dalle stazioni radiofoniche e televisive e queste dalle reti informatiche. È aumentato il rapporto di interdipendenza tra lettori e fonti di informazione, ma si è creata anche una nuova interdipendenza tra giornalismo e pubblicità di merci e servizi.
Un mercato semplice è diventato estremamente complesso. Ha raggiunto le masse. Dà lavoro a una schiera importante di professionisti. Le capacità dei «media» di manipolare il pubblico sono molto aumentate. La difesa contro queste manipolazioni è diminuita. Tuttavia anche la sensibilità dei lettori, ascoltatori o almeno della loro parte piú responsabile, si è acuita.
Insomma la nuova «lotta di classe» è in pieno sviluppo, e i suoi esiti ancora incerti.
Gran parte della mia vita io l’ho dedicata al giornalismo. Cominciai sessantacinque anni fa e ancora ci sono dentro. Ho contribuito alla fondazione di due giornali, li ho diretti per alcuni anni e sono stato per quarant’anni comproprietario di tutti e due.
Il giornalismo è stato per me il mezzo per esprimere una parte dei miei pensieri. Sono tuttavia riuscito a coltivare pensieri autonomi dalla mia professione e dalle sue regole. Sono riuscito a non farmi stritolare dalla sua logica, che è molto pervasiva.
Il giornalismo non è un mestiere che consenta un tempo libero autonomo rispetto alla professione. Richiede una vocazione. Se quella vocazione non c’è, è inutile provarci.
Vocazione al giornalismo vuol dire voglia e capacità di entrare nella vita degli altri, per raccontarli cogliendoli in tutte le loro posture, quelle gradevoli e quelle inquietanti, innocue o criminose, normali o devianti.
Vocazione ad invadere la vita degli altri, a cominciare da quelli che esercitano un potere. Perciò il giornalismo è anche un contropotere e come tale detiene un intenso potere di controllo. Questa è la ragione che rende la libertà di stampa necessaria alla democrazia e tutelata dalle costituzioni democratiche, una patente di nobiltà che però non ne modifica l’essenza: invadere la vita altrui.
Come tutte le invasioni, anche questa dà una sorta di ebbrezza, un senso di potenza che andrebbe controllato e moderato. Non sempre ci si riesce, specie se il giornalista e il giornale riscuotono successo nel pubblico e suscitano correnti di opinione influenzando comportamenti, decisioni e giudizi.
Io l’ho provato quel senso di potenza e non rappresento un’eccezione ma piuttosto una regola. Ti appassioni all’ebbrezza del potere quando metti il Palazzo, il «Business» e anche la Cultura sotto controllo e, se del caso, sotto processo. E aspiri ad essere il piú bravo a farlo. Il piú aggressivo. Il piú irriducibile.
Poiché tra i giornali vige una concorrenza accanita, il giornalista si affeziona alla sua verità e alle sue fonti e nega l’affidabilità delle fonti dei concorrenti. La nega per ragioni di bandiera e non di merito. La verità raccontata dal giornale A è la sola credibile per i giornalisti di A, quella raccontata dal giornale B è assoluta per i suoi giornalisti. Bisognerebbe essere piú disponibili a confrontare le fonti anche a rischio di dover riconoscere un errore, ma non accade quasi mai, quando si è scelta una tesi si va fino in fondo.
Questo metodo presenta anche qualche pregio: consente ai lettori che leggono piú di un giornale di confrontare le diverse verità e orientarsi liberamente facendosene una propria. Ma questa è pura teoria. In realtà non avviene nulla di simile. I lettori, anche i piú maturi, aderiscono di volta in volta a questa o quella tesi senza interrogarsi troppo sulla propria personale coerenza, cosí come avviene in certi dibattiti o congressi quando la platea tributa vere e proprie ovazioni ad un oratore e, a distanza di pochi minuti, applaude con lo stesso vigore l’oratore successivo che sta sostenendo tesi del tutto opposte.
La retorica e l’eloquenza sono due grandi invenzioni della latinità. Se bene usate convincono qualsiasi pubblico, si tratti di parole scritte o, meglio ancora, di parole parlate.
Perciò il giornalismo è una professione assai diversa dalle altre, salvo forse l’avvocatura. Confina con la politica; confina anche con la letteratura. Si dice che i giornalisti siano dei politici falliti o dei romanzieri mancati e forse c’è del vero in questo malevolo giudizio. Diciamo una parte di vero.
Avendo praticato quella professione e conoscendola dal di dentro, credo che il modo giusto di definirla sia la parola «dilettante». Il giornalista deve tradurre i linguaggi specialistici dell’uomo politico, dell’economista, del burocrate, del tecnico, dello scienziato e anche il «parlato» dell’uomo comune in una lingua comprensibile a tutti, chiara dove il suo interlocutore è stato oscuro, decifrandone i tecnicismi e il gergo specialistico.
È naturale che il giornalista non possieda conoscenze approfondite. Sarebbe un Pico della Mirandola e non un impiegato addetto alle notizie. La sua è dunque una cultura dilettantesca, un’infarinatura approssimativa che gli impone qualche approfondimento secondo gli incontri e i temi che gli saranno affidati. E tuttavia è, a suo modo, un grande specialista: specialista di dilettantismo, specialista nel capire il gergo altrui e trasmetterlo al pubblico dopo averlo reso comprensibile. Specialista nell’invadere l’animo altrui, stanarlo, obbligarlo a scoprirsi fotografandolo cosí come gli apparirà: nudo, stordito, colto sul fatto.
Professione crudele, il giornalismo. Comporta un po’ di magia. Uno «show» per incantare il pubblico. Una voglia di competere e, naturalmente, di uscire vittorioso dalla gara.
Ho scelto il giornalismo come la migliore professione che potessi fare, la piú adatta al mio modo di essere.
Cominciai a diciotto anni sui giornaletti del Guf ma quella non fu nemmeno un’iniziazione. Non imparai nulla perché non c’erano maestri e non c’era nulla da imparare.
Il vero incontro avvenne con la fortuita conoscenza di Mario Pannunzio e dei suoi amici del «Mondo» cui seguirono a breve distanza il mio trasferimento a Milano (allora ero funzionario della Banca Nazionale del Lavoro) e l’inizio della mia collaborazione a quel settimanale che raccoglieva il meglio della cultura liberal-radicale, con il patrocinio di due personalità molto diverse tra loro eppure accomunate in tarda età dall’amore per la democrazia, testimoniato dalle loro biografie morali e politiche: Benedetto Croce e Gaetano Salvemini.
«Il Mondo» fu il luogo dove si realizzò l’incontro tra quei due grandi spiriti. Ne nacque un prodotto unico nel suo genere, reso possibile da un liberale di alto intelletto come Pannunzio e da un personaggio di straordinaria vitalità e curiosità come Ernesto Rossi. Un «tiro a quattro» eccezionale che esercitò notevole influenza sulla cultura politica italiana, valendosi del contributo d’un altro personaggio di eccellenza quale fu Ugo La Malfa e d’uno stuolo di collaboratori ampio e di giornalisti di collaudata professionalità. Una presenza liberal-socialista, in verità piú liberale che socialista, che si interpose tra le due chiese egemoni nell’Italia degli anni Cinquanta, la democristiana e la comunista, tenendo viva una terza posizione e contribuendo cosí a mantenere aperto un sistema che rischiava di chiudersi bloccando il ricambio e la selezione della classe dirigente.
Mi trovai nella fortunata condizione di essere tra i piú giovani di quella compagnia, insieme a Francesco Compagna, a Vittorio De Caprariis, ad Alberto Arbasino. E lí, in quella redazione che era insieme luogo di lavoro, salotto di incontri e dibattiti quotidiani e laboratorio di iniziative politiche, cominciò la mia iniziazione professionale.
A Milano arrivai nel marzo del ’50. Non ero mai stato in quella città e non conoscevo nessuno, ma portavo con me due lettere di presentazione che Pannunzio mi aveva dato per Mario Paggi, un avvocato antifascista che durante la Resistenza era stato uno dei dirigenti del Partito d’azione ed ora era tra i piú assidui collaboratori del «Mondo», e per Arrigo Benedetti, direttore dell’«Europeo» da lui fondato nel 1948, uno dei piú diffusi e innovativi rotocalchi del giornalismo di quegli anni.
Sia «Il Mondo» sia «L’Europeo» erano editi dalla Domus di Gianni Mazzocchi. Le formule erano diverse ma il gusto grafico e giornalistico analogo, Mario ed Arrigo erano tutti e due nati a Lucca, avevano la stessa età, la stessa passione professionale e politica, avevano lavorato insieme a «Omnibus» di Leo Longanesi e insieme fondato il settimanale «Oggi» negli ultimi anni del fascismo.
«L’Europeo» di Benedetti faceva insomma tutt’uno con «Il Mondo» di Pannunzio, del quale era una sorta di cassa di risonanza. Anch’esso di intonazione liberalsocialista ma, a differenza del suo confratello, piú socialista che liberale.
Pochi mesi dopo il mio arrivo a Milano, Benedetti mi offrí di redigere una rubrica di economia. Cominciai anche a collaborare a «24 Ore», un giornale economico fondato qualche anno prima da Piero Colombi, un giornalista di livello e con forte spirito di indipendenza. Intanto continuavo la collaborazione al «Mondo» con articoli prevalentemente economici, guidato da Ernesto Rossi cui Pannunzio aveva delegato di sovrintendere a quel settore.
Ebbi dunque la fortuna di incontrare ottimi maestri. Benedetti mi insegnò a scrivere con chiarezza, Rossi l’efficacia della polemica, Colombi come applicare la limpidezza della prosa ai problemi complessi dell’economia.
Tutte le domeniche nello studio di Paggi in via Brera si riuniva, dalle undici all’una, un gruppo di persone che occupavano ruoli importanti nella città: c’era Adolfo Tino, che sarebbe di lí a poco diventato presidente di Mediobanca e ne era allora capo dell’ufficio legale; lo scrittore Arrigo Cajumi, presidente dell’Italgas; Leo Valiani e Antonello Gerbi, dell’ufficio studi della Comit; Riccardo Bauer, noto antifascista e presidente dell’Umanitaria; Remigio Paone, impresario teatrale e cognato di Enrico Cuccia (avevano sposato due sorelle, figlie di Beneduce, che era stato il fondatore e primo presidente dell’Iri).
Veniva spesso a quelle riunioni anche Aldo Aniasi, capo partigiano e storico sindaco socialista di Milano. Veniva Franco Cingano, mio coetaneo, che faceva le sue prime esperienze nella banca di Raffaele Mattioli, della quale molti anni dopo sarebbe diventato presidente. Di tanto in tanto a quei nostri incontri domenicali faceva la sua comparsa Ferruccio Parri, di cui diventai molto amico nonostante la notevole differenza di età che c’era tra noi.
Insomma, uno spaccato della classe dirigente milanese, la sua parte che oggi si direbbe riformista, laica, liberale.
Queste mie frequentazioni mi dettero un certo prestigio nella banca dove lavoravo. Prestigio, ma anche guai. A causa di una serie di articoli polemici sulla gestione dell’Ente Risi e della Federconsorzi, fui licenziato dalla Banca del Lavoro, alla quale il potentissimo presidente della Federconsorzi, Paolo Bonomi, aveva posto un aut aut di quelli che non si possono eludere: o il mio licenziamento o gli ingenti depositi della Federconsorzi sarebbero stati ritirati.
Quel licenziamento fece un certo scalpore, «Il Mondo» ne diede notizia; mi procurò altre nuove amicizie che avrebbero avuto un peso sul mio futuro: con Guido Carli, con Bruno Visentini e con Raffaele Mattioli.
A quel punto la mia decisione di abbracciare la professione giornalistica divenne definitiva. Quel licenziamento fu la spinta determinante. Molti anni dopo il direttore generale della banca, Imbriani Longo, mi incontrò a casa di comuni amici e dopo aver rievocato le vicende della nostra agitata convivenza professionale mi disse: «Allora, licenziandoti, io feci la tua fortuna». «È vero, – gli risposi, – ma allora non lo sapevamo né tu né io».
Nell’ottobre del ’55, con Arrigo Benedetti, che l’anno prima aveva lasciato la direzione dell’«Europeo», e con l’aiuto finanziario di Adriano Olivetti, fondammo «L’Espresso». Venti anni dopo, nel gennaio del ’76, insieme a Carlo Caracciolo e alla Mondadori allora guidata da Giorgio Mondadori e da Mario Formenton, fondammo «la Repubblica», che ho diretto per venti anni. Sommando insieme queste due esperienze si arriva ad un arco di tempo di oltre mezzo secolo. Io ho lasciato la direzione di «Repubblica» nel 1996, ma per desiderio del mio successore Ezio Mauro e della redazione del giornale, quell’esperienza continua sulla stessa linea politica e culturale che fu fin dall’inizio la nostra e che, nella sua ispirazione, risale ancora piú indietro ricollegandosi con «Il Mondo» e con il gruppo di giornalisti che lavorò in quel settimanale.
Giornalisti, ma anche scrittori, artisti, uomini di cinema, intellettuali, economisti.
Si erano già visti in Italia e altrove molti casi di iniziative giornalistiche intraprese da professionisti e da intellettuali, ma quella del «Mondo» e dell’«Espresso» è arrivata fino a «Repubblica» con una caratteristica che si è verificata molto raramente: ha cioè realizzato un’impresa editoriale di inusitate dimensioni, che oggi conta numerosi quotidiani, varie reti radiofoniche, una rilevante presenza sui siti Internet, dando lavoro a migliaia di persone. Il gruppo «Espresso-Repubblica» è quotato in Borsa e ha una capitalizzazione di circa 1500 milioni di euro.
Tutti i giornali di dimensione nazionale contano scrittori e intellettuali tra i loro collaboratori. Ma ciò che distingue il gruppo «Espresso-Repubblica» sta nel fatto che fin dall’inizio giornalisti e intellettuali furono alla guida dell’azienda e delle sue fortune editoriali.
Il nostro gruppo ha avuto un notevole successo editoriale e ha profondamente cambiato lo stile del giornalismo in Italia e in Europa. Ma nello stesso tempo ha contribuito alla crescita civile di tre generazioni di italiani. Questa non è una mia opinione ma un dato di fatto che va molto al di là di una semplice avventura di mercato.
Quando prendemmo la decisione di fondare un giornale quotidiano e facemmo i nostri conti sulle risorse necessarie, ci avvedemmo che il capitale di cui disponevamo era largamente insufficiente. Secondo il piano industriale che nel frattempo avevamo messo a punto ci volevano cinque miliardi per sostenere il giornale fino al raggiungimento del punto di pareggio. La previsione era che quel punto sarebbe stato raggiunto in tre anni, con una diffusione di centocinquantamila copie e una raccolta pubblicitaria adeguata. Tre anni, una redazione di una novantina di giornalisti, un giornale di 32 pagine. Al terzo anno, pareggio o chiusura: non volevamo fare un giornale che non potesse sostenersi da solo sul mercato.
Dovevamo però ancora superare l’ostacolo decisivo: mancavano i soldi necessari. All’inizio del ’75 demmo inizio alla ricerca del capitale. Pensavamo che la borghesia «illuminata» avrebbe capito l’importanza del nostro progetto. E andammo a bussare a quella porta.
Questa storia di una borghesia illuminata è stata una delle illusioni che il gruppo del «Mondo» e dell’«Espresso» ha lungamente coltivato: una borghesia liberale, anzi «liberal», la leggenda del partito «Whig» dell’Inghilterra del primo Ottocento, la lega di Manchester sostenuta dall’industria tessile che si batteva contro il dazio sul grano. Insomma l’industria grande e piccola che prendesse nelle sue mani la ricostruzione dello Stato e si alleasse con la classe operaia per risolvere la questione sociale.
Fu un’illusione che resistette a molte sconfitte e che personalmente ancora vagheggiavo fino a metà degli anni Ottanta. A volte bisogna sognare, magari ad occhi aperti, per realizzare un obiettivo. E noi sognammo.
Dopo tre mesi e dopo avere bussato a molte porte chiedendo contributi che non superassero i cento milioni ciascuno e dunque conservassero all’«Espresso» la maggioranza relativa della società editrice, avevamo raccolto seicento milioni. Aggiungendo le nostre disponibilità si arrivava a un miliardo e mezzo.
Fu chiaro a quel punto che dovevamo cercare un socio del nostro stesso mondo editoriale che sottoscrivesse l’altra metà del capitale. Il solo per noi accettabile era Mondadori, una casa editrice al primo posto nel settore libra...