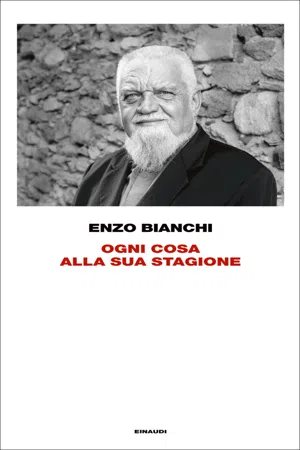![]()
I giorni della memoria
![]()
Pinèn
Ho perso mia madre quando ero ancora bambino e questo ha contribuito a che mio padre avesse un gran peso nella mia vita da quando sono nato fino al giorno in cui ruppe con me ogni relazione: me ne ero andato da casa per seguire una scelta di vita che non capiva. Per alcuni anni non mi rivolse nemmeno piú la parola e ripeteva sconsolato: «In ogni famiglia nasce un figlio stupido, e io ho avuto un figlio solo...» Mio padre si diceva non credente, canzonava la chiesa, scherzava parlando male dei preti e ancor piú delle donne devote che apostrofava con il nomignolo di «pepie», quand’ero adolescente mi invitava a farmi piú furbo e a non ascoltare quello che dicevano i preti. Non andava mai a messa, nonostante la mia matrigna cercasse di trascinarvelo almeno a Pasqua: ogni domenica se ne stava seduto sulla soglia di casa, nella piazza davanti alla chiesa, e tratteneva a ridere e conversare quelli che passavano di lí per andare a messa. Sicché il parroco – a volte con le buone, altre decisamente seccato – doveva uscire sul sagrato e gridargli: «Li lasci venire in chiesa!» Era un socialista, come tutta la sua famiglia, ma a volte si professava «comunista», soprattutto per fare un dispetto a chi non sopportava i comunisti. Eppure in lui c’erano alcune curiose contraddizioni: era infatti amico del parroco e andava volentieri a fargli i lavori da elettricista, senza mai farsi pagare; allora si fermava a parlare amichevolmente, salvo poi ricordargli: «Voi preti mangiate il pane a tradimento»...
Data la povertà in cui ci trovavamo in quegli anni di dopoguerra, Pinèn – il nome di mio padre era Giuseppe, ma per tutti era semplicemente Pinèn – per vivere si inventava ogni sorta di lavoro: di mestiere faceva lo stagnino e il lattoniere, ma si industriava anche come barbiere, vetraio, elettricista, venditore di bombole del gas... Di lui ricordo come una costante il suo «lavorare sempre», dal mattino alle sei, quando si alzava, fino a sera, all’ora di cena: solo una breve sosta per il pranzo di mezzodí e poi di nuovo per cascine a mettere o riparare grondaie, consegnare bombole, riparare vetri, oppure in casa a stagnare pentole di rame e aggiustare le «macchine» da verderame, quelle che i contadini si mettevano in spalla per irrorare l’acqua dallo straordinario colore turchese, l’acqua in cui si era sciolto il solfato di rame per la protezione della vite contro la peronospora. Lavoro ingrato, pagato pochi soldi, con alcuni «clienti» che si sdebitavano in natura con i prodotti della terra e altri che non pagavano mai. Cosí a casa mia non ci fu mai povertà di cibo, ma eravamo sempre senza soldi, anche perché la malattia di mia madre aggravava la situazione con le spese necessarie e le degenze in ospedale.
Mio padre lavorava in continuazione, ma per necessità; lavorava per vivere, ma non viveva per lavorare. Anche questo ho imparato da lui. Non andava al bar, non usciva alla sera per giocare a carte, preferiva restare in casa a parlare con chi veniva a trovarci, oppure d’estate stava seduto sulla soglia e magari, per far ridere e divertire un po’, suonava il mandolino. Quando parlava era molto sapiente e anche arguto, forse per questo i vicini venivano a discorrere con lui e facevano volentieri capannello. Era anche famoso per affibbiare soprannomi alla gente e lo faceva senza disprezzo né malizia, ma con senso dell’umorismo e capacità di cogliere al volo le caratteristiche delle persone: per questo sovente i nomignoli che lui dava restavano appiccicati addosso come un secondo nome di battesimo.
Pinèn amava la buona tavola ed era molto esigente con la sua seconda moglie, arrivando anche ad alzare la voce se il cibo non era come lo voleva. Mangiando beveva parecchio, soprattutto nei primi anni dopo la morte di mia madre: non l’ho mai visto ubriaco, ma a volte irato e collerico sí, soprattutto con me, per ragioni che non sempre capivo. Io cercavo di renderlo contento soprattutto impegnandomi a scuola: riuscii sempre a ottenere la borsa di studio per non essergli di peso con i miei studi, ma lo sentivo sempre distante.
Il periodo piú duro fu proprio quello successivo alla morte di mia madre: restammo io e mio padre soli... A otto anni dovetti imparare a far qualcosa da mangiare: a cuocere la pasta, a friggere le patate, a preparare la tavola... Alcuni vicini, con molta compassione, ogni tanto mi portavano del ragú, mentre mia nonna materna Maina veniva a piedi dal suo paese, restava un paio di giorni a casa nostra e preparava alcuni piatti buonissimi e poi se ne ritornava a Montabone. Ricordo quegli anni con grande tristezza: ogni sera, quando tornavo a casa verso le dieci dopo essere stato a studiare dalle persone che si erano fatte carico della mia educazione, trovavo mio padre addormentato, con la testa appoggiata sul tavolo accanto al bicchiere ormai vuoto e al bottiglione di vino sfuso, mentre la radio continuava a gracchiare... Non lo svegliavo neanche e me ne andavo a dormire con in mente le parole che mia madre gli aveva detto poco prima di morire: «Quando non ci sarò piú, Pinèn, cerca di risposarti, perché un uomo da solo alla tua età finisce per lasciarsi andare e diventare una lingèra». Andavo a letto con questo nodo in gola e nel petto: ci saremmo rivisti quasi di sfuggita all’indomani, di mattina presto, perché lui partiva per il lavoro e io alle sei ero già in chiesa a servire la messa, abitudine che dall’età di sei anni ho conservato fino a quando ho lasciato il paese per andare a Torino, all’università.
Sempre in quegli anni cupi, tra la morte di mia madre e le seconde nozze di mio padre, c’era un altro motivo di angoscia: ogni tanto lo sentivo ripetere che voleva andarsene in Australia, raggiungere dei cugini là emigrati, per tentare la fortuna perché qui la vita era troppo grama. Vissi quel periodo con la paura di essere abbandonato, di svegliarmi un mattino e non ritrovarlo piú a casa... È un’ansia che mi ha segnato a tal punto da rimanermi impressa ancora alla mia età, nonostante non ve ne sia piú alcuna ragione logica.
Non ci siamo mai detti molto, ma io aspettavo che fosse lui a iniziare a parlare, cercavo di capire oltre le sue parole, mi sforzavo di interpretare il modo in cui si rivolgeva a me e poi restavo a farmi domande, senza mai chiedergli tanti perché... Allora erano cosí i rapporti tra padre e figlio: tante o poche parole del padre, nessuna da parte del figlio. Di queste sue rare parole, alcune sono restate indelebili nella mia mente, forse perché gliele sentivo ripetere sovente e con convinzione: «Sappi che se diventi ladro, io ti ammazzo!», «Non dire mai quello che non pensi!», «Tutti i giorni avrai l’occasione di non essere un vigliacco!»
Quando decisi di iniziare la vita monastica a Bose, mio padre non capí né tanto meno approvò: gli sembrava semplicemente una follia. Dopo i brillanti studi universitari e il promettente avvio di una carriera politica, andavo a finire in una frazione abbandonata del Biellese, senza elettricità né riscaldamento, dove l’unica acqua corrente era quella che scendeva dai tetti disastrati e privi di grondaie... Per qualche anno, quando gli telefonavo, riagganciava: si comportava come se avesse deciso di non riconoscermi piú come figlio. Poi un giorno, senza avvisarmi, venne a vedere dove stavo. Mi incontrò nella mia confusione e imbarazzo: non sapevo cosa dirgli. Restò tutta la giornata a Bose e vide la piccola comunità che allora eravamo e la vita che facevamo: una decina di giovani che inseguivano un sogno restando con i piedi per terra. Prima di partire mi disse semplicemente: «Forse la cosa piú giusta l’hai fatta tu qui!»
Sí, perché per lui le cose si distinguevano essenzialmente tra giuste e ingiuste: sulla giustizia si decideva la qualità umana di una persona, si giudicavano gli eventi, i comportamenti... Quando una lingèra – quei poveri e dignitosi girovaghi che un tempo animavano i nostri paesi – bussava alla porta di casa nostra, mio padre lo faceva entrare e sedere a tavola con noi, dicendo: «Mai dare da mangiare a un viandante lasciandolo fuori dalla porta: sarebbe ingiusto!» Se parlava di una persona e doveva esprimere un giudizio, era categorico: «Quello è un giusto», oppure «Questo qui non sa cosa sia la giustizia!» Forse era il motivo del suo essere socialista: nel suo immaginario, il «socialismo di Nenni – cosí si esprimeva – porta un po’ di giustizia alla società, altrimenti regnano i prepotenti, i nobili, i ricchi... e i preti!»
Tornò ancora a trovarmi a Bose, ormai muto ed emiplegico a seguito di un ictus: restò alcuni giorni, apprezzò il grande lavoro fatto per trasformare la piccola borgata, trovò simpatici i fratelli e le sorelle che vedeva disposti a lavorare con serietà ma anche capaci di dialogo cordiale con un «burbero» come lui... Qualche anno dopo sopraggiunse anche un cancro: cosí l’ultima stagione della sua vita fu segnata da grande tribolazione, soprattutto perché al dolore fisico si aggiungeva l’impossibilità a parlare, terribilmente frustrante per uno come lui, abituato ad avere sempre una parola sagace per creare comunione. Cercava di comunicare scrivendo qualche frase su un block-notes, ma la voglia e la soddisfazione della parola giusta al momento giusto se ne erano andate. Se ne andò anche lui, a poco piú di settant’anni, ma qualche giorno prima, vedendomi al suo capezzale, ritrovò uno sprazzo della sua verve per scrivere con mano ormai incerta: «Ma che figlio ho fatto! Chissà da dove esce?!»
![]()
Grazie a voi
Di carattere e formazione sono un uomo piuttosto discreto, che ama parlare poco delle vicende personali e piú intime: per questo non ho mai raccontato la mia storia, nonostante molti inviti e alcune proposte editoriali. Da un lato sento mia la riservatezza piemontese, propria della mia terra, d’altro canto sono consapevole di non essere uno scrittore: a scuola, il voto piú frequente per i miei temi d’italiano era tra il sei e il sette, con annotazioni di questo tipo: «Profonde le idee, ma brutta la forma». Sento tuttavia di avere dei debiti di riconoscenza nella mia vita umana e spirituale, e questo tipo di debiti si paga in due modi: innanzitutto con l’affetto fedele e poi con il riconoscimento pubblico, soprattutto quando sono ancora in vita persone che hanno conosciuto i miei «creditori». Sí, mi sento debitore nel senso che il molto che oggi vivo, lo vivo grazie ad alcune persone che mi sono state vicine. In una vicenda, la mia, per certi versi «strana»...
Vengo da una famiglia povera: l’ingegnarsi di mio padre nel fare ogni sorta di mestiere garantiva il cibo quotidiano ma poco piú. Nel suo anticlericalismo cordiale amava ripetere, con rispetto e mai con cinismo: «A ciascuno il suo mestiere. Quello che devi fare, fallo bene. Poco importa quello che uno fa: l’essenziale è che, se ne è convinto, lo faccia bene. Questo è il suo dovere!» Mia madre era «malata di cuore» e tutti sapevano che se ne sarebbe andata presto: la mia nascita aveva aggravato la sua salute, ma lei non ne aveva voluto sapere di interrompere la gravidanza: mi aveva voluto e tenuto, anche se in famiglia c’erano pareri contrari. Era una donna di grande fede, una fede mai scossa dalle prove patite: la vita dura, le frequenti degenze in ospedale, le cure che non servivano a niente ma che gravavano sul misero bilancio famigliare... Di lei ricordo che mi portava in chiesa – abitavamo proprio di fronte – nella penombra del pomeriggio, guardava che non ci fosse nessuno, soprattutto che non sopraggiungesse il parroco e poi entrava nel presbiterio – gesto proibito a una donna – saliva i gradini dell’altare e con le sue braccia magre mi sollevava fino al tabernacolo e mi diceva: «Bussa!» Io bussavo a quella porticina, ripetendo le parole che lei mi sussurrava come preghiera... È cosí che ho iniziato a imparare a pregare, fin da quando avevo due, tre anni; sovente mi dico che in piú di sessant’anni non ho imparato a pregare meglio, anzi, forse pregavo meglio allora, con parole sussurrate da chi aveva piú fede e speranza di me.
Dell’infanzia non ho molti altri ricordi cosí forti e belli, semmai ne conservo molti dolorosi: le crisi asmatiche notturne di mia madre, la sua debolezza e il suo star male, le sue labbra che avevo imparato a «leggere», perché dal colore piú o meno violaceo capivo come stava. La ricordo come una donna in attesa accanto al fuoco alla sera, mentre preparava cena, stando piú seduta che in piedi, aspettando che mio padre tornasse dal lavoro... Se ne andò una notte, ma dopo avermi chiamato la sera prima con accanto anche mio padre e Cocco, un’altra donna cui sono debitore: chiese solo a mio padre di prometterle che mi avrebbe fatto studiare – cosa rara a quei tempi al mio paese e in quella condizione di povertà – e di non impedire la mia educazione cristiana.
Cocco, appunto, ed Etta sono state con ogni probabilità le persone per me piú significative e decisive. I loro soprannomi li avevo «inventati» io e si erano poi imposti fino a essere usati da tutti a Castervè. Cocco – Norma era il nome datole da suo padre, un patito dell’opera – era la «postina» (l’ufficiale di posta, si direbbe oggi) e aveva nel suo ufficio un oggetto che da piccolo mi affascinava tantissimo: un barattolo di «coccoina», quella colla in pasta che aveva un gusto di mandorle amare; cosí, quando chiedevo di essere portato da lei per giocare con carta e colla, dicevo solo «Cocco» e quel nomignolo le restò incollato per sempre. Etta si chiamava invece Elvira ed era la maestra elementare che tutti chiamavano con venerazione «la Maestra» per antonomasia: da lí la mia storpiatura infantile in «Etta».
Cocco ed Etta, due donne giunte al mio paese da luoghi diversi del Monferrato negli anni Venti, per svolgere le rispettive professioni. Si erano conosciute condividendo per i primi tempi l’alloggio in pensione, poi avevano deciso di vivere insieme: si davano correttamente del voi perché non ci fosse troppa confidenza, ma vivevano nello stesso alloggio, continuando però a mangiare a mezzogiorno da quella vicina che aveva dato loro pensione all’inizio, per non privarla di un minimo reddito. Erano entrambe molto credenti, ma in modo diversissimo l’una dall’altra: Cocco aveva una fede semplice e rocciosa; Etta invece, che era anche una raffinata intellettuale, era sí cattolica, ma con uno spirito critico, un modo di pensare autonomo e personale. Cocco andava a messa ogni giorno al mattino presto, Etta solo alla domenica, ma pregavano insieme ogni sera, leggendo qualche pagina del Vangelo e alcune preghiere da un libro devoto.
Già durante la malattia di mia madre si interessavano di me, figlio unico in una famiglia povera, ma quando a otto anni rimasi orfano si presero cura di me in modo eccezionale: ogni sera cenavo da loro e poi stavamo insieme finché non rientravo a casa a dormire. Etta mi insegnò il latino, mi dava dei libri da leggere, qualche volta mi portava a «vedere il mare» a Nervi, a Camogli e a Varazze, altre volte mi accompagnava a Nizza sul landò, la carrozza tirata da due cavalli! Cocco ed Etta furono per me piú di una madre: grazie al loro impegno e ai loro risparmi riuscii a proseguire gli studi, ad andare «a studiare a Nizza», e soprattutto il loro affetto premuroso mi aiutò a crescere in modo davvero privilegiato.
Quando ci penso e rifletto, mi sembra impossibile che, non appena fui in grado di gustare le letture, si prodigassero nel procurarmene: a tredici anni mi regalarono la Bibbia, a quindici le Regole di san Basilio – letture decisive per tutta la mia vita, fino a oggi! – poi mi abbonarono a «Il gallo», alla rivista fiorentina «Testimonianze» e a «Politica» di Pistelli e mi consentirono di avere una piccola biblioteca personale con i romanzi di Graham Greene, Bernanos, Mauriac, Bruce Marshall, Julien Green, Cesbron, Tolstoj, Doestoevskij... Ma soprattutto fu l’accompagnamento quotidiano che plasmò la mia esistenza: ogni giorno con consigli, rimproveri, a volte anche con urlate, specie di Cocco, mi trasmettevano il senso del dovere e della responsabilità, la capacità di dialogo, la curiosità per la scoperta di vie nuove e di persone diverse. Mio padre capiva l’importanza di alcune cose, ma non poteva fare molto, cosí anche se mi ripeteva: Fa’ la fam, ma cata i l¢`ber e gira el mund, in realtà, se non fosse stato per l’aiuto di Cocco ed Etta i libri non avrei potuto comperarli e il mondo non avrei iniziato a girarlo...
Di Etta ricorderò sempre che un anno mi portò per u...