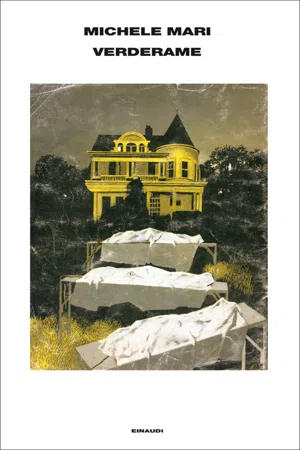![]()
Verderame
![]()
Dimidiata da un colpo preciso di vanga, la lumaca si contorceva ancora un attimo: poi stava. Tutto il vischioso lucore le rimaneva dietro, perché la scissione presentava una superficie asciutta e compatta che il colore viola-marrone assimilava al taglio di una bresaola in miniatura. Dunque della sua bavosa vergogna l’animale si doveva liberare in continuazione per rimanere puro nell’intimo suo, e a questa nobile pena era premio la metamorfosi dell’immonda deiezione in splendida scaglia iridescente.
Corrugato da solchi paralleli e regolari, il tegumento esterno era di un rossiccio che teneva del boleto: ciò che distingueva il nostro mollusco come lumaca rossa ovvero lumaca francese: piú tozza e piú chiara delle nostrali, con una sagoma piú vicina alla balena che al serpente, e corna piú corte e meno facili alla protrusione.
– Puàh! – fece il villano sputando sopra il cadaverino ma mancandolo di qualche centimetro. Poi ritrasse la vanga e ne passò la lama fra due dita, come a nettarla di una poltiglia che esisteva solo nella sua testa. – Lümàgh frances! – e nuovamente esplose un bolo di saliva che come il precedente scaracchio nessuna benedizione avrebbe trasformato in madreperla. – Lümàgh schifús vacaboia! – e finalmente si allontanava.
Io pure mi allontanavo, per tornare dopo qualche ora ad assistere al lavoro delle formiche, che coperti completamente i due monconi della lumaca ne suggevano la linfa riducendo la spoglia a fascio di fibre mummificate. Mi piaceva pensare a quegli esserini come all’equipaggio del Pequod impegnato nella lavorazione di un cetaceo, e da questo pensiero prendeva forma l’irresistibile immagine di una tremenda lumaca bianca piena di cicatrici, la lumaca della vendetta…
Peccato che il mio contadino non avesse nulla del capitano Ahab. Anzi lo caratterizzava qualcosa d’informe, cosí nella corpulenza perennemente insaccata nella stessa tuta bluastra come nel volto, complicato da una cicatrice che collegava il ciglio dell’occhio sinistro al ciglio del labbro, da una vasta voglia color vinaccia, e da tutti i porri il cui aggetto era bilanciato dalla cavità delle ulcere vaiolose. Segnatamente sconciato era il naso, bitorzoluto e spugnoso come quello di un cirrotico, e percorso da un reticolo di venuzze scure. Sgradevolmente lacrimosi aveva gli occhi, con le palpebre quasi incollate dalla resina come per una congiuntivite cronica: fenomeno che se non altro gli conferiva un’aria pensosa e concentrata, come di chi affisi il pensiero a metafisiche lontananze.
Dentro di me lo chiamavo l’uomo del verderame, perché di tutte le sue mansioni, che prevedevano la cura dell’orto e degli alberi, la manutenzione spicciola della casa, il taglio del prato, l’allevamento di galline e conigli, la preparazione e l’irrorazione del verderame era per un bambino la piú fascinosa. Lo vedevo spezzare stecche di verderame solido dentro un bidone di metallo, e ognuna di quelle schegge aveva la sinistra seduzione dei gessi colorati che furono fatali a Mimí, la «bimba sciocca» della canzoncina. Punizioni tremende, avessi solo sfiorato una di quelle schegge: pure, siccome egli le trattava a mani nude ritraendone un turchese che non solo gli tingeva la pelle ma gli si installava permanentemente sotto le unghie, i casi erano due: o il verderame non era cosí pericoloso, o davvero egli era un mostro. E a questa seconda ipotesi sempre fiducioso mi attenni.
Perché mi voleva bene, quell’essere, ed essere amato da un mostro è la migliore delle protezioni dall’orribile mondo. Certo si macchiava di atti nefandi come l’uccisione delle lumache o lo scuoiamento dei conigli, la cui cruenta pelliccia appendeva ai rami degli alberi senza alcun riguardo alla mia tenerezza: ma ero abbastanza intelligente da capire che a un mostro qualcosa si deve pur concedere. Mio nonno cercava di confondermi attribuendo l’eccidio dei molluschi alla necessità di preservar le lattughe, e il sacrificio dei conigli alla bontà degli umidi imbanditi dalla nonna: ma io sapevo che erano pretesti, che il mostro uccideva con piacere e con pompa e che questo solo contava, la sua barbara soddisfazione di carnefice; e del resto a qualificarlo per mostro bastavano i suoi disgustosi scaracchi, ai quali anche la speciosa dialettica del nonno non poteva trovare giustificazione.
Si sapeva poi quand’era nato, e dove? Cos’aveva fatto prima di lavorare per noi? Se aveva parenti? Qualcuno era mai entrato in casa sua, se casa era l’incognito spazio chiuso da un portoncino di legno grigiastro? Qualcuno l’aveva mai visto in un abito che non fosse quella tuta, identica nei decenni? Qualcuno poteva dire di averlo visto fare la spesa,o ricevere derrate a domicilio? E di cosa si nutriva? Beveva molto, evidentemente, ma c’era in tutto il paese una sola persona che potesse testimoniare dell’ingresso di una bottiglia attraverso quel portoncino? E finalmente, io avevo bisogno di un mostro, e questo decideva. D’altronde, non maneggiava impunemente il tremendo veleno?
Sciolto nell’acqua, il verderame formava una pasta densa, simile a quella che nelle fiere di una volta i caramellai torcevano come lottassero contro un pitone: cosí doveva rimanere alcuni giorni per «respirare», verbo che diceva fin troppo della vita di quella cosa. A tal fine, il bidone restava pericolosamente aperto: io entravo piú volte nella legnaia per controllare quella misteriosa attività respiratoria, e contemplando il meraviglioso turchese cercavo di non sporgermici sopra per paura delle esalazioni, una paura che mi confermavano gli insettini morti che sempre piú numerosi maculavano il colore.
Venuto il momento l’uomo versava la pasta dentro una grande vasca di graniglia, la cui presenza faceva sí che la legnaia fosse talvolta chiamata lavanderia, con una transitività che se sconcertava gli estranei era per me il segno della natura metamorfica e magica di quel luogo. Aggiunta molta acqua nella vasca egli «rügava», cioè mescolava con un bastone finché il liquido non fosse omogeneo. – Va’ Michelín, l’è cumpagn rügà la pulenta – mi faceva: poi sputava dentro la vasca e procedeva alla mescidazione come una macchina. Era solo un’abitudine, o quello sputo conteneva gli enzimi necessari alla buona riuscita dell’operazione, come uno di quegli ingredienti segreti su cui ogni brava cuoca costruisce la propria fama? Non seppi mai. Ottenuto il risultato prefisso, ecco che le sue mosse si facevano rapidissime: bisognava riempire il sifone prima che nella vasca la miscela «l’andass insemma», cioè, come con identico errore si dice della maionese, si dividesse. Cosí, inferto un ultimo e piú vigoroso giro di bastone, l’artefice prendeva l’enorme sifone di rame e lo immergeva finché fosse pieno; dopodiché lo chiudeva assicurandone il coperchio con due leve; dopodiché lo asciugava e lucidava con due diversi panni perché il verderame, mi aveva spiegato, non rovinasse il lucido del rame; dopodiché, sustoltolo alquanto, lo agitava come lo shaker mostruoso di un piú mostruoso barman; dopodiché vi applicava due larghe cinghie di cuoio a mo’ di spallacci, e come uno zaino della prima guerra effettivamente se l’incollava sul groppone: cosí carico faceva due o tre saltelli ad assestarselo meglio, quindi rimosso con destrezza un opercolo situato sul coperchio vi avvitava la ghiera di un tubo di gomma terminante in una punta metallica, anch’essa di rame, identica per proporzioni alle siringhe dei pasticceri, non fosse per una sottostante impugnatura ad anello che ricordava quella di un Winchester. Io a questo punto mi ero già allontanato di qualche metro perché sapevo cosa stava per accadere: puntato il tubo-siringa verso il nulla, l’officiante tirava a sé l’anello provocando lo spruzzo del verderame, prima restio e in forma di goccioline troppo grosse, poi finalmente nebulizzato e gagliardo. Irriferibili bestemmie uscivano dalla bocca dell’orco finché lo spruzzo non fosse di suo gradimento: al che, con tutto quel rame sulla schiena che mi ricordava i palombari del Nautilus, si girava verso di me e simulava irrorarmi facendo – Psssssss… – con la bocca, ma l’attimo dopo si era già dimenticato di me per essere tutto della sua mansione.
Due ore dopo l’intera vigna era costellata di macchioline turchesi, cosí fitte e concentrate da tingere talvolta un’intera foglia o mezzo grappolo. – E anca stavolta l’emm daa – bofonchiava il mio uomo, che rientrava nella legnaia-lavanderia per sciacquare il proprio strumento e svuotare la vasca: la quale tratteneva sulla sua superficie una gromma turchese che mi sembrava un delitto rimuovere, e che pure era regolarmente eliminata con una spatola metallica ed altra acqua.
Il verderame! Per anni fui convinto che quel nome meraviglioso fosse la somma meccanica del rame del sifone e del verde della vigna: invece lo stesso rame ci entrava per il colore che assume quando è ossidato o, come avrei scoperto da grande, quando è in forma di acetato.
Guardando la vigna picchiettata di verderame un giorno fui ghermito da una domanda: com’era possibile che la tuta dell’uomo, sulla quale io stesso avevo appena visto cadere qualche gocciolina turchese dalle foglie, non fosse diventata con il tempo tutta una composizione di macchie, raggere, galassie di quello stesso colore? Terra e sangue di coniglio sí, ruggine, grasso di motore anche, calce, stucco, ma verderame no. E certo, il verderame si dà due volte all’anno, mentre con l’orto, le bestie e la casa c’era da fare ogni giorno: però… però se non altro dovevano esserci piú tute, cosa che il mio pensiero non riusciva ad accettare perché in relazione ad un essere come quello implicava una frivolezza imbarazzante: piú tute, tutte però uguali come le scarpe di quei lord inglesi che se ne fanno fare dodici paia alla volta… E chi lavava via il verderame, lui stesso o qualche donnina del paese?
La risposta, per la crudeltà del destino, arrivò poco tempo dopo, come se i dolorosi fatti che vi erano congiunti fossero stati innescati dal mio stesso dubbio.
Si era all’inizio di agosto, quando gli acini d’uva in procinto di maturare chiedevano la seconda passata di verderame. Come al solito i nonni stavano chiusi in qualche punto della casa. Si apre il cancello e lo vedo: dovrebbe tagliare per il prato in direzione della legnaia, invece fa un giro piú lungo costeggiando il muro dietro gli abeti: ma quando riesce allo spiazzo davanti al fienile non può piú nascondersi, nascondere, dico, la straordinaria novità della sua tuta beige-kaki, di quel punto cromatico che è piú precisamente il noisette, e che da nonne e zie non ho mai sentito designare altro che per «un bel noasetino». Cosí vestito sembra un soldato inglese, con il sifone sarà un perfetto sminatore. Si accorge della mia presenza, però, e si volta.
– Michelín?
– Sono io.
– Michelín, la va minga.
– Perché?
– Mi adess voo a fà ’l verderam, giüsta?
– Sí.
– Poeu voo a dàghel a l’üga, giüsta?
– Giusto.
– Giusto ’n cass, vacaboia!
– Perché?
– Se pò dà ’l verderam cunsciaa inscí? Culúr de la merda?
– Veramente a me sembra un bel noasetino…
– Noasetin sti ciapp! Mi dagh el verderam ghel doo, ma poeu? Quand rivi a cà?
E mi spiega: da due giorni sta cercando disperatamente le sue tute blu ma non ricorda dove le ha messe. Eppure la sua casa è piccola, anche volendo non ci si potrebbe nascondere nulla… Dunque non sa che pensare… Anzi lo sa fin troppo e ne è terrorizzato, perché si tratta di qualcosa che prima o poi ha colpito tutti i suoi antenati come una maledizione.
– Michelín, sunt adree a perd la memoria.
Unita a una lagrima che gli sgorga da un occhio semichiuso, questa frase mi lascia basito. Egli del resto non mi dà tempo e si sottrae alla mia vista entrando in legnaia. Per la prima volta non lo seguo e lascio che prepari il verderame da solo.
![]()
Antenati… Dunque quell’uomo non era pura natura naturata, inconsapevole goccia nell’oceano della materia vivente: ma sapeva una storia entro cui aveva un posto, la sua visione del mondo non si fermava all’immediata esperienza ma si slontanava in profondità e in prospettiva… Per un verso quest’idea mi contrariava, perché un mostro con l’albero genealogico era una cosa ridicola, per un altro verso mi seduceva, perché mi dava modo di indugiare sul concetto di tara ereditaria, concetto a me carissimo perché all’intersezione delle idee di tabe, di degenerazione e di maledizione. Ogni figlio piú mostruoso del padre, ma piú mostruoso di tutti il capostipite perché capace di infettare tutte le generazioni a venire… Una vicenda biblica e gotica insieme, darwiniana e lombrosiana: potevo ben dirlo anche nella mia giovane età, visto che i romanzi gotici erano stati il mio primo pane, la Bibbia l’avevo letta e cosí L’origine delle specie, e quanto a Lombroso mio padre me ne aveva sufficientemente edotto una volta che trovai il coraggio di chiedergli perché mai, ogni volta che incontrava qualcuno da lui ritenuto un deficiente (cioè il 99% dell’umanità), si allontanasse bofonchiando quel nome, che io interpretavo come «l’ombroso». Anche Uomini e topi avevo letto, subito prestando a Lennie il sembiante del mio contadino, e si può dire che questo completasse il quadro.
Dunque la tara era di natura amnestica, e la sua scoperta,o quantomeno la sua confessione, era legata alle tute blu che non si trovavano. Chissà quante altre avvisaglie c’erano state, prima che si decidesse al gran passo: un gran passo, sí, perché era evidente che confidare quel segreto a un ragazzino equivaleva per l’uomo membruto a una richiesta di soccorso; di piú, a mettersi nelle sue mani. Mi dissi che per rivolgersi a me doveva essere davvero solo, ma mi lusingavo all’idea che in me avesse intuito lo spirito piú fraterno e congeniale di tutto il paese. Non ero forse un cultore di mostri, disposto con ogni mia fibra a farmeli amici, a capirli, ad amarli?
Il giorno successivo a quella conversazione ricomparve in tuta blu: dunque l’amnesia era stata di breve durata. Gli corsi incontro per felicitarmi ma ancor prima di raggiungerlo capii quanto fossi in errore. Era pallido come non l’avevo mai visto, e su quel pallore il viola della voglia e l’intrico delle vene spiccavano con grafica impietà. E soprattutto non aveva sputato appena varcato il cancello, cosa che da anni mi obbligava a guadagnare l’uscita di sguincio pur di evitare il tratto d’erba contaminato.
– Michelín! – mi disse con la voce di uno che sta per piangere.
– Sí?
– Michelín, mi, com’è che me ciami?
Non volevo credere che la tara galoppasse a quella velocità, per cui tacqui.
– El mè nomm sacrabissa, come diaul me ciami, mi?
– Felice.
– Felis… mi?
– Felice, sí.
– Varda un po’, credevi de ciamamm Danilo…
– E perché proprio Danilo?
– Parchè gh’è i manifest par tücc i cantún, Danilo Goretti e la sua orchestra, stasira a Bress de Béder e dumàn a Germignaga.
Quella passività quasi camaleontica mi diede immediatamente un’idea. Si doveva trovare qualcosa – qualcosa di oggettivo e concreto – che al bisogno gli ricordasse la parola o l’idea dimenticata. Felice, felicità… ma felicità era astratto (sempre che poi esista), ci voleva qualcosa di piú evidente e immediato, qualcosa che provocasse un’associazione automatica anche attraverso il...