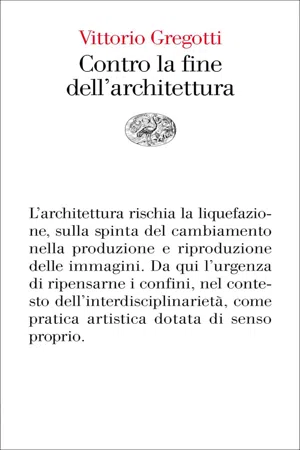![]()
I.
Intorno alla teoria del progetto
Noi architetti usiamo probabilmente la parola «teoria» in modo nello stesso tempo abusivo e indispensabile. Abusivo perché il suo significato è assai distante dall’uso che ne fanno scienza e filosofia in quanto essa non è per noi né costruzione in sé autonoma, né ipotesi di spiegazione progressiva del mondo, ma è al contempo fondamento, scelta e strumento dell’agire concreto non distinguibile dal suo esito. In sostanza un modo di essere del progetto. Mettere in scena il pensiero sotto forma della forma sembra essere il compito dell’architettura anche quando si parla di teoria.
Si potrebbe dire che, in qualche modo, le cose stesse dell’architettura sono in primo piano la sua teoria: per l’architettura la teoria non è in alcun modo opposta alla pratica, né separabile da essa: si scrive di regole e non di modelli, per usare la celebre distinzione di Françoise Choay.
Questo scritto si presenta quindi sotto una forma assai ibrida: in parte con pretese teoretiche, in parte quale risultato delle riflessioni intorno alla mia quotidiana esperienza di architetto, in parte quale «pamphlet» contro una condizione di degrado che mi pare di leggere proprio nelle architetture di piú forte successo mediatico dei nostri anni.
page_no="6" Scrivo di teoria anche perché si tratta, piú che di una libera scelta, di una dura necessità dettata dall’incertezza intorno ai fondamenti del progetto dei nostri anni, fondamenti che non sono certo un ostacolo alla libertà di espressione ma sono, io credo, condizione indispensabile per coltivarla. Né peraltro si deve confondere teoria e metafisica dei principî: le teorie del progetto, forse anche quelle dei progetti di ricerca scientifica ma certo quelle che riguardano l’arte, sono sempre ipotesi intenzionalizzate a partire da una verità limitata e specifica, metafora di una totalità fondata su un’etica della convinzione e della necessità.
Da piú parti, inoltre, è stata ricordata la difficoltà di trovare un piano adeguato ai nostri specifici problemi di architetti sul quale collocare la questione della teoria, un piano tanto integrato al fare quanto lo era un tempo quello del trattato di architettura. Nei nostri anni non vi siamo forse riusciti e spesso la nostra riflessione teorica è una sottospecie di quella filosofica o una semplificazione di quella storica o epistemologica: talvolta essa viene adottata come giustificazione a posteriori del lavoro architettonico, talaltra come interferenza metaforica tra linguaggi diversi che invece, proprio per poter comunicare, devono mantenere aperte ma chiare le loro identità.
Ma non per questo il problema della teoria dell’architettura e della sua continua costruzione non esiste. «Nella complicata geografia delle molli posizioni di questi anni è facile abbandonarsi sia al fatalismo della frammentazione, come ritratto dell’infinita apertura interpretativa del disordine delle nostre coscienze, o reagire ad esse con un ordine del tutto fantasmatico». Cosí scrivevo in un mio testo di vent’anni or sono e cosí penso anche oggi. Tuttavia non voglio nascondermi anche i pericoli di questo tipo di sguardo teoretico sull’architettura.
I processi di deduzione diretta in forme architettoniche (ma non solo), dell’enunciazione di principî esterni alla pratica artistica specifica sono l’aspetto piú pericoloso della riflessione teorica sulla nostra disciplina: quando cioè la teoria, anziché diventare fondamento storico critico del fare, diventa ideologia da cui il fare deve essere dedotto. Tutto questo passa in generale attraverso processi di semplificazione arbitraria, di determinismo in cui viene messa da parte la funzione creativa delle contraddizioni di ogni presente.
È evidente che ogni tempo storico produce condizioni di potere dominanti con cui le pratiche artistiche hanno a che fare, ma altrettanto evidente è che le opere dell’arte devono essere una presa di coscienza di tali condizioni. Quando qualcuno scrive «di ruolo dell’arte di rappresentare le priorità politiche ed economiche di una società» opera quindi una doppia semplificazione: da un lato elimina le contraddizioni, politiche oltre che ideali, che ogni struttura sociale produce, dall’altro mette tra parentesi proprio quella quota di verità altra che le forme dell’architettura producono e rendono visibili (anche se sovente sembra che i nostri artisti contemporanei non vogliano piú far vedere ma solo essere visti), e che mettono in campo come cosa concreta, persino al di là del ruolo critico che esse possono assumere. Anche se tale ruolo critico è, in modo contraddittorio, materiale fondante la libertà stessa dell’autore.
Naturalmente non si può, scrivendo di teoria dell’architettura come fondamento del fare, non tenere conto delle profonde mutazioni delle pratiche dell’arte e del loro ruolo nel mondo dei nostri anni, della difficoltà di definirne caratteri e ruoli nello stato di transizione in cui esse si trovano, specie a partire dall’ultimo trentennio del XX secolo, cioè dalla progressiva ricusazione, senza sostituzione, degli ideali di rifondazione dell’arte e del suo ruolo critico nella società promossa dalle avanguardie dell’inizio di quello stesso secolo. Il loro attuale stato, sia pure con le dovute eccezioni, qualcuno lo ha definito «gassoso», altri di «liquefazione» e insieme di superproduzione sopra sé stesse.
Si può dire infatti che la produzione estetica, che si è estesa sopra ogni atto, ha superato la capacità di rappresentazione di significati distinti, e cosí le cose si formano per differenza forzosa esterna. Riprendere la nozione francofortese di «industria culturale», in quanto pura espansione dell’esperienza estetica in funzione del consumo non sembra sufficiente quando, al di là degli enormi vantaggi offerti dallo sviluppo delle tecnoscienze e delle comunicazioni immateriali, l’ideologia del potere da esse stesse prodotta non ci mette piú in rapporto con l’esperienza degli eventi e con i loro processi di produzione e di uso, ma solo con la loro immagine. Come l’informazione, la bellezza è ovunque, i «ready made» dappertutto e l’arte assente; persino i musei appartengono alla categoria dei «mass media» e l’estetica dei prodotti è diventata cemento sociale. Separare mercato culturale e arte è divenuto impossibile: il primo si identifica con la seconda. Il nuovo diventa novità e abbandona ogni pretesa fondativa di costituzione di differenze. Tutto è sostanzialmente fermo pur nell’incessante turbinio delle proposte, fermo in un tempo che si pretende senza storia.
In realtà, per definire, invece, storicamente l’età in cui siamo tuttora immersi è necessario forse ricorrere alla vecchia (e anche un poco generica) categoria del postmodernismo quale cultura del tardo capitalismo, cosí come l’ha definita Fredric Jameson piú di vent’anni or sono, ribadita, sia pure in altri termini, dal libro del 1990 di David Harvey sulla crisi della modernità e da quello di Alain Touraine del 1992 sulla Critica della modernità, e constatare soprattutto il perdurare e allargarsi nei nostri anni delle condizioni descritte da quegli autori1.
Chi ha chiarito tra i primi i fondamenti teoretici della questione è, come noto, il filosofo francese JeanFrançois Lyotard, pubblicando nel 1979 il libro La condizione postmoderna, in cui descrive la mutazione in atto (tramonto dell’età della macchina, globalismo, immaterialità, cultura dell’immagine) e analizza le ragioni dello stato delle cose. Giustamente egli aveva peraltro anche subito intravisto, sin dagli anni Ottanta, i danni che un opaco e frettoloso giudizio positivo del postmodernismo avrebbe prodotto su quella che era per lui un’analisi critica dello stato delle cose.
A tale chiarimento Jürgen Habermas risponde nel settembre 1980 con il celebre saggio La modernità, un progetto incompiuto, in cui rivendica le ragioni di una prospettiva positiva della razionalità possibile delle relazioni sociali e della loro organizzazione politica: se la modernità è costruita dal dialogo tra ragione e soggetto, è questo che implica la responsabilità sociale.
Al di là degli esiti stilistici degli anni del primo postmodernismo, messi rapidamente da parte dal transito delle mode, bisogna essere riconoscenti proprio agli aspetti teorici di questo dibattito che ha evidenziato uno stato di crisi delle teorie e delle pratiche dell’architettura, che dagli anni Ottanta in poi non ha fatto che dilatarsi senza risolversi, pur cambiando stili e linguaggi. Ed è interessante rilevare subito che proprio perché la modernità era nata come ricominciamento radicale in polemica con il passato, essa aveva della storia un senso assai piú vivo di quanto avviene nel primo postmodernismo, per il quale essa è stata materiale stilistico occasionale.
Se è vera la descrizione di Lyotard del sorgere di una nuova condizione, la proposta di perseguire criticamente la tradizione illuminista di Habermas non contraddice tale descrizione, ma rappresenta un progetto che si costituisce come un atto di fiducia nella capacità della società intorno alla possibilità di un suo agire comunicativo, in grado di utilizzare positivamente e nell’interesse collettivo anche quelle nuove condizioni.
Naturalmente chi scrive qui (non solo come architetto) ha da sempre considerato, come molti della mia generazione, la categoria del postmoderno una funesta, anche se storicamente propria, descrizione a volte caricaturale (la caricatura insieme alla sproporzione è un carattere rilevante dell’età postmoderna) della condizione di progressiva disgregazione degli impegni critici della cultura di fronte allo stato delle cose, disgregazione che è proseguita e che permane immutata. Non importa il cambiamento del gusto e degli stili; nei nostri anni Damien Hirst è un «artista», se cosí lo si può definire, tipico dell’ideologia postmodernista per le sue prospettive e anche per come è stato costruito e propagandato dal mercato dell’arte. Le sue differenze rispetto ai neostoricismi degli anni Ottanta sono del tutto superficiali: è solo ammesso senza piú infingimenti l’orgoglio della dissoluzione.
Ed è necessario ricordare a questo punto che non vi è per ora nulla di piú antagonistico rispetto al postmodernismo del progetto moderno, con il suo originale atteggiamento critico, o meglio oppositivo, nei confronti della società e contro lo stato accademico dell’arte che la rappresentava. La modernità, peraltro, ha conservato sino alla metà del XX secolo una condizione minoritaria per divenire poi brevemente egemone, ma solo nella sua interpretazione positivistico-praticista. Perché cos’altro è stata, si domanda Jameson nel suo celebre saggio, la soggettività del progetto moderno se non un’allegoria della rivoluzione, mentre cos’altro è il postmoderno se non la rappresentazione di uno stato?
Non vi è dubbio che il saggio di Jameson debba essere considerato, per un giudizio sulla cultura postmodernista, almeno per quanto riguarda l’architettura, altrettanto preciso (forse anche a causa della simpatia che l’autore provava per i suoi prodotti) di come lo sono stati per la pittura contemporanea i libri di Harold Rosenberg pubblicati vent’anni prima, con la messa in evidenza della crisi tecnica e finalistica delle arti visive e l’emersione dell’evento rispetto all’opera, che è ciò che presiede ormai da quasi mezzo secolo le arti visive e il loro dissolvimento nella cultura mediatica del mercato.
«Questi nostri anni – scrive Jameson all’inizio del suo saggio del 1984 – sono stati caratterizzati da un millenarismo alla rovescia, in cui le premonizioni del futuro, catastrofiche o redentive, hanno lasciato il posto al senso della fine di questo o di quello (fine dell’ideologia, dell’arte o delle classi sociali, della socialdemocrazia, del welfare state, ecc.): considerati nel loro insieme, tutti questi fenomeni costituiscono forse ciò che sempre piú spesso viene chiamato postmodernismo»2. Ma la caratteristica che permane sopra tutte le altre a rappresentare il sogno postmodernista del capitalismo globale è l’aspirazione alla fine della coscienza storica. «È anche probabile – scrive piú avanti – che nei nostri anni al precario ma anche produttivo equilibrio tra i due termini della contraddizione nuovo capitalismo-populismo democratico non vi sia alternativa visibile; tuttavia sarebbe compito della cultura pensare al di là, affermare che tale equilibrio non è la fine della storia, e che non è necessario che ogni mutazione si debba compiere solo al suo interno: con tutti i rischi che ciò comporta. Il capitalismo è nello stesso tempo la cosa migliore e peggiore che sia capitata alla razza umana e quindi ogni giudizio moralistico su di esso è un errore categoriale». «Occorrerebbe – scrive da parte sua Touraine – restituire all’uomo la libertà positiva che per lui sognavano Hegel e Marx, e non accontentarsi della libertà negativa, difesa da Locke e da Kant, che protegge gli individui contro gli sconfinamenti del potere. La libertà positiva è il potere di comportarsi secondo le regole universali della ragione, dunque, come dice Horkheimer nel 1942, è la polis greca senza la schiavitú»3. Ma è proprio a questo compito che la cultura postmodernista ha l’obiettivo di opporsi.
Quando si parla di giudizio storico si potrebbe pensare temerariamente alla possibilità di ricostituire, in modo nuovo, quella distanza critica, che fu il perno dei giudizi della sinistra della cultura negli anni Venti da Brecht sino alla Scuola di Francoforte, ma ancora poi di molti filosofi francesi degli anni Sessanta.
Proprio perché la realtà umana è divenuta in questi anni un complesso organizzato dall’alto e disperso nei fatti in stereotipi, cliché, luoghi comuni la cui descrizione, coincidente con i modi di produzione del tardo capitalismo e in modo ancor piú compiuto con quelli che hanno per ora trasformato la grande opportunità offerta dalla globalizzazione in ideologia della globalizzazione del denaro e del consumo, non può che essere costruita sulla critica diretta o indiretta di una società dei simulacri e dell’indistinzione tra realtà e apparenza.
Ma il cambiamento è un problema che il postmodernismo, proprio con il suo eterno presente, non si pone nemmeno, perché il presente è una forma di sottrazione all’idea di differenza significativa e perché la novità non è una prerogativa del soggetto, ma una spinta strutturale del sistema, e i fenomeni oggi non desiderano affatto essere interpretati ma solo consumati o trasformati in credenze. Perché anche il futuro è ridotto a forecast o proiettato in una tecnoscienza dell’eterno presente.
L’ideologia postmodernista che si prolunga sino all’oggi non è quindi solo falsa coscienza che traveste la realtà dei rapporti sociali, ma è diventata una pratica che fa parte della realtà stessa: rappresentazione del rapporto immaginario degli individui con le proprie condizioni. Cosí la soggettività è costretta a rappresentare sé stessa, in modo esibizionista, cogliendosi solo in situazione, contrabbandata per flessibile creatività. Il populismo resta, quindi, anche da questo punto di vista, uno degli aspetti storicamente strutturali della contemporaneità postmodernista, dell’idea della coincidenza di arte e comunicazione, dell’avvenuta sostituzione dei ceti e dei gruppi alla nozione di classe sociale.
Muoversi dal tentativo di costruire una concezione storica strutturale del postmodernismo in quanto ideologia del mondo attuale mette a lato anche ogni giudizio sul suo carattere meramente stilistico, e questo ci consente di stabilire una continuità che, come ho detto, attraversa e connette almeno per l’architettura, ma io credo per le arti in generale, la sua fase di eclettica nostalgia stilistica (la coesistenza, cioè, dell’idea di simulacro come copia identica di un originale mai esistito e del pastiche, cioè l’incompatibilità del linguaggio storicista con una storicità autentica) e quella attuale della novità incessante dei neo- o ipermodernisti: anche se sono stati accantonati cornici e capitelli.
I procedimenti di bricolage, abbandonata ogni attitudine polemica contro l’aura artistica, sono diventati, nella costituzione della forma, tutti simboli della sua «necessaria assenza di necessità». La ricomparsa rovesciata di senso dei linguaggi delle avanguardie, la loro dispersione fluttuante e intercambiabile è la conseguenza della negazione anche della nozione di contesto, quindi, nel caso dell’architettura, anche del confronto con l’urbano e il suo disegno e dell’assenza della relazione sfondo-figura non sostituibile da alcuna forma di intertestualità, se non quella puramente estetizzante della riduzione a «design» in quanto «form follows the market» e metafora tecnologica, cioè della riconduzione alle ragioni del consumo dell’intera produzione della ex arte.
Tutto questo è accomunato in architettura da ciò che Jameson ha definito il «campo sublime e isterico del surrealismo senza inconscio e dell’iperspazio disorientante», ma anche dal nuovo diventato «novità incessante» e, nello stesso tempo, dal processo di colonizzazione che dilaga come globalizzazione in quanto ideologia del mercato finanziario e del consumo, in una produzione della cultura sempre piú incollata saldamente a quei valori e alla dipendenza da esso del mondo delle stesse tecnoscienze.
Attribuire, però, come qualcuno scrive, all’arte postmoderna dei nostri anni il ruolo di un salto epistemologico pari a ciò che in tempi remoti, o in civiltà antropologicamente altre, fu un diverso ruolo dell’arte, rituale, religioso, decorativo o mercantile, non solo ci sembra una valutazione del diverso valore del tempo storico imparagonabile e difficile quindi da applicare all’oggi, ma che non risolve comunque la condizione di crisi di chi la produce.
È necessario accettare tutto questo come inevitabile e adattarsi allo stato delle cose? È necessario che «l’arte non sia piú – come scrive Yves Michaud – manifestazione dello spirito ma una sorta di ornamento dell’epoca», l’arte come edonismo turistico4?
page_no="16" Oppure l’arte potrebbe invece avere il compito di immaginare, senza rimpianti per il passato, una teoria fondata su un senso altro?
La storia ci insegna che vi sono certamente nella tradizione dell’architettura modi di essere della relazione tra prassi e teoria anche molto diversi tra loro come attività sulla pratica progettuale; la discussione tra grandi architetti a proposito del tiburio del Duomo di Milano alla fine del XV secolo è una di queste, o le teorie disegnate come i 33 fogli di Villard de Honnecourt del XIII secolo, ma anche taccuini di viaggio come quelli di Nicoletto da Modena o di Vincenzo Scamozzi verso Parigi o del Voyage en Orient di Le Corbusier, scritti che accompagnano progetti per cercare di chiarirne le intenzioni, e poi anche teorie disegnate, scritti con scopi pedagogici, manuali, che tramandano le esperienze costruttive, testi che raccolgono e commentano le architetture giudicate le migliori del periodo, corsi di architettura (come quelli per esempio di Jean-François Blondel), traduzioni e commenti di libri antichi e persino i documenti descrittivi come quelli di Bonvesin de la Riva su Milano o di Leonardo Bruni su Firenze, ma anche scritti direttamente teorici come le osservazioni dell’abate Laugier sull’architettura o il Laocoonte di Lessing.
I tentativi degli artisti di affrontare i loro problemi sul piano teoretico e quindi di considerare l’arte una professione intellettuale sono, si sa, molto antichi e risalgono almeno agli anni tra il v e il IV secolo a.C. Anche le firme degli artisti, un indubbio documento di affermazione dell’idea di autore, cominciano a comparire su vasi e statue nella Grecia del VI secolo a.C., ma non siamo certi che questo non avvenisse assai prima. Anche se ancora la cultura romana antica non accolse mai gli artisti visivi tra le artis liberalis, Vitruvio cita nell’introduzione al suo libro un certo numero di opere di teoria dell’architettura, come quella di Teodoro di Samo.
Tuttavia, il trattato è forse il modo con cui piú propriamente le teorie del progetto si esplicano, anche se bisogna dire che nella forma piú chiara e compiuta il trattato, dopo quelli antichi a noi sconosciuti, fatto salvo quello di Vitruvio (giunto a noi senza illustrazioni), ha una vita relativamente breve: dal XV secolo, cioè dal trattato di Leon Battista Alberti sino alla fine del XVIII secolo, con Boullée, Ledoux, e il Milizia.
Naturalmente non mancano (anche in altra forma, come i testi di Durand o di Rondelet) le riflessioni teoriche nel XIX secolo da Viollet-le-Duc ad Augustus Pugin, da Ruskin a William Morris, solo per citarne alcuni, sino agli utopisti come Owen o Fourier. Anche le collezioni disegnate di monumenti architettonici (come ad esempio la raccolta cinquecentesca dei Plus excellents monuments de France di Jacques Androuet du Cerceau) devono essere considerati, con i loro criteri espliciti o impliciti di scelta, parte del patrimonio delle teorie dell’architettura, o infine le influenze dovute alla rilettura di trattati (si pensi al neopalladianesi...