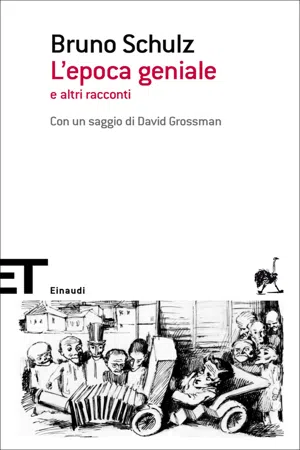![]()
Tutto il possibile infinito
di David Grossman
Primavera del 1933. Il pomeriggio della domenica di Pasqua. Dietro il banco della reception di un piccolo hotel di Varsavia c’è Magdalena Gross. Magdalena è una scultrice e il suo piccolo albergo a conduzione familiare è un punto d’incontro di scrittori e intellettuali. Nella hall è seduta una ragazzina ebrea di circa dodici anni, nativa di Łódź. I genitori l’hanno mandata a Varsavia per riprendersi da una grave malattia. Un uomo piccolo, magro e pallido entra nell’hotel con una valigia. È un po’ curvo, alla bambina sembra spaventato. Magdalena gli domanda come si chiama. – Schulz, – risponde lui, – sono un insegnante, ho scritto un libro e…
Magdalena lo interrompe: – Da dove viene?
– Da Drohobycz.
– E come è arrivato qui?
– In treno, passando per Danzica.
La donna ridacchia. – Danzica? Lei danza?
– Come? No, assolutamente no –. L’uomo giocherella con l’orlo della giacca. Magdalena ride, divertita delle proprie spiritosaggini, strizza l’occhio alla bimba al di sopra della spalla di Schulz.
– E cosa è venuto a fare qui? – gli chiede finalmente. – Sono insegnante di disegno al ginnasio, ho scritto un libro di racconti, – sussurra lui, – sono venuto a Varsavia solo per questa notte, vorrei consegnarlo a Madame Nalkowska –. Magdalena squadra l’uomo dall’alto in basso. Zofia Nalkowska è una famosa scrittrice e drammaturga nonché membro della commissione editoriale della prestigiosa casa editrice Rój. – E come farà arrivare il libro a Madame Nalkowska? – gli domanda con un sorrisetto.
L’uomo balbetta, abbassa lo sguardo. Ma il suo tono è caparbio: qualcuno gli ha detto che Madame Gross conosce Madame Nalkowska. Se fosse cosí gentile da…
Non appena pronuncia questa frase Madame Gross accantona l’atteggiamento irrisorio. Forse perché l’uomo ha un’aria tanto spaventata, intuisce la bambina. Oppure per quella sua ostinazione quasi disperata. Magdalena Gross va al telefono, parla con Zofia Nalkowska e le dice dell’uomo. – Se dovessi leggere il manoscritto di ogni balordo che arriva a Varsavia, – risponde Nalkowska, – non avrei il tempo di scrivere.
Magdalena Gross le chiede di dargli un’occhiata. – Solo alla prima pagina, – bisbiglia nella cornetta, – cosí ci liberiamo di lui.
Zofia Nalkowska accetta a malincuore. Magdalena Gross riattacca. – Prenda un taxi. Madame Nalkowska la riceverà tra mezz’ora, per dieci minuti.
Schulz esce di corsa. Dopo un’ora è di ritorno. Senza il manoscritto. – Cosa le ha detto Madame Nalkowska? – domanda Magdalena.
– Mi ha chiesto di leggerle la prima pagina ad alta voce, – risponde Schulz, – poi mi ha interrotto. Mi ha detto di lasciarle il manoscritto e di tornare qui all’albergo. Mi contatterà lei.
Magdalena Gross gli offre un tè, ma lui non riesce a berlo. Aspettano in silenzio. L’atmosfera nella hall a un tratto si fa seria, tesa. Schulz cammina nervosamente avanti e indietro. La ragazza – Jacarda – lo segue con lo sguardo. Anni dopo, divenuta adulta, lascerà la Polonia e andrà a vivere in Argentina. Diverrà pittrice, sposerà uno scultore e racconterà questo episodio sessant’anni dopo, durante una visita a Gerusalemme.
I tre aspettano. Ogni squillo del telefono li fa sobbalzare. Finalmente, verso sera, Zofia Nalkowska chiama. Le manca la voce. Ha letto soltanto trenta pagine. Ci sono cose che è certa di non avere capito eppure le sembra di trovarsi in presenza di una rivelazione. Forse la piú importante rivelazione della letteratura polacca degli ultimi anni. Lei stessa sarebbe onorata di proporre il manoscritto – il piú presto possibile – a una casa editrice. La bambina guarda Schulz che sembra sul punto di svenire. Gli portano una sedia. Lui vi si lascia cadere e si prende la testa fra le mani.
Dei numerosi aneddoti, storie e leggende che ho udito su Bruno Schulz questo mi commuove in modo particolare. Forse per via delle modeste circostanze in cui una stella tanto brillante è venuta alla ribalta, o forse perché è narrato dall’innocente punto di vista di una bambina, Jacarda, che osservava quell’uomo dall’aspetto fragile quanto quello di un bambino da un angolo della hall dell’albergo.
Ed ecco un altro aneddoto: quando Schulz era ragazzo, una sera malinconica, sua madre Henrietta entrò in camera sua e lo trovò che nutriva con granelli di zucchero le ultime mosche rimaste al termine del freddo autunno.
– Bruno, – gli domandò, – ma che fai?
– Le sto irrobustendo per l’inverno.
Bruno Schulz, uno scrittore ebreo polacco, nacque nel 1892 nella città di Drohobycz, in Galizia, una regione allora entro i confini dell’impero austro-ungarico e oggi dell’Ucraina. Non ha lasciato molti scritti: solo due raccolte di racconti, qualche decina di saggi, articoli, recensioni, oltre a disegni e schizzi. Ma questo poco racchiude un mondo intero. I suoi due libri: Le botteghe color cannella (1932) e Il Sanatorio all’insegna della Clessidra (1937) creano un universo fantastico ripercorrendo la mitologia privata di una famiglia, e il loro lessico è tanto ricercato e vivido da essere esso stesso protagonista e l’unica dimensione in cui quei racconti possano esistere. Schulz scrisse inoltre un romanzo intitolato Il Messia, andato perduto durante la guerra. Nessuno ne conosce la trama. Una volta incontrai un uomo al quale Schulz aveva mostrato l’incipit: l’alba che si levava su una città. La luce che si faceva sempre piú forte. Torri e guglie. Non vide altro.
Alla pubblicazione del suo primo libro Schulz fu immediatamente riconosciuto come un raro talento, soprattutto dai circoli letterari polacchi e, negli anni, è divenuto una figura di notevole interesse per scrittori e lettori di tutto il mondo. Autori del calibro di Philip Roth, Danilo Ki∫, Cynthia Ozick, Nicole Krauss, e altri ancora hanno parlato di lui, trasformandolo in un personaggio dei loro libri o rievocando la storia della sua vita. Schulz è uno di quegli autori la cui opera, come pure la personalità e la vita, è spesso soffusa da un alone di meraviglia e di mistero.
Era uno di quelli cui Dio ha passato la mano sul viso nel sonno, cosí che sanno ciò che non sanno, diventano pieni di congetture e di sospetti, mentre attraverso le loro palpebre chiuse passano i riflessi di mondi lontani1.
Cosí scrive Schulz a proposito di Alessandro Magno nel suo racconto Primavera. E lo stesso potremmo dire facilmente di lui. E ho l’impressione che anche noi, suoi lettori, proviamo qualcosa di simile nel momento in cui i suoi racconti scorrono sotto i nostri occhi.
Perché scrivo queste cose? Soprattutto a seguito di una testimonianza commovente sugli ultimi istanti di vita di Bruno Schulz – di cui non si sa molto –, e che ho appreso di recente. Prima di riferirla, però, vorrei parlare del «mio» Bruno Schulz, del modo in cui ha influenzato i miei scritti.
Ho l’impressione che tutti coloro che amano questo autore abbiano una propria storia personale riguardo alle circostanze in cui lo hanno scoperto. Io mi imbattei in lui dopo la pubblicazione del mio primo romanzo, Il sorriso dell’agnello.
Un bambino, quando nasce, sembra provenire dall’ignoto. La famiglia sente allora il bisogno di riconoscerlo come proprio, di rendere comprensibile, e forse anche un po’ meno «pericolosi», la sua novità, il suo mistero. I parenti si chinano sulla culla, osservano il neonato da vicino ed esclamano: – Ma guarda, ha il naso di zio Jacob! E il mento identico a quello di zia Malka!
Qualcosa di simile succede alla pubblicazione di un’opera prima. Critici e lettori si affrettano a informare il nuovo scrittore a chi si è ispirato, da chi è stato influenzato, e naturalmente, da chi ha copiato. Per inciso dirò che spesso, dopo aver letto le opere degli autori ai quali i miei critici sostenevano avessi fatto riferimento (quasi sempre per la prima volta), ho scoperto che avevano decisamente ragione.
Un giorno ricevetti la telefonata di un certo Daniel Schilit, un ebreo polacco immigrato in Israele che aveva letto il mio libro. – Si nota subito quanto lei sia stato influenzato da Bruno Schulz, – mi disse.
Io, giovane ed educato, non lo contraddissi. In realtà prima di quel giorno non avevo mai letto niente di Bruno Schulz. Dopo quella telefonata, però, pensai di procurarmi un suo libro.
Quella sera, a casa di amici, mi imbattei nell’edizione ebraica di Le botteghe color cannella. Chiesi in prestito il volume e lo lessi nell’arco di poche ore. Ancora oggi faccio fatica a descrivere l’emozione che mi assalí.
Giunto alla fine lessi l’epilogo del traduttore israeliano, Yoram Bronowski, e per la prima volta scoprii il modo in cui Schulz era morto. Nel ghetto di Drohobycz un ufficiale delle SS aveva approfittato del suo talento per decorare le pareti di casa e lo aveva preso sotto la sua protezione. Un avversario di quell’ufficiale aveva poi sparato a Schulz per strada, per provocare il rivale. Si racconta che quando i due nazisti si erano incontrati dopo l’assassinio uno avesse detto: – Ho ammazzato il tuo ebreo, – e l’altro avrebbe risposto: – Benissimo, e ora io ammazzerò il tuo.
Ricordo di aver chiuso il libro, di essere uscito di casa e di aver vagato in un campo vicino per qualche ora. Camminavo come avvolto nella nebbia. Non ero in grado di rientrare e non volevo incontrare nessuno. Non capivo come si potesse continuare a vivere in un mondo in cui potevano accadere cose come queste, dove esistevano persone come queste, dove si potevano pensare cose come queste. Un mondo in cui c’era una lingua che permetteva di pronunciare frasi tanto mostruose. E ricordo anche che, unitamente al senso di paralisi, sentii risvegliarsi in me il bisogno di riscattare la vita e l’esuberanza che avevo scoperto in Bruno Schulz, nelle sue parole, nei suoi racconti. Riscattarli dalla crudeltà, dalla tirannia e dalla laconicità di quella frase: «Ho ammazzato il tuo ebreo…»
Non sempre uno scrittore è in grado di identificare il momento esatto in cui germoglia in lui l’idea di un libro. L’istante del concepimento. Dopo tutto cosí tanti pensieri e sentimenti si accumulano in un qualche punto dell’anima, per anni, prima di giungere a maturazione e sfociare nella scrittura. Eppure, sebbene per molti anni avessi voluto scrivere della Shoah, furono quelle due frasi «Ho ammazzato il tuo ebreo» e «Benissimo, e ora io ucciderò il tuo» a darmi la spinta finale, a rappresentare una sorta di scossa elettrica che innescò la stesura del mio romanzo Vedi alla voce: amore.
I numerosi ammiratori di Schulz conoscono la storia che ho qui riportato sulle circostanze della sua morte. Il poeta e scrittore polacco Jerzy Ficowski, uno dei maggiori studiosi della vita e delle opere di Schulz, riferisce nel suo libro, Regions of the Great Heresy (pp. 137-138), che poco prima di un massacro, noto come «L’eccidio del Giovedí Nero», un ufficiale della Gestapo, tale Felix Landau, uccise un dentista ebreo di nome Lowe, «protégée» di un altro ufficiale nazista, Karl Günther. Fra i due non correva buon sangue e l’omicidio del suo protetto spinse Günther a cercare vendetta. Proclamando le sue intenzioni andò allora a cercare Schulz, beniamino di Landau e, approfittando degli eventi del «Giovedí Nero», gli sparò all’angolo fra Czacki e Mickiewicz Street. «Secondo quanto riferiscono numerosi residenti di Drohobycz, – scrive Ficowski, – nell’incontrare poi Landau, Günther proclamò solennemente: “Tu hai ucciso il mio ebreo, e io ho ucciso il tuo”».
Ficowski riporta questa storia con cautela e diffidenza. C’è anche chi la reputa una leggenda, una diceria, un aneddoto, ritenendo che Schulz sia stato effettivamente assassinato nel ghetto di Drohobycz ma che le cose siano andate diversamente e quell’orrendo scambio di battute non sia mai avvenuto.
Il dibattito tra i sostenitori delle diverse versioni perdura da decenni, senza che possa trovare apparente soluzione, e forse sarebbe bene ricordare le parole che lo scrittore argentino Ernesto Sabato scrisse in un contesto totalmente diverso:
Gli aneddoti sono sostanzialmente fedeli alla verità, proprio perché sono finzioni, inventati in dettaglio per adeguarsi con grande precisione a una certa persona.
Ma anche se ritenessimo la conversazione tra gli ufficiali della Gestapo – Landau e Günther – pura invenzione, essa ci tocca nel profondo perché, malgrado tutto, è sostanzialmente fedele a una qualche verità tragica e ironica riguardante l’uomo Bruno Schulz, il suo senso di estraneità esistenziale, di impotenza, il suo modo di essere.
Da quando ho capito che sarei diventato scrittore ho anche capito che avrei scritto della Shoah. Penso che queste due consapevolezze siano nate in me contemporaneamente. E piú il tempo passava piú sentivo crescere in me la sensazione che non sarei stato in grado di comprendere la mia esistenza di uomo, di padre, di scrittore, di israeliano e di ebreo fintanto che non avessi scritto della vita che non avevo vissuto all’epoca della Shoah, nei luoghi della Shoah.
In altre parole mi chiedevo come mi sarei comportato se fossi stato un ebreo all’epoca del dominio nazista, in un ghetto, in un campo di concentramento o di sterminio. Cosa avrei potuto fare per salvare qualcosa di me, del mio essere, in una realtà in cui le persone venivano spogliate non solo dei loro abiti ma dei loro nomi e dei loro affetti, venivano quasi totalmente private della loro vita precedente – dei famigliari, degli amici, degli amori, della professione, del talento –, sradicate dal contesto in cui vivevano e spinte da altri esseri umani al gradino piú basso dell’esistenza, divenendo numeri stampati su un braccio, carne e sangue, creature destinate a essere sterminate con la massima efficienza.
Volevo sapere cosa in me si sarebbe opposto a questo tentativo di annichilimento e avrebbe preservato una scintilla di umanità in un mondo interamente finalizzato a spegnerla.
Quando terminai di leggere il libro di Schulz capii di aver trovato la chiave con la quale avrei potuto scrivere della Shoah. Non scrivere della morte e dello sterminio, ma della vita, di ciò che i nazisti avevano distrutto in maniera meccanica e su vasta scala. E non di una vita trascorsa fiaccamente ma di una come quella che Schulz ci insegna nei suoi libri: vera, alla massima potenza, nella quale la gente che ho appena incontrato, l’attimo appena trascorso, la scena già vista migliaia di volte, la parola ripetuta e scritta all’infinito, si rinnovano incessantemente.
Ricordo anche che, con l’arroganza del giovane scrittore, dissi a me stesso che volevo scrivere un libro che tremasse sullo scaffale. Vitale quanto un battito di ciglia nella vita di un uomo. In ogni pagina di Schulz, infatti, in ogni suo brano, la vita esplode ed è degna di questo nome. È ricca di contenuto, di significato e avviene simultaneamente in tutti i substrati del conscio e dell’inconscio, dell’illusione, del sogno, dell’incubo, dei sensi, dei sentimenti, di un linguaggio ricco di sfumature. Ogni riga è una ribellione contro ciò che Schulz definisce «il muro fortificato che grava sul significato». È una protesta contro la desolazione, la banalità, la routine, la stupidità, gli stereotipi, la tirannia del semplicismo, della massa, contro tutto ciò che è privo di audacia, di ispirazione, di nobiltà di spirito.
E la storia – vera o presunta – dell’assassinio di Bruno Schulz ancora oggi ci sconvolge tanto perché crea un insopportabile conflitto tra il modo di pensare e di agire dei nazisti e ciò che l’uomo Bruno Schulz era riuscito a creare in forza della sua aspirazione, della sua elevazione spirituale.
Nel racconto I manichini scrive di suo padre:
Vale la pena notare come tutte le cose, a contatto con quell’uomo straordinario, risalissero in certo qual modo alla radice della loro esistenza, ricostruissero la loro realtà fenomenica fino al nucleo metafisico, tornassero per cosí dire all’idea primigenia per distaccarsene poi a quel punto e volgere in quelle regioni dubbie, rischiose e ambigue che chiameremo qui, brevemente, regioni della grande eresia2.
Non c’è descrizione piú azzeccata dello stile dello stesso Schulz, della sua ricerca costante del «nucleo metafisico» delle cose, ma anche del suo coraggio di cambiare, di punto in bianco, il proprio punto di vista e volgere, all’ultimo minuto, in maniera ironica e significativa, «nelle regioni della grande eresia».
È questa la forza di uno scrittore che non si fa illusioni circa la natura arbitraria, caotica e casuale della vita eppure è determinato a costringere quell’esistenza banale e indifferente a capitolare, a spalancarsi, a rivelare ai nostri occhi il nucleo del significato celato nelle sue profondità. Oserei dire: il nucleo di un’umanità nascosta. E malgrado egli creda fermamente in un qualche «significato», «senso» o «legge» che crea e guida tutto ciò che è al mondo – uomini, animali, piante, o anche oggetti inanimati ai quali attribuiva, sempre con un sorriso, un’anima e dei desideri – è altresí capace, nella frazione di un secondo, di sradicarsi da questa convinzione, di disconoscerla con una sorta di disperazione abissale, demoniaca, che accentua in noi la sensazione della sua profonda solitudine e l’intuizione che quest’uomo non poteva trovare consolazione in questo mondo.
All’inizio dell’estate del 2008, in una casa di riposo di Beer Sheva, incontro Zeev Fleischer, un uomo di 83 anni che per due anni, dal 1939 al 1941, era stato alunno di Bruno Schulz al ginnasio Sternbach, una scuola superiore ebraica situata in Szaszkiewicz Street (poco lontano dal centro della città di Drohobycz) dove la lingua di insegnamento era il polacco.
– Ufficialmente Schulz era insegnante di disegno e applicazioni tecniche, – racconta Fleischer, – era una persona timida e molto chiusa. Agli occhi degli estranei non valeva granché. Perché? Perché un uomo deve guadagnare denaro! E chi scriveva «scemenze» come Schulz, non era tenuto in gran conto. Veniva considerato «segatura umana»…
Era un insegnante strano. Aveva ottenuto l’impiego al ginnasio grazie a degli amici che si occupavano di letteratura e riconoscevano il suo genio letterario. Il suo primo libro Le botteghe color cannella, era già stato pubblicato nel 1934. Sapevano che Schulz non aveva chance di sopravvivere in un ambiente in cui contava solo il denaro, e avevano deciso di aiutarlo.
Avrebbe dovuto insegnare disegno e applicazioni tecniche ma ben presto...