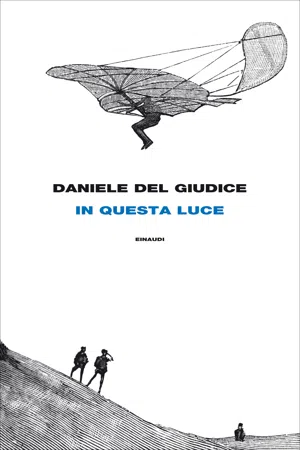![]()
![]()
La mia passione all’inizio non era tanto per la scienza ma per la meccanica e la tecnica. Non si tratta di una scelta intellettuale. Sono cresciuto nelle periferie di Roma con la passione comune dei motori e delle motociclette. Le mie amicizie si basavano sui carburatori, le valvole, i pistoni, sulla cura dei motori e su come «truccarli» per succhiare qualche sprint in piú. Avevo un altro gruppo di amici che leggevano i romanzi e con i quali parlavo di filosofia e di letteratura. Queste due comunità si detestavano. Gli amici filosofi consideravano i motociclisti dei bruti e gli amici motociclisti consideravano i filosofi persone pallide e noiose. Tutto ciò si è protratto negli anni e ancora oggi vivo con una sorta di imbarazzo il fatto di passare ore negli hangar coi meccanici che smontano le eliche e controllano gli strumenti di navigazione aerea. Quando ho cominciato a scrivere romanzi e racconti mi è sembrato naturale introdurre gli elementi di quella mia formazione profana, che comunque appartiene all’esperienza e al senso del «fare» quotidiano. Le scienze e le tecniche sono un riferimento conoscitivo indispensabile, un nutrimento, e la curiosità per un immaginario che lavora in modo diverso. Sono dei vicini di casa che non si conoscono, che non si sa bene cosa facciano, e che ti affascinano, ti emozionano. Le persone di scienza, anche quando parlano di una piccola questione, di un problema specifico, presuppongono sempre ipotesi sull’origine e sulla fine, e sono rimaste le ultime a farlo, insieme ai teologi. Descrivono come avverrà la morte del sole, e come gli umani di allora, prima ancora di percepirla come esplosione, se ne accorgeranno dalla perdita della loro gravità corporale, non potranno piú restare aggrappati alla terra. Certe volte i fisici, piú i teorici e meno gli sperimentali, mi appaiono come gli ultimi metafisici «con onere della prova». Ma quando tento questo discorso con loro sorridono o scuotono la testa o si arrabbiano.
Ha ragione Ian Mc Ewan. Secondo un pregiudizio romantico e spiritualista, uno che scrive non deve avere alcun rapporto con la materia, non deve neppure sapere come si chiude la macchina del caffè, deve essere lontano dalla materia perché la materia è distante dallo spirito. Gli «altri» vivono nel mondo della materia, operano con la materia, hanno a che fare con le cose, con gli oggetti, con le macchine, e di fatto sono loro, con il loro vivere tra gli oggetti e le macchine, che fanno e che formano le storie per chi scrive. Ci sono davvero delle cose in comune nelle storie di Ian e nelle mie. In Lettera a Berlino l’idea straordinaria della costruzione di un tunnel sotto il Muro è alla base dell’intero suo romanzo, è un oggetto d’ingegneria e di spionaggio quel che sorregge tutto il racconto; io, in Atlante occidentale, ho voluto che l’anello di collisione di particelle, realmente esistente nel Cern di Ginevra e lungo ventisette chilometri, fosse il cuore propulsivo del romanzo, dei personaggi e di una loro nuova capacità di percezione ed emozione. Ian ha parlato di Voltaire. È davvero una combinazione che proprio sopra quell’anello si trovi la villa di Voltaire; l’ho descritta come vuota, con le impronte dei mobili sui muri spogli, quasi non ci fosse piú bisogno di tanto illuminismo. Quello che mi piace della scienza, e della fisica in particolare, è che parla di cose che spesso sono al di fuori della nostra esperienza sensibile e che chiedono un adeguamento del nostro sentire e del nostro immaginare. Nelle teorie dell’Unificazione, cioè le teorie che tendono a unificare le diverse descrizioni della materia in una sola legge, la piú semplice, la piú economica, e quindi anche la piú elegante, nei modelli che si basano su «stringhe» e «superstringhe», si parla di dieci dimensioni o piú, mentre noi possiamo percepirne soltanto quattro, tre spaziali e una temporale. Il mondo degli scienziati ha dimensioni molteplici, il nostro ha soltanto le dimensioni che corrispondono ai labirinti auricolari, i tre assi che, tra l’altro, sono i tre assi su cui si vola con gli aeroplani. Ho usato spesso in Atlante occidentale, e anche altrove, termini scientifici rinunciando a spiegarli, perché inseguivo l’effetto di parole sconosciute ai piú, come sconosciuti ai piú restano i concetti e le emozioni di quella fisica.
Avrei due piccole esperienze, due storie che posso raccontare sulla presunta fine della «grande» scienza, alla quale non credo. Anni fa dentro l’anello di Ginevra parlavo con un fisico sperimentale cui avevo chiesto di portarmi clandestinamente con sé. Di fronte alle enormi macchine per «vedere» le collisioni e la materia come le vedono i fisici per dimostrare la validità delle teorie, gli ho domandato se era consapevole delle implicazioni conoscitive piú ampie e generali che il suo lavoro comportava. Ha risposto: «Non so, io sono un meccanico, sono come un elettrauto. Faccio la mia parte di esperimento, tutto qui». Gli ho domandato allora che ne era degli scienziati che una volta si ritrovavano la sera e suonavano il violino e parlavano di Leibniz, dove sono finiti? Mi ha risposto: «Ma quelli erano i pre-bellici», cioè antecedenti la Seconda guerra mondiale. Anni dopo ho partecipato con Claudio Magris a un laboratorio alla Scuola internazionale di studi avanzati di Trieste sull’immaginario scientifico e l’immaginario narrativo. Il centro di Trieste era diretto allora da Abdus Salam, fisico pakistano, premio Nobel e musulmano praticante. Lí abbiamo lavorato per alcuni anni con matematici e fisici. Claudio era piú interessato ai punti di contatto nel nostro e nel loro modo di immaginare, io ero piú attratto dal patrimonio delle diversità. A proposito della meccanica quantistica, abbiamo scoperto come per i fisici teorici costituisse una ferita ancora aperta. Due di loro ci hanno spiegato a lungo il loro modello teorico per rinormalizzare i paradossi della meccanica quantistica, che non piacevano nemmeno ad Einstein: la indecidibilità, la non predittività, l’ambiguità. Eppure la fisica quantistica funziona benissimo, la usiamo senza rendercene conto negli oggetti quotidiani di oggi. Del resto gli oggetti di oggi non sappiamo piú come sono fatti, non possiamo metterci le mani dentro, li usiamo e basta. Inconoscibilità e impiego: non erano queste anche le caratteristiche del mito prima che diventasse racconto? Se l’universo è qualcosa un po’ distante da pensare, la meccanica quantistica ci riguarda da vicino, riguarda il nostro corpo, la materia che è in noi. Penso alle recenti ricerche di un fisico italiano bravissimo, Mario Rasetti, che mi parla di come una proteina per riprodursi debba fare ogni volta milioni di calcoli ricavando la misura e le possibilità di se stessa dal contesto circostante, dalle circostanze. E sono felice quando mi dice che la materia stessa è intelligente (altro che materia e spirito), quando mi dice che la materia «pensa». E lo dice rigorosamente da scienziato, non da filosofo, lo dice come un meccanico particolare, un meccanico quantistico.
Ian Mc Ewan cita Conrad. Anche per me Conrad è sempre stato importante. È forse lo scrittore che piú nel suo tempo ha narrato il male, la parte oscura, nera, che è in noi. Lo ha fatto prevalentemente attraverso le esperienze di un sapere e di un fare specifico, tecnico e commerciale, che era quello della marineria. Ian ricorda Il negro del Narciso, io penso a Tifone, che da un certo punto di vista è un romanzo sulla condotta e sul governo delle navi col mare in tempesta, e soprattutto sulle differenze tra ciò che è scritto nei manuali di navigazione e la realtà viva di ciò che accade. In Cuore di tenebra Marlow trova un libro presso una capanna abbandonata lungo il fiume; il romanzo è cosí teso e cruciale che ci aspettiamo che l’unico libro che appare sia anch’esso cruciale, che so, la Bibbia o Shakespeare. Ma quel libro si intitola modestamente Indagine su alcuni aspetti dell’arte marinaresca. Infine, c’è un piccolo saggio di Conrad degli ultimi anni, il cui titolo è Fuori della letteratura. È un saggio sugli «avvisi ai naviganti», su come ebbe a leggerne nel suo lavoro di ufficiale in seconda e su come li scriverebbe lui se fosse chiamato a farlo. Gli avvisi ai naviganti, dice Conrad, sono fuori della letteratura, eppure sono letti con la massima avidità con cui sia mai stata letta carta stampata. Non fanno sospirare, né sorridere né rabbrividire. Ma corrispondono a un unico ideale: quello dell’assoluta responsabilità.
Andare fuori, andare via è stata per secoli una forma particolare dell’esperienza: conoscenza dell’altro, conoscenza di ciò che è diverso. Ma soprattutto i luoghi contengono le storie, e bisogna saperle ascoltare. Ho girato posti molto differenti, una decina di anni fa ho vissuto piú di un mese in Antartide per capire quanto «pazzi» erano gli scienziati che vivevano permanentemente laggiú, e quanto presente fosse ancora la memoria delle leggendarie imprese epiche e scientifiche di Shackleton e Scott. Ho sempre viaggiato per conoscere e per ascoltare le storie che i luoghi racchiudevano, e con le storie le persone e la loro vita. Anni fa venni a sapere che a Napoli c’era un cimitero dimenticato, molto particolare, una vera macchina illuminista, destinata al fallimento come tutte le macchine utopiche di questo tipo: un cimitero «matematico» con 366 fosse, cimitero dei poveri, costruito nella seconda metà del Settecento dall’architetto Fuga. Le tombe erano numerate da 1 a 366 perché i giorni dell’anno sono 365 ma 366 negli anni bisestili. Il 1° gennaio di ogni anno veniva aperta la fossa numero 1 e i morti poveri che arrivavano venivano buttati dentro uno sull’altro; alla sera la fossa veniva chiusa e sarebbe stata riaperta soltanto il 1° gennaio dell’anno successivo. Il 2 gennaio veniva usata la fossa numero 2, e cosí via. Era un cimitero ma anche un calendario. Strana matematica dei morti. Quel luogo conteneva o attendeva una storia e ho provato a raccontarla in Mania. Ogni volta che andavo a Napoli faticavo per trovare il cimitero di Fuga, perché nessuno ne ricordava l’esistenza. Ho detto che i luoghi portano le storie, ma spesso accade anche il contrario, sono i personaggi che ti portano ai luoghi. Cosí è stato per lo Stadio di Wimbledon, quando ho dovuto inseguire gli anziani protagonisti di quel romanzo da Trieste fino a Londra.
Preferirei usare il termine «mania» piuttosto che «ossessione». So che in inglese il termine «mania» ha un significato piú ristretto del corrispondente italiano e porta direttamente al serial killer. Al contrario, «mania» nel mondo antico era una parola doppia, una parola «male-bene». Mania ha la stessa radice di mente e di màinomai, verbo greco che significa infuriarsi, da cui ménade, e si estende nell’aggettivo manikòs, «frenetico». Ma nell’orizzonte greco «mania» indica non soltanto il demone che sconvolge la mente, ma anche una particolare forma di concentrazione, una forma estrema del conoscere e del coincidere con il proprio destino. La mania può sostenere anche un grande matematico, un poeta, un musicista, un inventore. «Ossessione» è invece uno dei molteplici composti del verbo latino sideo, «sedere», obsideo, da cui ossesso. È curioso che la mania venga descritta come una disposizione della mente e l’ossessione come una posizione del corpo. Il maniaco è smanioso, frenetico, l’ossessionato sta seduto. La mania la fiuto nella realtà e nei sentimenti delle persone d’oggi come una forma estrema, nella quale siamo immersi piú di quanto appare. E c’è qualcosa di nuovo: la mania, disposizione della mente, tende oggi sempre piú al passaggio all’azione. Anche nel Medioevo era conosciuto il demone meridiano, che aggrediva a metà giornata con immagini ossessive, fantàsmata in greco; ma i fantasmi interiori non potevano essere messi in atto, e dunque ci si ritraeva nella delusione, nella melanconia. Oggi, al contrario, i fantasmi chiedono come allora di passare all’atto, ma senza piú remore: vogliamo agirli e ci riusciamo.
![]()
Mezzanotte, ventiquattresima ora del giorno, istante ultimo e anche primo, valico del giorno passato e incipit del nuovo, ore ventiquattro e ora zero, «nulla» temporale e temporale «tutto», mezzanotte civile, mezzanotte vera, che corrisponde astronomicamente all’istante in cui si verifica la mezzanotte media al meridiano centrale del fuso orario di un luogo. Nella tradizione popolare e letteraria, viva fin dall’antichità, la mezzanotte è l’ora piú buia della notte, quella in cui appaiono i morti, gli spiriti, le streghe, è quando si compiono incanti e sortilegi. Ma a mezzanotte può anche esserci il sole, il sole di mezzanotte, noto fenomeno per cui l’astro, nel corso della sua apparente rotazione diurna attorno alla terra, non scende oltre l’orizzonte in alcuni luoghi, alcuni punti situati nelle calotte polari e caratterizzati da latitudine Nord o Sud maggiore di 66° 17´,e resta visibile per tutte le ventiquattro ore, per diciassette giorni a 70° o per metà dell’anno a 90°, cioè ai poli. La mezzanotte ha poi un compito grave, la responsabilità del passaggio da un anno all’altro, assumendo su di sé il peso di almeno 365 giorni già consumati, da archiviare, e di altrettanti giorni incipienti, il nuovo calendario, e del passaggio da un decennio all’altro, da un secolo e da un millennio all’altro.
L’intera notte, il notturno intero, sembra concentrarsi e coagularsi nella mezzanotte, è il suo perno, il centro. Senza dubbio nella mezzanotte si lavora e si soffre parecchio: il pingue e bonario dottor Henry Jekyll, chimico e medico, si trasforma in Edward Hyde mentre passa dalla sua abitazione al laboratorio di scienziato nella buia Londra vittoriana, straordinaria invenzione di Robert Louis Stevenson. A mezzanotte Dostoevskij getta le ultime carte del Giocatore Aleksej Ivanovič, e a quell’ora Dostoevskij stesso è obbligato a giocare per pagare i molti debiti di gioco, per Polina Aleksandrovna della quale è follemente innamorato. A mezzanotte Amleto attende sui bastioni lo spettro di suo padre che gli racconterà di come è stato ucciso, e quante volte attorno a mezzanotte Franz Kafka si aggirò inquieto nella sua casa o nelle vie di Praga, mentre scriveva la Metamorfosi, lo raccontò nelle lettere alla sua amata Felice Bauer. Dickens, poi, aveva una vera adorazione per la mezzanotte, specialmente la mezzanotte delle feste natalizie quando si aggirano gli spettri dei festeggiamenti trascorsi o le giovani governanti ingannate, tradite, e proprio a mezzanotte nasce David Copperfield: nello stesso istante l’orologio rintocca e lui vagisce e per questo è votato, dice la sua balia, a una vita infelice e al dono di vedere i fantasmi. Ed è ancora mezzanotte, e ancora inverno, nella piú bella e piú conosciuta poesia di Edgar Allan Poe, Il Corvo, che inizia cosí: «Era una cupa mezzanotte e mentre stanco meditavo su bizzarri volumi di sapere remoto, mentre, il capo reclino, mi ero quasi assopito, d’improvviso udii bussare leggermente alla porta. C’è qualcuno – mi dissi – che bussa alla mia porta. Solo questo e nulla di piú». A mezzanotte Jorge Luis Borges, nel suo El Aleph, racconta di aver calpestato l’ombra nera del palazzo opera degli dèi sulla sabbia gialla, e di aver pensato che quegli dèi che lo avevano edificato erano morti, che erano pazzi. E ogni notte fino ai dodici tocchi della mezzanotte un giovanissimo Cesare Pavese aspetta davanti al caffè concerto La Meridiana, sotto una pioggia insistente e gelida, la cantante ballerina Pucci che esce alle sei da una porta sul retro per incontrare un altro.
Se la mezzanotte non ha una buona reputazione, però ha un grande valore nelle leggende, nei romanzi e nelle azioni dei depressi e degli esaltati o degli amanti. Perché proprio la mezzanotte e non le tre o le undici? Per la posizione astronomica o perché il suo nome è potente? Comunque anch’io mi accorgo che volentieri proprio a mezzanotte esco spesso nella città della laguna, Venezia, specialmente quando a mezzanotte scende la nebbia; la percepisco prima di tutto nel suo odore, poi nel suo silenzio. La casa è sul rio, e a mezzanotte misuro l’altezza dell’acqua che proprio allora raggiunge il culmine per poi defluire con la marea che si abbassa e si spegne e si allontana come la mezzanotte. Il silenzio. E le case hanno gli scuri chiusi ma non del tutto, gli scuri terminano in alto in una specie di figura rotonda, sembra una testa, che lascia passare la luce degli interni. Cammino sui «masegni» velati dall’umidità, ci si incontra al passo, ci si saluta, in pochi, si attraversano le «sconte», le piccole calli che solo gli abitanti di questa città acquatica seguono per i percorsi piú veloci, l’unica città al mondo in cui nel camminare, come in tutto il resto, la via piú breve non porta da nessuna parte, perché la città è concepita a partire dall’acqua, dal sistema naturale delle isole raccordate l’una all’altra da ponti. Passo per passo, a mezzanotte, vorrei entrare in tutte le case, ogni casa ha la sua storia di persone che ci hanno vissuto, di ognuna vorrei conoscere le speranze e i sogni che si sono avverati. E poterli raccontare.
![]()
Occorre riconoscere a Trieste, senza fare alcun mito della «triestinità», due primati importanti: quello di aver dato il primo vero scrittore moderno italiano, nella figura e nella persona di Italo Svevo, e quello di aver dato il primo grande non-scrittore italiano, nella figura e nella persona di Roberto Bazlen. Sebbene la nostra predilezione di lettori sia naturalmente per lo scrittore che scrive libri, non dobbiamo sottovalutare l’importanza, soprattutto nella prospettiva del primo Novecento, di chi per fondati motivi e in modo significativo decide di non scriverne. Roberto Bazlen dichiarò fin dall’inizio le sue intenzioni: «Non si possono piú scrivere libri, io scrivo soltanto note a piè di pagina». Se questa rinuncia programmatica avesse dato origine semplicemente a un silenzio, noi non saremmo qui a occuparci di Bazlen; ma poiché tutta la sua vita ruotò attorno al libro – del resto Bazlen, ebreo, apparteneva per nascita al popolo del Libro – e poiché alla scrittura, e in particolare al crinale stretto tra scrittura e vita («un poeta vive e fa bei versi. Ma che brutti sono i versi di un poeta che non vive per fare bei versi»), ha dedicato in fondo tutta la sua energia, dobbiamo pensarlo come un non-scrittore. Attenzione: un non-scrittore, un autentico non-scrittore è raro e prezioso, non pensate che sia un’occasione da buttar via. Se è vero che il nostro narrare, e venire alle parole, è permeato a ogni istante dal silenzio da cui si distacca, un personaggio che avendo tutte le qualità per scrivere decide per convincimento, per vocazione, di astenersi costituisce un punto di negazione, un’antimateria di segno opposto alla materia, ma al pari di essa necessaria e vitale.
Appartenendo a coloro che non hanno mai conosciuto Bazlen, vorrei stabilire con lui un rapporto immaginario. I rapporti immaginari sono piú semplici dei rapporti veri, riducono il conflitto; ma sono anche piú difficili, poiché tutto è affidato alla fantasia e alla memoria (che in questo caso non può essere quella personale). Né vorrei parlare di me, e per ritardare il piú possibile il momento in cui inevitabilmente dovrò fare almeno qualche accenno, vorrei provare a tratteggiare un personaggio di romanzo, un personaggio che mi piacerebbe narrare, cominciando da alcuni suoi possibili caratteri, per esempio: un personaggio che sia in rapporto con la sostanza delle cose. Il rapporto con la sostanza delle cose, me ne rendo conto, è molto impegnativo e difficile da definire, implica una forma profonda di naturalezza; ora, niente è piú complesso che essere naturali, soprattutto da parte di un personaggio che aveva pensato e scritto «la semplicità è la conquista dei complicati e la complicazione è la conquista dei semplici». Un personaggio in stretto rapporto con la sostanza delle cose è anche, o almeno vorrei che lo fosse, in stretto rapporto con una certa naturalezza dell’essere, esser...