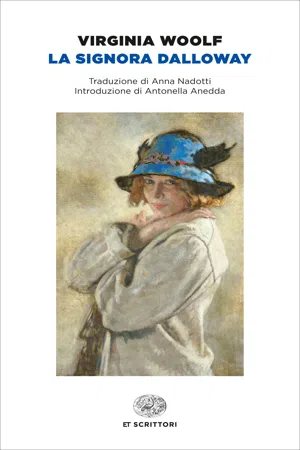![]()
© 2012 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino
In copertina: Sir William Orpen, Il cappello blu, olio su tela. (Foto © Christie’s Images / The Bridgeman Art Library / Archivi Alinari).
Progetto grafico: 46xy.
Questo ebook contiene materiale protetto da copyright e non può essere copiato, riprodotto, trasferito, distribuito, noleggiato, licenziato o trasmesso in pubblico, o utilizzato in alcun altro modo ad eccezione di quanto è stato specificamente autorizzato dall’editore, ai termini e alle condizioni alle quali è stato acquistato o da quanto esplicitamente previsto dalla legge applicabile. Qualsiasi distribuzione o fruizione non autorizzata di questo testo cosí come l’alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti costituisce una violazione dei diritti dell’editore e dell’autore e sarà sanzionata civilmente e penalmente secondo quanto previsto dalla Legge 633/1941 e successive modifiche.
Questo ebook non potrà in alcun modo essere oggetto di scambio, commercio, prestito, rivendita, acquisto rateale o altrimenti diffuso senza il preventivo consenso scritto dell’editore. In caso di consenso, tale ebook non potrà avere alcuna forma diversa da quella in cui l’opera è stata pubblicata e le condizioni incluse alla presente dovranno essere imposte anche al fruitore successivo.
www.einaudi.it
Ebook ISBN 9788858406106
![]()
«Ho fin troppe idee», scrisse Virginia Woolf a proposito di Mrs Dalloway. È il 1925, l’anno in cui insieme al romanzo pubblica la prima serie dei saggi intitolata The Common Reader. Il volume include un testo fondamentale, Mr Bennett and Mrs Brown1 , una delle riflessioni piú profetiche sulla letteratura inglese dopo l’età edoardiana. Attraverso la figura di Mrs Brown, Woolf segnala infatti una serie di cambiamenti nella costruzione di un personaggio e intravede nel vuoto lasciato dalla guerra uno sconvolgimento di cui rende partecipi i suoi lettori: «Tollerate lo spasmodico, l’oscuro, il frammentario, il fallimento… stiamo tremanti sull’orlo di un’altra grandissima epoca di letteratura inglese».
Mrs Dalloway dunque coincide con un mutamento di pensiero e di scrittura, con un’abbondanza di idee che porterà nel giro di dieci anni alla composizione di una serie di capolavori: To the Lighthouse (1927), Orlando (1928), A Room of One’s Own (1929), On Being Ill (1930), e che culminerà nel 1931 con The Waves.
L’abbondanza contempla anche dei consigli. In un altro saggio intitolato Come dobbiamo leggere un libro?, Woolf si rivolge di nuovo a noi e dice: «Non date ordini al vostro scrittore: cercate di diventare lui stesso. Siate il suo compagno di lavoro e il suo complice».
Da lettori comuni ma un po’ indisciplinati proviamo a diventare, piú che l’autore, il suo personaggio. Non è un’immedesimazione lusinghiera. La signora Dalloway non è un’eroina, non è giovane, non è innamorata. È un’agiata ordinary woman di mezz’età. Le notizie che abbiamo su di lei sono contraddittorie: «non sa nulla», «non ha cultura», ma legge Huxley e Tyndall.
È «fredda», «conformista» ma non la scandalizza l’idea di amare un’altra donna. È «dura» ma convinta appunto come Huxley del dovere di «mitigare le sofferenze dei nostri compagni di sventura». A differenza dei personaggi della narrativa precedente non possiamo dedurre nulla sul suo conto a partire dalla casa in cui abita, visto che la sua prima azione è uscirne. Per tutto il romanzo resterà un enigma, un’immagine inafferrabile, cangiante, soggetta a cambi di prospettiva. La sua immagine dipende dai diversi punti di vista2 . Anche i personaggi «secondari» scorrono nelle pagine, sconfinando, cambiando, confondendosi a seconda dei punti di vista. Lettrice di Montaigne a cui dedica uno dei suoi saggi piú belli, Woolf sa che «non c’è nulla di piú vano, vario e ondeggiante dell’essere umano».
A noi lettori comuni non resta che seguire il suono con cui si apre il libro: «La signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comprati lei». Questo attacco, quasi sbadato, sembra continuare un discorso già iniziato altrove. Allo stesso tempo però è l’unica cosa a cui aggrapparsi perché nella sua normalità accoglie anche una nota di allarme. Fin dalle prime pagine l’incanto è venato di pericolo. Il mondo è allegro e il mondo è minaccioso. La paura ha la voce dei versi di Shakespeare dal Cimbelino che rintoccheranno per tutto il romanzo:
Piú non temere la vampa del sole
Né del furioso inverno le tempeste.
Virginia Woolf sa che le molte idee, le troppe idee possono esistere nell’aiuola del foglio solo se trovano un ritmo3.
Ascoltiamo i suoni che tessono la prima pagina e capiremo perché la traduzione di questo romanzo è un atto eroico: «squeak/flap/chill/sharp/yet». Alla traiettoria orizzontale del corpo che va nel mondo s’intreccia quella verticale di una mente che affonda: «affondava come una lama nelle cose, e tuttavia ne restava fuori, a osservare». Non è forse questo il compito di chi traduce? La pagina come luogo d’inabissamento e distacco, il proprio linguaggio come una lama che affonda nel linguaggio dell’altro?
La signora Dalloway è un romanzo sull’irrealtà della realtà, sulla sua continua trasformazione e sulle nostre illusioni di controllare spazio e tempo. Lo spazio è Londra, la stagione è l’estate, il mese è giugno. Il tempo è dalla mattina alla sera. Ma questa unità aristotelica è una nostra invenzione. Il tempo infatti è sbriciolato, tagliato a fette dall’orologio, lo spazio sembra compatto e invece è pieno di varchi e di scaglie. Le tessere della memoria sono incastrate con quelle delle cose e percepite per dettagli senza gerarchia:
Bond Street l’affascinava, Bond Street la mattina presto nella stagione giusta; con le bandiere al vento, i negozi, niente sfarzo, niente luccichii, una sola pezza di tweed nel negozio dove per cinquant’anni suo padre si era comprato i vestiti; qualche collana di perle; salmone su un blocco di ghiaccio.
La complicità richiesta in Come dobbiamo leggere un libro? si è realizzata. Siamo nel traffico, siamo la signora Dalloway. Impossibile resistere. Il ritmo accelera e coincide con lo stupore. Lo sguardo si affila e si fa prensile. La signora Dalloway è una flâneuse, una traduttrice di sinestesie:
E poi, pensò Clarissa Dalloway, che mattina – fresca come se fosse scaturita per dei bambini su una spiaggia.
Che allegria! Che tuffo! Aveva sempre avuto quella sensazione quando, con un sommesso cigolio dei cardini, lo stesso che udiva ora, spalancava le portefinestre a Bourton e si tuffava nell’aria aperta. Quanto era fresca, calma, piú ferma laggiú naturalmente, l’aria di prima mattina; come la carezza di un’onda, il bacio di un’onda, freddo e pungente…
Abbacinati dai pensieri di questa estranea incontriamo i suoi affetti e quasi ipnoticamente li condividiamo seguendo il moto ondoso della loro apparizione. Ecco Peter Walsh, l’antico pretendente, l’innamorato respinto che torna dall’India, ecco sua figlia Elizabeth di diciassette anni, la stessa età che aveva lei ai tempi dell’amore di Peter. Ricordando, la signora Dalloway trasforma lo spazio. E pone a noi lettori una serie di domande. Chi è l’io di queste memorie, esiste davvero, e soprattutto chi corrisponde al nome della signora Richard Clarissa Dalloway?
Ma ora spesso il corpo che abitava (si fermò a guardare un dipinto olandese), questo corpo, con tutte le sue qualità, le sembrava niente – meno di niente. Aveva la bizzarra sensazione di essere invisibile, non vista, non conosciuta; ormai non c’erano piú né matrimonio né figli, ma solo questa stupefacente e piuttosto solenne processione insieme a tutti gli altri, su per Bond Street, questo essere la signora Dalloway, neppure piú Clarissa, solo la moglie di Richard Dalloway.
Nell’introduzione al volume dell’edizione Penguin, Elaine Showalter4 vede in queste riflessioni una critica di Woolf al sistema patriarcale. La signora Dalloway è, infatti, secondo l’uso inglese, la signora Richard (il nome del marito) Dalloway. Esisterebbe dunque solo come moglie, come appendice senza identità.
Tuttavia quando Clarissa prova «la bizzarra sensazione di essere invisibile» credo che parli a nome di tutti, uomini, donne, perché considera noi, e lei per prima, degli spettri. La sua riflessione è ironica. Prende di mira non tanto il patriarcato e la soggezione femminile quanto l’inconsistenza dei nomi, la loro volatilità, il loro essere semplici suoni. Il nostro essere nulla:
E allora che importanza aveva, si chiese, dirigendosi verso Bond Street, che importanza aveva che lei dovesse ineluttabilmente cessare di esistere? Tutto questo sarebbe continuato senza di lei…
La signora Dalloway è un grande romanzo lirico5. Se, come scrive Nadia Fusini in Nomi, la domanda che si pone Virginia Woolf è «come posso conoscere il reale»6, la risposta arriva attraverso una scrittura che «saggia le forze» e le restituisce attraverso un ritmo in cui creature e cose, interno ed esterno sono inseparabili. Non a caso, forse, il romanzo è trattato come un campo cosparso di fiori, e dunque concimato e aperto ora alla vita ora alla morte.
La signora Dalloway è un romanzo sulla perdita. Perdita della giovinezza certo, ma percepita come tale solo per intermittenze e rivelata solo dallo spazio. Se nel traffico della città Clarissa si sente giovane, quando sale nella sua stanza si sente «d’un tratto avvizzita, vecchia, coi seni cadenti». Il letto che non condivide piú col marito è un luogo senza calore dove legge le memorie sulla ritirata di Russia del barone di Marbot, ufficiale dell’esercito napoleonico. Rinuncia, gelo, sconfitta, un letto sempre piú stretto, una candela per metà consumata. Metafore fin troppo chiare del passaggio dall’età fertile alla menopausa. Eppure La signora Dalloway è molto di piú: un romanzo filosofico capace di rivelare tutta la precarietà degli esseri umani trascinati dai fenomeni, feriti dalle circostanze, inermi di fronte alle correnti della sofferenza e della gioia. La perdita non solo di Clarissa, ma di tutti i personaggi è in primo luogo perdita dei propri confini nel mondo, smarrimento di fronte all’evidenza della nostra trascurabilità. Benché o forse proprio perché «she knows nothing», la signora Dalloway, la snob, rivela la nostra insignificanza. Accatasta i pensieri, lascia che la attraversino, non sa nulla, non è nulla, la vita riempie il suo vuoto. Per questo – giustamente – dubita di esistere.
La signora Dalloway è un romanzo sulla dissipazione. Clarissa ci dice che ha mancato, dissipandolo per paura, l’amore. Ha respinto l’eccentrico, infantile Peter Walsh e sposato il ragionevole, leggermente ottuso Richard Dalloway. Su questa scelta Virginia Woolf scrive pagine di lucidità assoluta e di tetro umorismo. L’amore stordisce, modifica il ritmo. Peter avrebbe voluto condividere tutto, non le avrebbe consentito nessuna solitudine. L’avrebbe scalzata da se stessa e ferita: non apre e chiude forse in modo disturbante un coltellino? Inoltre il pericolo della fusione è acquatico, anticipa l’annegamento nell’altro: uomo o fiume.
Anche chi sembrava incarnare la passione, come Sally, l’amica tanto libera da baciare un’altra donna e verso la quale Clarissa aveva provato i sentimenti che normalmente «provano gli uomini», è diventata un’altra, la moglie di un ricco mercante di Manchester. Quando ricompare, al party che conclude il romanzo, chi legge ricorda soltanto l’ombra della sua nudità nel corridoio, l’eco della voce, gli occhi scuri.
Mrs Dalloway viene pubblicato nel 1925. La guerra è finita ma non dimenticata. Appare all’inizio attraverso le figure di due donne: «la signora Foxcroft che ieri sera all’ambasciata si rodeva il cuore perché quel caro ragazzo era stato ucciso» e «Lady Bexborough, che aveva inaugurato una vendita di beneficenza, dicevano, con il telegramma in mano, John, il suo prediletto, ucciso». Per tenere a bada l’inquietudine la signora Dalloway ha bisogno di ripetersi che «è finita, grazie al cielo, finita», che la vita è piú forte con il trionfo dei suoi suoni umani e l’immagine rassicurante «del re e della regina a palazzo».
Come molti vittoriani e post-vittoriani, Virginia Woolf è influenzata da Charles Darwin7. Il nome viene citato in modo incidentale a proposito del libro sulle orchidee della zia di Clarissa, ma è presente nella meravigliosa pagina sul suolo livellato da morti e implicito in uno degli interrogativi del libro. Chi è adatto a sopravvivere? I rapaci? Gli indifferenti? Domande fluttuanti come le lettere che l’aereo (ora innocuo ma pochi anni prima sarebbe stato un mezzo di morte) scrive con il fumo nel cielo e che probabilmente reclamizzano un tipo di caramelle8. La pace, la bellezza, la quotidianità convivono con l’orrore. Per usare le parole di un verso di Elizabeth Bishop, ammiratrice di Charles Darwin, «tutto questo trambusto seguita, orribile ma allegro». Se è vero che l’arte «is a controlled panic»9, la signora Dalloway incarna questo principio, trattiene la paura dentro il suo corpo incrinato dal mal di cuore e ne declina nomi: fear/panic/terror.
La prima guerra mondiale, scrive Joyce Kelley nel saggio «Corrected in Red Ink»: Septimus Warren Smith, the First World War, and the Culture of Erasure10, fu soprattutto una guerra di distanza. I collegamenti tra i soldati al fronte e le loro famiglie furono fin dall’inizio ostacolati. La propaganda impedí che le notizie trapelassero, censurando le lettere e predisponendo cartoline che prevedevano solo poche espressioni autorizzate. I giornali parlavano della guerra in termini eufemistici con un linguaggio romantico e rassicurante. Eppure alcuni soldati, e in particolare poeti-soldati come Wilfred Owen e Siegfried Sassoon11, provarono a dire la verità su una guerra che coinvolgeva i civili e in cui l’uso di nuove armi aveva effetti impossibili da controllare. Uno dei traumi piú diffusi e, contrariamente a quanto pensava Freud, irreversibili, fu lo «shell shock», il trauma da esplosione, seguito molto spesso dal suicidio.
Annunciato dallo scoppio di una macchina che si accosta al marciapiede, entra in scena il personaggio di Septimus, il vero alter ego di Clarissa, l’unico personaggio che non vortica intorno alla sua figura ma le si contrappone.
Septimus Warren Smith12 è un uomo ancora giovane, aveva sognato di diventare poeta, si è arruolato, è sopravvissuto alla guerra ma una volta tornato in patria soffre di allucinazioni, è tormentato dal senso di colpa. Nulla lo tratterrà dal suicidio, né l’amore della giovanissima moglie italiana Rezia, né le cure dei medici.
Nel 1919 esce il film J’accuse di Abel Gance. Diventa subito un cult, fa «furore» come scrivono tutti i giornali dell’epoca e viene proiettato in tutta Europa. È un film durissimo: racconta la vicenda di un giovane poeta, Jean Diaz. Mandato al fronte, assisterà al crollo dei suoi sentimenti di amore e di amicizia, fino a impazzire e a uccidersi gettandosi nel vuoto. In un saggio del 2008, Leslie Kathleen Hankins13 ha giustamente ipotizzato una corrispondenza tra il film e il libro. Anche se non esistono prove che Virginia Woolf abbia visto il film, le somiglianze con il romanzo sono impressionanti. Leggiamo due brani: se non lo sapessimo penseremmo si riferiscano entrambi a Mrs Dalloway, mentre il secondo si riferisce a J’accuse:
un caso di trauma da esplosione – molto triste – che ode in lontananza le voci dei defunti che cantano, e vede nel cielo la propria apoteosi o dannazione. Che guerra spaventosa14!
un poeta giovane e visionario è impazzito a causa delle scene orribili che ha visto nelle trincee, e costantemente immagina di vedere quella processione di eroici defunti15.
Jean Diaz, come Septimus, parla con i morti. Come Diaz, Septimus ha allucinazioni sonore. Il rintoccare dei versi shakespeariani nella Signora Dalloway si collega all’ultimo monologo di Diaz contro il sole accusato di indifferenza. Le stesse sperimentazioni cinematografiche di Gance trovano un controcanto nel linguaggio frantumato di Septimus, nella sua Guernica di parole.
Tra i destini di Clarissa e Septimus si stabilisce, per usare un’immagine di Virginia Woolf, «una transazione segreta». Sul piano della realtà non solo non si incontrano ma non hanno nulla in comune, appartengono ad ambienti diversi, uno è colto, l’altra non sa nulla, uno sente troppo, l’altra troppo poco. Hanno una sola cosa in comune ed è la capacità di vedere la verità. 19 giugno 1923: «I adumbrate here a study of insanity and suicide, – annota Virginia Woolf nel suo diario, – the world seen by the sane and the insane side by side»; e piú tardi, il 16 ottobre: «Suppose it to be connected in this way Sanity and Insanity. Mrs Dalloway seeing the truth. S.S. (Septimus Smith) seeing the insane truth»16 .
Clarissa e Septimus dunque vedono la verità anche se in modi diversi. Septimus la testimonia attraverso corpo e mente. Ansia, terrore, angoscia, perdita della voce, paralisi, balbettio, visioni, impotenza sono solo alcuni dei sintomi che lo porteranno al suicidio. Vive in un mondo estraneo, in una solitudine crescente. Anche la moglie lo considera un egoista che non capisce e la terrorizza.
Solo la signora Dalloway intuisce che per lui il suicidio è «l’unico modo che aveva di preservare la sua integrità». Septimus sognava di diventare poeta, e dopo la guerra rifiuta un linguaggio fatto di metafore, retorica e menzogne.
Virginia Woolf non risparmia la sua ironia verso una cultura e una società che ritenevano una virtú controllare i propri impulsi. Septimus dunque è anche «una tragica figura del sistema di classe, completamente annientato dalla guerra»17. Durante il conflitto aveva imparato a reprimere i suoi sentimenti. Quando il suo amico Evans viene ucciso, Septimus si congratula addirittura con se stesso per aver...