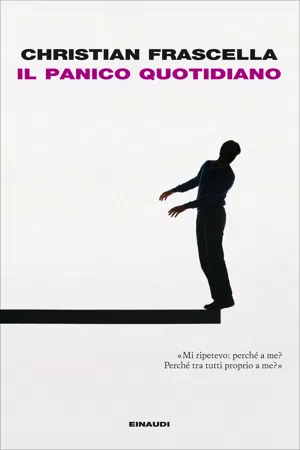![]()
Christian Frascella
Il panico quotidiano
![]()
– Piú pensi di sentirti male... e piú... stai... male.
Travis Bickle in Taxi Driver
![]()
La prima volta che ho avuto una crisi di panico non lo sapevo mica che era una crisi di panico. Non è proprio come la prima volta che fai sesso.
Dov’ero? Cosa stavo facendo?
Ero in fabbrica, turno di notte, quattro del mattino, stava per suonare la sirena della pausa di mezz’ora. Non ero né piú stanco né piú nervoso del solito. Non ero triste – stavo per andare in pausa! E mancavano solo due ore alla fine della nottata lavorativa.
Non ero nemmeno felicissimo – stavo stampando lamiere per automobili a una macchina denominata «trancia». Era la macchina peggiore della linea. Il pezzo arrivava pesantissimo, «imbutito» come si dice in gergo tecnico, dalla prima macchina. Il mio compito era bucarlo, lasciare che gli estrattori lo spingessero verso il nastro trasportatore della terza macchina, l’assestamento, e via cosí. No, non è cosí divertente come sembra.
Un pezzo dopo l’altro, centinaia di pezzi l’ora, avevo cominciato alle dieci di sera. Intanto controllavo la qualità – solo un’occhiatina di prammatica –, fumavo le mie oneste sigarette, pensavo a cose semplici tipo: Con chi gioca domenica il Toro?; oppure: Lucia a casa che fa? Dorme profondamente nel nostro letto o sogna un qualche tipo di sogno che mi riguarda almeno un po’?
Ricordo che il mio amico Mirko mi fece un cenno dalla terza macchina. Io mi piegai per fargli un cenno. Andavamo avanti a cenni, mentre eravamo in linea, ché di chiacchierare non c’era il tempo e nemmeno la forza. Cosa significavano quei cenni? Qualunque cosa l’altro avesse in mente. Magari Mirko intendeva qualcosa tipo: «Rallenta»; e io invece: «Inter di merda» – perché lui era interista. Però erano dialoghi funzionali. Insomma, non sapevamo a cosa accennassimo, ma andava bene. Con lui come con gli altri. Come con Rosario della prima macchina. O Beppe della quarta. Cenni. Magari uno ti mandava affanculo con un movimento della mano, e tu capivi che quella sera aveva scopato, e sorridevi. E piú lui ti mandava affanculo, piú tu sorridevi – una roba assurda a vederla da fuori, ma non c’è modo di spiegarla adesso cosí come non c’era modo di smetterla allora.
Io ripetevo quei cenni da sei anni, ormai. Sui tre turni: 6-14, 14-22 e 22-6, il turno della mia prima crisi, appunto.
Quattro del mattino, dicevo. 27 gennaio del 2001. Certe date proprio non si dimenticano.
Come la data del diploma.
La data del matrimonio.
O la data di nascita del primo pargolo.
Solo che io non sono diplomato, non ho mogli e non mi va di avere figli.
Alcuni colleghi già stavano svitando i panini dal cellophane, già masticavano banane o sbocconcellavano mele – la normale routine appena prima della pausa, insomma.
Non c’erano state avvisaglie? Massí. Un formicolio ai polpacci. Troppe ore in piedi, avevo pensato. Dovrei solo sedermi. Poi ho sentito piovermi in testa la paura. Proprio cosí. Dal nulla. Come se l’orrore gocciolasse sulla mia dura madre, tra i capelli. Un freddo, un brivido lunghissimo ma dentro. Non fuori, dentro, dappertutto dentro di me. Glaciale. Poi di colpo caldissimo.
I pezzi hanno cominciato ad accumularsi sul mio nastro.
Ma io li vedevo e non li vedevo. Cioè: li vedevo, sapevo che c’erano, sapevo dove mi trovavo, sapevo chi stava alla prima macchina e chi alla terza. Sapere, sapevo. Ma tenerlo presente durante quell’implosione era pressoché impossibile. Stavo crollando. Dal fondo, da un pozzo ghiacciato sistemato dentro di me, chissà da quando, ho avvertito risalirmi in petto, in gola, la paura ancestrale della morte. Ho sentito – in ogni poro, in ogni atomo –, ho sentito che sarei morto. Lí. Subito.
Ho provato a gridare, ma non ce l’ho fatta. Ciò che era risalito si era raggrumato come cemento a schiacciare la lingua, a togliermi il fiato. Ho provato a voltare la testa, a guardare i miei colleghi: individuavo soltanto il luccichio delle lamiere sul mio nastro trasportatore, e alcuni pezzi che già cadevano.
Ero muto, sordo, cieco, semiparalizzato. Ho pensato che era la fine. Un attacco di cuore, un ictus, una congestione fulminante, una crisi epilettica, un malore che mi stroncava giovane, ventisette anni, operaio, di notte, in fabbrica, come si legge a volte sui giornali, come dicono in Tv: ancora ignote le cause del decesso. Il sostituto procuratore ha avviato le indagini, ma rimanda tutto all’autopsia, che si svolgerà eccetera.
– Ehi, – ha detto Rosario. – Che cazzo succede? – Allora non ero sordo. Allora forse potevo anche parlare.
La lingua mi si è scollata dai denti, la palla di cemento è riscivolata in corpo: – Rosario mi sento male aiuto chiama un’ambulanza chiama Lucia chiama aiuto Rosario aiuto.
E poi eccola – nera, ombra guizzante, la morte.
Ho gridato, anche se non lo ricordo. Ho gridato, mi ha poi detto Mirko, come se mi stessero castrando a freddo. Una frase che non mi è piú uscita dalla testa, quando me l’ha riferita. Castrando a freddo. Perché, che differenza fa se ti castrano a caldo?
Comunque ho gridato, il soffitto della fabbrica è diventato immenso, scuro, distante. Sono crollato a terra. Svenuto. Non morto, eh. Svenuto.
Mi avevano sistemato su uno dei tavoli della mensa. Ce li avevo tutti attorno, quando mi svegliai. Piero, il capoturno, si chinò su di me. – Allora? – La sua faccia scavata di sonno e preoccupazione, il collo taurino nel camice nero.
– Che m’è successo? – articolavo male le parole, quasi le sbavavo.
Mirko, che stava all’altezza del mio gomito, disse quella cosa della castrazione a freddo.
Rosario mi mise una mano sulla fronte. – Non ce n’è, febbre.
Non me la sentivo, infatti. Non sentivo niente. E sentivo tutto. Troppo, a ondate.
Il respiro degli altri operai. Un parlottio. Piero chiese: – Hai fumato qualcosa, Chri?
– Sigarette.
– E basta?
– Basta, sí.
Carlo, che era il pusher della fabbrica (pure i capi lo sapevano, ma non dicevano niente), da dietro le spalle del capoturno disse: – Che io sappia, non ha fumato –. E se non lo sapeva lui...
– Vuoi andare a casa?
Cosa volevo?
Mi misi seduto, con circospezione. Si scansarono un po’. Ma guarda, pensai. Ragazzi e vecchi attorno a me, stanchi, coi panini e le bottiglie d’acqua in mano, che non sanno cosa fare. Gli sto rovinando l’unica mezz’ora decente del turno.
– Sto bene, – feci. Però mi risdraiai.
Uno degli anziani annuí. – Si vede, – disse, e diede un morso al suo panino.
– Sto meglio.
– Magari hai un po’ di fame. Hai mangiato ieri sera?
– O qualcosa gli ha fatto male...
– O si fa troppe seghe.
Risata generale distensiva.
Tornai a guardarli.
Le facce nella smorta luce della saletta mensa. Nasi, orecchie, occhi spiritati, labbra curve, capelli unti, giacche unte, mani unte.
E mi prese un brivido: dalle gambe alla testa, mi fece arcuare, come se il tavolo ardesse sulla schiena, e poi al contrario: la schiena sul tavolo, gambe e mani e testa in alto. – Sto morendo! – dissi.
– Chri! – Rosario mi afferrò le gambe, Mirko la testa.
Una folata di terrore fluttuò nelle ossa, risalí, ridiscese: ero una strada, le emozioni mi attraversavano in entrambi i sensi come veicoli. – Lasciatemi lasciatemi lasciatemi... – E fu di nuovo buio.
Non so se vi siate mai risvegliati in un’ambulanza. Non so se, nel caso, abbiate incontrato gli occhi consumati di un infermiere che, sbadigliando, controlla voi e, con molta flemma, la flebo che vi ha piantato nel braccio. Non so se abbiate mai goduto, da sdraiati, del piacevolissimo avanzare nella notte di un mezzo che vi trasporta da un posto all’altro, senza ricordarvi dov’eravate prima di stramazzare svenuti per la seconda volta in poco tempo né sapere in quale ospedale della città siete diretti.
Be’, vi assicuro che non sarebbe poi tutto questo granché se non entrassero in gioco le benzodiazepine. In questo caso, l’Imperatore Valium. Che mi stava fluendo nel sangue da qualche minuto, e già una serenità da abbraccio materno e caldo s’impadroniva di me. Come un maglione quando stai in terrazza e si è appena alzato il vento.
– Ti sei ripreso? – chiese una voce alla mia sinistra. Mi venne da sorridere. Cos’è tutto questo piacere diffuso, questo senso primordiale uterino di grazia?, pensai.
Voltai il capo e ci trovai Rosario.
Mi piacque annuirgli.
Mi piacque rivolgergli quel sorriso.
Non sapevo niente del Valium fino a quel momento. Quale nettare fosse, quale bacio zuccherino depositasse sulle labbra. Un morbido sfiorare, un guanto di velluto sulle palpebre.
All’ospedale mi chiesero che cosa fosse successo. Me lo chiese un dottore che aveva un segno fresco sul viso, verticale, che gli tagliava la guancia destra: il segno di un lenzuolo o della federa del cuscino. Stava dormendo, ovvio, quando eravamo arrivati.
Nella sala d’aspetto non c’era nessuno. Mi avevano sistemato su una sedia a rotelle, e Rosario mi aveva spinto per un po’, dopo l’aveva sostituito un’infermiera giovane, i capelli gialli piú che biondi riuniti in una coda lunga. Rosario mi aveva salutato, aveva detto: «Aspetto qui», nonostante l’avessi pregato di tornarsene a casa, di andare a dormire. Ma non ne aveva voluto sapere.
Nella saletta ambulatoriale l’infermiera mi aveva fatto sdraiare su una barella, mi aveva misurato la pressione. «Tutto okay», era stato il suo responso.
Dopo un’attesa nella quale stavo per addormentarmi, arrivò il medico, un sorrisino sulla faccia glabra, quel segno in viso. Si sedette dietro la scrivania ingombra di fogli e cartelle e digitò sulla tastiera di un pc malandato.
– Nome? – chiese.
– Christian Frascella.
– Età?
– Ventisette anni.
– Dove vive?
– Zona Barriera.
Annuí, senza mollare lo sguardo dal monitor. – Mi racconti cos’è successo.
– Stavo benissimo poi sono stato malissimo, nel giro di un minuto o due.
– Che tipo di male?
– Del tipo che mi ha fatto svenire.
– Le era già successo?
– Macché, no, che cavolo. No.
– Sta vivendo un periodo particolare?
– In che senso?
– È particolarmente stressato per qualche motivo?
– No. Ero in fabbrica.
– Le piace il suo lavoro?
– Piú o meno, – feci. – A lei?
Mi guardò un attimo. Per fortuna non aggiunse: «Qui le domande le faccio io», come il piú consumato degli sbirri nei film americani. Ma, l’avesse fatto, non me la sarei nemmeno presa: il Valium mi teneva buono, molle, vigile appena da stare sveglio. Pensai che non sarebbe stato male, da quel momento fino alla fine dei miei giorni, imbottirmi di pillole o stantuffarmi in vena quel prodotto miracoloso. M’avrebbero potuto assumere come testimonial, spedirmi in giro di città in città, io sempre sorridente e sereno, le movenze quiete, nessuna traccia di disperazione dentro e fuori.
– Direi che si è trattata di una crisi di panico, – disse il dottore dopo un po’.
– Crisi di panico? – Da quello che ne sapevo, era una roba da signore frustrate in menopausa. Che c’entrava con me, maschio sano nel pieno del vigore?
– I sintomi sono quelli –. Alzò le spalle.
– Ma neanche per idea! – protestai. Il panico. A me? – Magari qualcosa mi ha fatto male. Sto incubando un’influenza, sono stanco, robe cosí.
Mi osservò, il segno verticale andava scomparendo. – Posso sbagliarmi, certo, – acconsentí senza troppa convinzione.
– Sarà stato qualcosa di... organico, – insistetti. – Mi faccia fare delle analisi, dottore –. Dottore!
– No, stia tranquillo –. La stampante accanto al pc prese a fare un chiasso dell’anima, mentre sputava fuori un foglio. – Due svenimenti, respirazione corta, paura immotivata... direi che non ce n’è bisogno. Si è trattato di una crisi isolata. Provocata dallo stress –. Sfilò il foglio dalla stampante. – Stia a riposo qualche giorno –. Rilesse, firmò con uno svolazzo, mi passò il foglio. Si alzò.
Diedi una letta veloce. I miei dati, il trattamento col Valium, e la diagnosi: «Sindrome Ansiosa». Tutto lí. – Mi faccia fare un controllo, una TAC, qualcosa.
Mi tese la mano, io la guardai soltanto. – Stia a riposo, – concluse, e se ne andò da dove era arrivato, nella stanza dove si andavano a riposare i luminari della scienza tra una diagnosi sbagliata e un’altra.
L’infermiera coi capelli gialli risbucò da chissà dove. Mi sfilò con delicatezza l’ago della flebo – il liquido all’interno si era praticamente dimezzato. – La accompagno fuori.
Mi alzai da quella cavolo di carrozzella. – Ce la faccio da solo! – Ma, una volta in piedi, mi presero le vertigini, un brivido freddo mi risalí lungo la schiena, le gambe s’ammosciarono sotto il peso delle mie intenzioni. Ricaddi sulla carrozzella. Mi spinse.
Fuori non vidi Rosario.
Vidi Lucia. Il cappottino aperto, la sciarpa allentata, il viso tirato sotto il biondo morbido dei suoi capelli a caschetto – mi guardò sulla carrozzella e s’irrigidí, fino a quando l’infermiera non mi parcheggiò in mezzo alla sala d’aspetto vuota e sparí. Ricambiai il suo sguardo, mi alzai con fatica solo per accomodarmi accanto a lei.
Che finalmente parlò: – Che ti è successo, Chri?
Era bello sentire il mio nome pronunciato dalle sue labbra. Persino con quel tono apprensivo.
– Un capogiro.
Mi guardò il braccio, con la manica del magl...