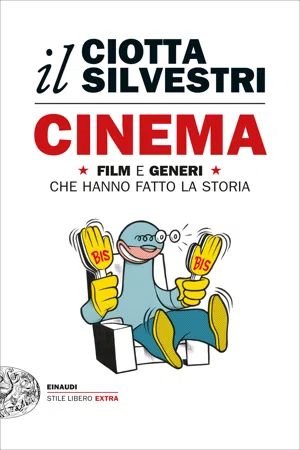
- 1,320 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile sull'app)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Il Ciotta-Silvestri blog si trova qui. *** La prima guida all'uso personale del cinema. Di tutto il cinema. Da quello mai visto o dimenticato al grande successo planetario. Da Hollywood a Dakar, da Hong Kong a Cinecittà, di serie A e di serie Z, in nitrato d'argento o digitale. Una mappa geografica ed emozionale del cinema, suddivisa per generi. ° Cartoon
° Cinema autonomo
° Commedia
° Cult
° De-generato
° Documentario
° Drammatico-Biografico
° Epico-Storico
° Fantascienza-Fantasy
° Giallo-Noir
° Guerra
° Horror
° Melodramma
° Musica(l)
° Muto
° Teenager
° Western
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Base e Completo
- Base è ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un’ampia varietà di argomenti. Accedi alla Biblioteca Base con oltre 800.000 titoli affidabili e best-seller in business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce Read Aloud standard.
- Completo: Perfetto per studenti avanzati e ricercatori che necessitano di accesso completo e senza restrizioni. Sblocca oltre 1,4 milioni di libri in centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specializzati. Il piano Completo include anche funzionalità avanzate come Premium Read Aloud e Research Assistant.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi usare l’app Perlego sia su dispositivi iOS che Android per leggere in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo — anche offline. Perfetta per i tragitti o quando sei in movimento.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Sì, puoi accedere a Cinema di Mariuccia Ciotta,Roberto Silvestri in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Print ISBN
9788806190903eBook ISBN
9788858406533DRAMMATICO-BIOGRAFICO

Walt Kowalski, veterano di Corea, non sopporta di avere per vicini degli asiatici, in Gran Torino (2008), di Clint Eastwood.
© Warner Bros./The Kobal Collection.
Trailer
Se non c’è troppa suspence. Se non si inseguono estasianti geometrie coreografiche e musicali. Se non ci si concentra su un omicidio o un altro fatto cruento, o su un complicato mistero da sciogliere. Se la sostanza esotica o l’ingresso in un mondo alieno non è predominante. Se la lacerazione tragica può non avvenire o non traumatizzare, ma il film è capace di muovere lo spettatore verso stadi emozionali intensi ma differenti, perché c’è un conflitto in corso da equilibrare, un’ingiustizia da sanare, una situazione che diventerà nell’happy end molto istruttiva e eticamente edificante e che insomma rischierà, ma solo rischierà, di renderci completamente pazzi. E se, meglio ancora, si tratta di immedesimarci in vite fuori dall’ordinario, in biografie di uomini eccezionali capaci di imprese straordinarie (è stato il grande sogno rooseveltiano di William Dieterle, e lo avrebbe ripreso Roberto Rossellini in Italia negli anni sessanta, quello di realizzare film didattici seri, alfabetizzando il grande pubblico senza mistificare la storia dei «grandi», in biopic come Zola, Pasteur, Juarez, Reuter, Ludwig, il dottor Ehrlich…) ecco che ci troviamo davanti allo scaffale «film drammatici», al «dramma drammatico» cosí come è stato codificato e embedded, però, dal rigidissimo codice Hays che autoregolò per trent’anni fino a Kennedy l’industria cinematografica statunitense. Mettendo per tre decenni l’autobavaglio alle majors (Warner Brothers, Mgm, 20th Century Fox, Paramount e Columbia) e alle quasi majors (Rko, Universal e United Artists) e controllando le nostre pulsioni di spettatori planetari, dividendole tra lecite e illecite, sovversive o equilibrate, trattenendo in zona off e dark il non consentito, mettendo al bando le scene esplicite di rivolta sociale, d’amore eterosessuale, perfino tra coppie regolarmente sposate, figuriamoci quello omosessuale, il crimine impunito, la droga al lavoro…
Forse fu patriarcale e sciovinista, e a lungo razzista, quel codice, cosí autoautoritario, ma nei limiti di un processo di equilibrio federale tra oscurantismi e progressismi statuali, cui contribuirono i piú aguzzi cervelli europei della diaspora antinazista e antifascista. Cinema grande e in progress perché mai terragno, localizzato, territorializzato, anzi in tensione perenne verso il «fuori di sé», come esige il mercato planetario, tra differenza e ripetizione, continuità e variazione, esperienza della narrazione familiare e incremento del tasso innovativo e spregiudicato. La centralità poi, nella cultura Usa, dell’individualismo democratico, di una democrazia in movimento, vista come fluxus sempre in divenire, ma fondata su regole riconosciute, mai blindate da formalismi bizantini, rende piú aperto, innovativo, «produttivo» e contraddittorio quel codice, sia rispetto alla società civile interna (per larghe fette ancora palesemente razzista, omofobica e integralista religiosa), che al controllo dei generi cinematografici attuato dalle dittature europee, cosí ossessionate dalla volontà di disintegrare l’io nella famiglia, nella comunità, nella nazione, nello Stato (a volte perfino in quello operaio) da condurre a progetti coloniali e (social)imperiali o perfino ai deliri razziali interni. E poi non era proprio impossibile da erodere dall’interno, da attraversare criticamente o satiricamente, e da astutamente eludere, quel sistema di regole, che l’Europa – tranne la Gran Bretagna (dove andò a lavorare l’attore e star nera americana Paul Robeson, irritato dal razzismo hollywoodiano) – peggiorò. Prima e dopo, nell’epoca pre codice e nel post classicismo hollywoodiano aperto dal dramma metropolitano di Otto Preminger L’uomo dal braccio d’oro (1955), certificato 17011 del Mpaa (The Motion Picture Association of America), dopo un duro scontro a proposito dei duetti tra Frank Sinatra e l’eroina (dall’anno successivo ai film Usa furono permesse le scene con droga, i rapimenti, l’aborto e la prostituzione esplicita), la familiarità del codice narrativo è utilizzata non per rassicurare ma per sconcertare e perfino frustrare le attese. Prima del 1932 e dopo il 1954 il genere drammatico fu attraversato da messe in discussioni pesanti dell’ordine, anche simbolico, costituito. Non pensiamo solamente al dramma etico-politico, etnico (non solo black o yiddish), ai film di gang o sulla droga, ma anche al dramma femminista, legato alle lotte delle suffragette, che prima della grande guerra imposero un modello di donna lontana dalla schiavitú domestica e dalla spoliticizzazione obbligatoria, finalmente «persona» a tutto tondo, pienamente consapevole delle sue responsabilità sociali e della sua forza «privata». E spesso egemone. Soltanto durante la seconda guerra mondiale e grazie all’obbligo di incoraggiare le donne a lavorare sostituendo completamente gli uomini in ogni funzione le donne tornarono «pericolosamente» al centro inquieto dell’immaginario. L’intera stagione del noir ci mostra come fosse temuta questa escalation sociale e come dovesse essere fermata, quella criminalizzata femme fatale, con ogni mezzo necessario. Gli anni cinquanta della guerra fredda, dell’opulenza e del ritorno forzato ai fornelli e ai grembiuli coincisero con melodrammi e commedie romantiche che si concludevano inevitabilmente con la riaffermazione dell’ordine sociale e della sottomissione della moglie al marito (mentre esplodeva nei drive-in l’incandescente teenager-movie). Tranne nascondendosi nei meló di Douglas Sirk, dove quella riaffermazione era pesantemente ironica, contrassegnata da evidenti «colori di guerra» pronti a esplodere a Berkeley nel 1964 (e in Italia percorse la stessa via profetica Raffaello Matarazzo). Ma questo è un altro genere.
Affliction
Paul Schrader, Usa 1997
Affliction, tratto dal romanzo di Russell Banks, è lo spazio gelato, la brutalità del paesaggio del Nord (New Hampshire, ma il set è canadese), il silenzio immobile, il cielo che cade sulle distese di neve… Il film di Paul Schrader fa subito pensare ai confini del mondo, soprattutto morale, di Atom Egoyan (Il dolce domani, da un altro testo di Banks). Padre, ancora padre. Il maschio wasp che domina i ricordi di bambini vecchi o in culla, che si ripete e genera mostri. Se in molti film del periodo emerge rigenerato un padre nuovo, decostruito nel suo machismo, nei film tratti da Banks è una divinità malvagia. Metafora di un’intera civiltà che si perpetua nel suo nome, e che qui prende l’aspetto apocalittico, virato nel blu di memorie infantili. Schrader gioca come sempre con i generi, e torna in pole position sui giovani cineasti, che ricominciano dal disfacimento dei generi, dall’ultimo canto di Hollywood anni sessanta.
Il «giallo» è la chiave di Affliction, lo era anche di American Gigolo e di Hardcore. Qualcuno forse ha ucciso un uomo, boss del sindacato, mentre se la spassava nel weekend a caccia di cervi. E il poliziotto-vigile locale, Wade Whitehouse (Nick Nolte), un tipo che cade a pezzi, ex bimbo picchiato da Pop, il padre (James Coburn), sospetta tutti, in particolare il giovane collega, guida per cacciatori dilettanti. Primo film. Secondo film, che s’interseca nell’altro e lo scardina come un documentario-sermone calvinista (Schrader) e segue la caduta del nostro eroe, Wade-Nolte, al massimo dell’interpretazione insieme a Coburn e a Willem Dafoe nella parte del fratello fuggito dalla casa paterna, voce narrante che spiega come mai un «uomo normale» può impazzire, Wade, padre frustrato e fallito di una bimba scorbutica che preferisce la mamma, la ex moglie «perbene», anche nella magica notte di Halloween. Ecco gli orrori della Twin Peaks delle nevi, dove vagano anime in pena, afflitte da una storia di cui ci si può liberare solo a colpi di fucile, o bruciando il proprio genitore in un falò infernale.
Estenuante e duro, dark e torbido, Affliction non fa pubblicità all’America, sprofondata in «acque profonde» come dice Banks. Vittime del «totem» capofamiglia, l’alcolizzato Pop, una madre succube, avvelenata dal gas di una stufa difettosa, vita sprecata in vana difesa dei figli, e un altro «fantasma», Sissy Spacek, scelta non a caso come «fidanzata» di Nick Nolte, lei rappresentante della New Hollywood. Ma, ancora, e soprattutto, sono i bambini, la bimba imbronciata «sosia» di quella di Egoyan, i perseguitati e grandi accusatori. La generazione futura che promette l’apocalisse, e una estrema ribellione alla legge paterna. (m.c.)
L’agronomo / The Agronomist
Jonathan Demme, Usa 2003
Haiti, «nuovo territorio» ma non per Jonathan Demme che ha un’antica liaison con l’isola, con i suoi artisti, musicisti e cineasti e con i Dreams of Democracy, sogni di democrazia (titolo di un documentario di Patricia Benoit che Demme ha prodotto nel 1987) di un popolo tra i piú derubati e sfruttati della terra. Clinica Estetico, la compagnia di Demme, questa volta racconta la storia di un amico intimo, attivista di Amnesty International e tante altre cose. Di un eroe del microfono e della resistenza, Jean Dominique, L’agronomo. Un racconto in «diretta» dalla stazione radiofonica Radio Haiti Inter, postazione privilegiata dell’attivista politico della sinistra che ha attraversato dal 1968 al 2000, fino all’assassinio di Dominique, rivoluzioni e repressioni, colpi di stato militari, invasioni, insurrezioni, feste voodoo, tutto scritto sulla facciata dell’edificio smitragliato di colpi d’arma da fuoco. Colpi registrati da Jean, soundtrack da mischiare all’allegra sigla dell’emittente, temibile per ogni regime e dove la lingua francese dell’élite – le dieci potenti famiglie che hanno sequestrato economicamente e politicamente l’isola da due secoli – è stata sostituita con il creolo-haitiano dei contadini e degli operai della canna da zucchero, ora poco piú di centomila persone, ma nel 1804 il nucleo dell’esercito di schiavi, già proletariamente cosciente e unificato, guidato da Toussaint Louverture che sbriciolò militarmente le truppe coloniali di Napoleone, purificò da ogni sfumatura razzista il concetto rivoluzionario di «uguaglianza, libertà, fraternità», tenne alla larga per qualche anno spagnoli e inglesi, e fondò la prima repubblica «all black» indipendente. Cinquant’anni prima dell’Italia.
Una storia raccolta dal regista del Silenzio degli innocenti per rendere omaggio a un grande popolo dalla straordinaria cultura e a un amico. E per raccontare di come la democrazia si accendeva a Haiti e si spegneva a fasi alterne in relazione all’America di Carter e di Clinton o dei cowboys che precedettero Roosevelt e dominarono poi gli anni ottanta, Reagan-Bush, scatenanti i plotoni assassini dei Ton Ton Macute dei loro pupazzi, Papà e «Baby» Doc, i Duvalier. Jean Dominique ha una faccia forte sagomata in un sorriso ruggente, sarebbe un attore perfetto per recitare nella parte di se stesso.
Non a caso assomiglia a Jean-Louis Barrault, piú che un interprete, una furia umana dalle good vibrations. Il giornalista di Radio Haiti parla a Jonathan Demme, che lo avvicinò quand’era in esilio a New York, in un intermezzo tra un colpo di stato e l’altro. Quando Carter smise di appoggiare Papa Doc – che forse aveva perduto il contatto con il popolo e l’amore strumentale per il voodoo – i microfoni di Jean ripresero a strillare le news, ma le interferenze si moltiplicarono di anno in anno. Arrivò il figlio del dittatore nero per governare una borghesia creola, piú che bianca, e dopo di lui i marines a mettere ordine e poi di nuovo colpo di stato. Radio muta, Jean Dominique in esilio.
La lunga intervista di Demme è frammentata da immagini dell’epoca, ma anche dai primi film di produzione haitiana, che Dominique, fondatore dell’unico cineclub, aveva stimolato: dal mitico documentario di Arnold Antonin (anche intervistato), un pamphlet anti-imperialista del 1973 che tanto piacque a Graham Greene, fino al mediometraggio fiction Anita, di Rassoul Labouchin (1984) che fu scoperto in Occidente dalla Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro. E il film sale inquietante, pieno di suspence, sostenuto da un colonna sonora incalzante (Demme ha prodotto anche un disco dei Frères Parents negli anni ottanta), vibrante nelle parole scandite come in un balletto vocale del cronista, innamorato, supporter e poi deluso da Jean-Bertrand Aristide.
Riportato alla guida di Haiti da Clinton, il primo presidente votato dal popolo, scende a compromessi con i rappresentanti della vecchia dittatura e con i latifondisti contro i contadini, schierati contro l’importazione massiccia di etanolo, che sostituisce la canna da zucchero nelle bevande alcoliche. Finché sarà anche lui ostaggio degli uomini forti del suo partito che decreteranno alcuni anni fa l’uccisione di Dominique (ma ci sono dubbi sulle vere responsabilità dell’omicidio), mai concepita neppure dai feroci Duvalier. Che però non spegne la radio, oggi animata con ancora piú forza dalla moglie e dalla famiglia dell’«agronomo» passato alla radio perché rendere ricca l’agricoltura di un paese dalla terra fertilissima è un crimine che le multinazionali puniscono ancor piú velocemente e ferocemente. (m.c.)
L’amore molesto
Mario Martone, Italia 1998
«I capelli erano lunghi. Amalia non finiva mai di scioglierli e per lavarli non bastava il sapone… Sospettavo che a volte mia madre, sfuggendo alla mia sorveglianza, li andasse a immergere direttamente nel bidone, col consenso dell’uomo della bottega. Poi si girava allegramente verso di me con la faccia bagnata, l’acqua che le scrosciava sulla nuca dal rubinetto di casa, le ciglia e le pupille nere, le sopracciglia tracciate a carbonella, appena ingrigite dalla schiuma che, ad arco sulla fronte, si rompeva in gocce d’acqua e sapone. Le gocce le scivolavano giú per il naso, verso la bocca, finché lei le catturava con la lingua rossa e mi pareva che dicesse: buone». Sembra il ritratto di un amante, il racconto sensuale di un osservatore pervaso di desiderio nell’osservare carne, capelli, labbra umidi e lucenti. Invece sono le parole di una figlia, Delia, scritte da Elena Ferrante nel romanzo L’amore molesto, che è diventato il film di Mario Martone (in concorso a Cannes).
Un film italiano con una mamma senza grembiule e spaghetti. Inedita immagine, che immerge le bellissime visioni di Martone in un languido flusso nostalgico. Napoli s’incanta intorno a questo corpo evocato dalla figlia sulle tracce di un nome perduto, Amalia. Una donna che ha calamitato mille sguardi maschili, vittima di molestie d’amore da parte del marito, del presunto amante, del fratello, dei passanti, sotto il tunnel buio dove mani si protendevano a toccarla. E della figlia, che ha vissuto per quarant’anni e piú disgiunta dal suo stesso desiderio. Spia di reati sessuali mai commessi.
Martone, nel film, materializza l’indicibile attrazione «innaturale» che trasuda nelle pagine di Ferrante. È un mix di sgradevole sospetto quello che attraversa il romanzo, una morbosa identificazione tra Delia e la madre. Quasi un autoerotismo. Delia annusa le mutande rosse della mamma morta, le prova, le accarezza, le scopre dovunque. L’indumento è un leitmotif, un indizio. Incesto virtuale, ma di segno sconvolgente. Delia alla fine dirà «Mi chiamo Amalia», e ritrova se stessa bambina, a scimmiottare la desiderata e bella signora che non poteva sorridere senza ricevere uno schiaffo dal marito. Ritrova quell’universo apartheid nell’Italia degli anni cinquanta, e oltre. Il non-detto di un mondo complice e machista, cresciuto sordidamente sullo sfruttamento di corpi posseduti e venduti, come la Zingara dipinta nuda dal padre di Delia a immagine di Amalia. Tele offerte ai militari americani, che commentavano il corpo riprodotto di una donna resa adultera dal marito. È questa Italia da dimenticare e che invece incombe ancora la «mamma» di Ferrante e Martone. Quell’erotismo scandaloso di Delia verso la madre sembra allora un violento atto di possesso. Un risarcimento. Una vittoria. Quando, appunto, Delia sorride ai militari sul treno e dice «Mi chiamo Amalia». (m.c.)
Amores perros
Alejandro González Iñárritu, Messico 2000
Bellissimo, affascinante, inquinatissimo. Com’è Mexico City. Chi ama le immagini di Nanni Moretti, può essere puritanamente attratto anche dal suo antidoto, la barocca, violenta, tecnologica tempesta delle pulsioni post-umane che si scatenano in ogni centimetro quadrato di questo film a grandissimo schermo. Si intitola Amores perros e incredibilmente gironzola nelle sale italiane. Va visto. Anche se, purtroppo è stato doppiato.
Scoperto dalla Settimana della critica di Cannes 2000 e lanciato, attraverso una lunga sequenza di festival (Edimburgo, Tokyo, Chicago, L’Avana…) nell’olimpo mondiale, fino a un non improbabile premio Oscar (è nella cinquina finale e se La tigre e il dragone farà il gran salto…), questo impietoso e duro spaccato metropolitano non lascerà indifferente il pubblico, sia quello soft (che gode anche dei suoi piaceri proibiti) che hard. Inoltre per il mercato italiano segna il grande ritorno di una cinematografia da troppo tempo (dagli instant-action di René Cardona jr) invisibile. 36 stesure di sceneggiatura, tre anni di lavoro per Guillermo Arriaga, il film è di quelli che fanno passare attraverso la telecamera mossa e nervosa (già, è digitale il lavoro di Rodrigo Priesto) l’odore e il sapore di questo ennesimo attraversamento del dolore che contraddistingue tanto cinema contemporaneo.
Film d’esordio, con una dilatazione dei tempi e delle ambizioni rimediabile, Amores perros (amore canino) è diretto da Alejandro González Iñárritu, 38 anni, e acquistato con intuito e perfetta scelta di tempo dal Luce. Il film possiede una inusuale forza bruta e la sua originalità non è né fasulla né studiata. L’ex dj della principale radio rock di Mexico City, la Wfm, con esperienze pubblicitarie e studi a Los Angeles, sostiene artificialmente in vita – ma non è l’unico soundtrack a farlo – tramite eccitanti ed estasian...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Cinema
- La trappola di luce vellutata - di Mariuccia Ciotta e Roberto Silvestri
- Cinema
- Cartoon
- Cinema autonomo
- Commedia
- Cult
- De-generato
- Documentario
- Drammatico-Biografico
- Epico-Storico
- Fantascienza-Fantasy
- Giallo-Noir
- Guerra
- Horror
- Melodramma
- Musica(l)
- Muto
- Teenager
- Western
- Copyright